Nel 1997, a Lucca, durante un esame paleopatologico su un corpo riesumato si scopre un delitto perfetto avvenuto due secoli prima.
Benvenuto, benvenuta
nell'archivio del Cavalier Serpente. A questo punto puoi sbizzarrirti e andare indietro nel tempo (anche di anni). Gli articoli sono elencati in ordine cronologico al contrario: dal più fresco al più stantio.
N° 644 - Microbiografie Irrispettose - Charles Ives 1874 - 1954

Charles Ives è un uomo d’affari americano. Nasce a Danbury, nel Connecticut ed entra presto nel mondo delle assicurazioni sulla vita con una propria compagnia, la Ives & Myrick, con sede a New York, che gli permette di vivere agiatamente. Acquista fama e rispetto nel suo ambiente di lavoro con la pubblicazione del trattato: “L’Assicurazione sulla vita in relazione all’imposta di successione”.
Finché nel 1930, con un bel gruzzolo in tasca e dopo una serie di presunti “attacchi di cuore”, come li chiamavano in famiglia, anche se non si è mai saputo se fossero in realtà semplici palpitazioni di origine psicologica, decide di ritirarsi dagli affari e muore di un colpo apoplettico, questa volta vero, nel 1954.

Un assicuratore? Ci dev’essere un equivoco. Ricominciamo.
Charles Ives è un musicista americano, il primo compositore USA a raggiungere una vera noto-rietà internazionale. Ma attenzione, lui non ne sarà mai proprio del tutto consapevole perché questa notizia diventa pubblica solo dopo che è morto del famoso colpo apoplettico nel 1954.
Nasce a Danbury, nel Connecticut, figlio del direttore della banda locale, il quale lo avvia pre-sto allo studio della musica. A dodici anni suona il tamburo sotto la bacchetta di papà, l’anno dopo è organista nella chiesa battista poi va a studiare composizione a Yale; un percorso veloce.
Parentesi: giovane dai molti talenti, alcuni dei quali inaspettati, emerge come atleta della squa-dra di football americano di Yale, ed è così apprezzato dal suo allenatore da fargli dire: “E’ un vero peccato che perda tanto tempo a strimpellare la sua musica: potrebbe diventare un grande attaccan-te”.
Quasi subito (bisogna dire, incoraggiato da suo padre) si rende conto di essere istintivamente troppo all’avanguardia per andare d’accordo con l’impostazione musicale americana dell’epoca e al-lora decide di rinunciare a una dichiarata professione artistica e si butta in una doppia vita: pubblica come assicuratore, clandestina come musicista.
Naturalmente, visto che si nasconde, critici e potenziali ammiratori non si accorgono nemmeno della sua esistenza, mentre lui continua a comporre furiosamente (nei momenti liberi dall’assicurazione) musica sperimentale, poliritmica, politonale, difficile, neanche pubblicata, quindi non eseguita da nessuno.
D’altra parte detesta che definiscano le sue composizioni carine, quindi la solida impopolarità che lo circonda non gli sarà neanche tanto dispiaciuta. L’unico evento musicale di un certo rilievo della sua vita è l’esecuzione della sua terza sinfonia con la quale vince il premio Pulitzer, per metà diviso con un suo giovane ammiratore-allievo con la dedica: “I premi sono per i ragazzi e io ormai sono adulto”. In seguito diventa, sempre nel più assoluto anonimato e con i soldi dell’assicurazione, sostenitore e finanziatore di tanti altri compositori americani più giovani e bisognosi di lui.
Un bel giorno del 1927, racconta la moglie, Ives entra in salotto e dichiara con le lacrime agli occhi “Non riesco più a comporre, non mi piace più niente di quello che faccio”.
Hanno cercato di spiegare questo repentino mutismo musicale, ma non ci è riuscito nessuno. Si è arrivati solo a trovare un paragone con Sibelius, che soffrì dello stesso inaridimento del flusso creati-vo alla stessa età.
Molti e sempre più numerosi con il passare degli anni sono i suoi estimatori, a cominciare da Mahler che lo definisce “Un vero rivoluzionario della musica”, per passare a John Cage che ammira “la sua capacità di comprendere l’importanza in palcoscenico dell’inattività e del silenzio” e poi a Stravinskij e a Bernstein, che dirige la sua Seconda Sinfonia in un concerto alla radio ascoltato, co-me si usava all’epoca, nel tinello di casa dai coniugi Ives, stupiti dei caldi applausi del pubblico.
Perfino Frank Zappa dichiara Charles l’influenza dominante nel suo disco “Freak Out” del ’66. Phil Lesh, bassista dei Grateful Dead lo chiama il suo eroe musicale.
Ma il più entusiasta di tutti è Schoenberg. Poco dopo la sua morte, tre anni prima di quella di Ives, la vedova trova una sua dichiarazione scritta al tempo in cui insegnava a Los Angeles, che è un monumento alla sua integrità artistica: “In questo paese c’è un grand’uomo, un compositore, che ha risolto il problema di mantenere la propria autostima. Reagisce al disinteresse con il disprezzo. Non si sente obbligato a ricevere lodi o accettare critiche. Si chiama Charles Ives”.
N° 643 - Microbiografie Irrispettose - Arcangelo Corelli 1653 - 1713

A Fusignano dove nasce nel 1653, i suoi antenati sono famosi come attaccabrighe che da anni, se non da secoli, tentano di strappare, senza riuscirci, il feudo alla famiglia rivale dei Calcagni.
Lui invece lo descrivono “timido, ordinato, austero, servizievole e tranquillo”, nella vita di tutti i giorni; ma guai a contrariarlo sul lavoro! Allora diventa “energico, esigente e determinato”.
Appena può se ne va a studiare a Bologna, che è all’epoca la seconda città più importante dello Stato Pontificio, con la sua antica università e una quantità di chiese che mantengono orchestre e cori; poi ci sono tre grandi teatri per spettacoli drammatici e operistici, diverse case editrici musicali e perfino una mezza dozzina di accademie sovvenzionate dai nobili e dal clero. Insomma, un nido di cultura e di arte. Bella fortuna esserci capitato al momento giusto.
La sua produzione è striminzita: cinque raccolte di sonate per violino solo o in trio e una di concerti grossi. Ma sufficiente a fare di lui il violinista più famoso del suo tempo, nonché un maestro insuperato di tecnica virtuosistica e di esecuzione. Un vero miracolo che gli capita mentre è ancora vivo, giovane e in piena attività. Ammesso all’Accademia dell’Arcadia, chiamato da principi e cardinali il “Nuovo Orfeo”, il “Principe dei Musicisti”, insomma una leggenda vivente.
Eppure, anche lui deve combattere la sua guerra in famiglia perché all’epoca quella del musicista è una professione servile e di pochissimo prestigio sociale, per cui mamma Corelli, che appartiene alla piccola nobiltà campagnola, rimasta vedova presto, acconsente a fargli prendere qualche lezione privata di violino, purché però completi i suoi studi tradizionali, prima di lasciarlo andare a Bologna, dove, appena diciassettenne lo invitano all’Accademia Filarmonica.
Poi, via verso Roma, dove il suo prestigio di virtuoso, ma anche di direttore d’orchestra, cresce, diventa internazionale, grazie alla protezione della regina Cristina di Svezia, poi del cardinale Pamphili e finalmente del suo grande mecenate, il cardinale Ottoboni, nipote di Papa Alessandro VIII, che lo ospita a palazzo insieme ai fratelli Ippolito, Domenico e Giacinto, lasciandolo completamente libero dalle pressioni che gli altri musicisti devono subire dai loro potenti e spesso prepotenti padroni.
Qui Arcangelo vive in mezzo al lusso (degli altri). Lui è persona modesta e discreta. Il suo unico capriccio è una bella collezione di dipinti, che accresce anno dopo anno fino ad arrivare a centoquaranta pezzi importanti, insieme a un certo numero di violini di pregio che lascerà in eredità al suo allievo prediletto Matteo Fornari, con il quale si mormora abbia una relazione (Corelli non si sposa né gli si conoscono storie di donne).
Pare che sia anche estremamente parsimonioso: il suo guardaroba è ridottissimo, va in giro sempre vestito di nero e solo a piedi, e si arrabbia se qualcuno cerca di farlo salire in carrozza.
Invece quando suona, specialmente passi difficili, “la sua figura è trasmutata e contorta, i suoi occhi sono tinti di rosso e girati nelle orbite come fosse in agonia”.
Ma anche in una vita così lineare non manca qualche inciampo. Convocato a Napoli per farsi ascoltare dal re, mentre suona un adagio, Sua Maestà, annoiato, si alza e se ne va a metà dell’esecuzione con grande mortificazione di Arcangelo. In un’altra occasione, a Roma per un’opera di Haendel, con l’autore presente, pare che quest’ultimo, insoddisfatto dell’esecuzione, gli tolga il violino di mano per mostrargli come il brano va suonato.
Verso il 1710 si ritira dai palcoscenici, lasciando la direzione dell’Orchestra di San Luigi, che aveva tenuto per più di vent’anni, occupandosi, come un vero impresario, di reclutare esecutori e pagare stipendi, viaggi e trasporto strumenti, talvolta mettendo insieme formazioni per l’epoca sterminate: fino a 150 elementi.
Il suo posto viene preso dall’allievo Fornari, e quando muore, il suo protettore Ottoboni lo fa seppellire nel Panteon, un onore supremo per un musicista. Ricordiamoci sempre che allora i musicisti facevano parte del personale di servizio e non contavano un gran che.
Corelli, il grande virtuoso del violino, non ha lasciato nessuna testimonianza scritta sulla sua tecnica strumentale. All’epoca c’erano addirittura in uso diversi modi di tenere lo strumento: sotto il mento, sopra la spalla o contro il petto. Pare che lui lo tenesse appoggiato al petto e molto proiettato in avanti “appena sotto la clavicola, inclinando leggermente il lato destro verso il basso, in modo che non sia necessario inchinarsi troppo quando bisogna suonare la quarta corda”.
Un’ultima nota che forse farà sorridere i nostri lettori violinisti: “Corelli riteneva essenziale che l’intera orchestra muovesse gli archi esattamente insieme: tutti su, tutti giù, in modo da poter interrompere le prove se avesse visto un arco fuori posizione”.
N° 642 - Microbiografie Irrispettose Francis Poulenc 1899 - 1963

Nasce a Parigi, figlio di un grande industriale farmaceutico e di una pianista che lo incanta quando si siede alla tastiera. Ma è soprattutto affascinato dallo zio Papoum, il fratello della madre, che è esattamente come deve essere uno zio speciale: musicista anche lui e pittore, uomo di mondo, frequentatore di teatri e caffè; irresistibile mito per i nipotini.
Bambino prodigio (guarda un po’) a cinque anni studia pianoforte con mamma e a sette già compone piccoli brani e ammira Debussy, di cui però non riesce a suonare gli spartiti, mentre Schubert, appena ascoltato, gli riesce facilissimo.
Il suo nuovo insegnante e poi amico per la vita sarà Ricardo Vines, un grande pianista e didatta dell’epoca che lo metterà in contatto con il meglio del meglio della cultura, non solo musicale, francese.
Il centro di questa giostra di cervelli, oltre alla libreria Monnier è il locale “La Gaya” a Montparnasse, fondato nel 1917, che lui frequenta accanitamente.
In quello stesso anno c’è la prima esecuzione della sua “Rapsodie Negre”, dedicata a Satie.
Ma non è altrettanto fortunato con il Conservatorio di Parigi nel quale cerca di entrare facendosi presentare a Paul Vidal, sommo insegnante di composizione.
“Mi ha chiesto se gli avessi portato un manoscritto. Gli ho dato la partitura di “Rapsodie Negre”. L’ha letta attentamente, ha alzato il sopracciglio e vedendo la mia dedica a Satie si è infuriato e ha gridato queste esatte parole: Il tuo lavoro puzza! Stai cercando di farmi passare per uno scemo? Che cavolo è questa roba? Ah, vedo che ti sei unito al gruppo di Stravinskij, Satie & Co. Bene, allora addio!”
Alla fine della Prima Guerra Mondiale, Poulenc comincia a collaborare con grandi nomi della letteratura: Cocteau, Apollinaire, approfondendo così la sua intimità con i potenti intelletti di Francia. Non solo scrittori; è amico di Picasso, Modigliani, Valery, Claudel, Milhaud, Auric… superfluo ripeterlo: il centro del mondo in quell’epoca è Parigi.
1924, finalmente il successo! L’esecuzione a Montecarlo del suo “Les Biches”, commissionatogli da Djagilev per i Balletti Russi, lo lancia definitivamente. “La premiere di “Les Biches” è stata, se posso dirlo, un trionfo. Otto chiamate alla ribalta, cosa rarissima per Montecarlo”, scrive lui stesso in una lettera.
A questo punto della sua vita gli succede qualcosa che lo colpisce forte. In una serie impressionante di decessi perde tanti amici a cui è particolarmente affezionato. Questo lo spinge a fare un pellegrinaggio alla Madonna Nera di Rocamadour e o fa scivolare in uno stile di lavoro e di vita, lui che è da sempre uno spensierato gaudente, molto più sobrio; addirittura mistico. Compone la Messa in sol minore, lo Stabat Mater, le Litanie per la Vergine Nera, un Gloria, un concerto per organo…
Il successo continua ad aumentare anche grazie a una trionfale tournee in USA. Alla Scala di Milano è l’apoteosi per il suo “Dialoghi delle Carmelitane”. E così, di clamore in clamore, arriviamo al suo ultimo clamoroso concerto a Maastricht il 26 gennaio 1963.
Quattro giorni dopo, un infarto lo fulmina a casa sua a Parigi.
In gioventù ha dichiarato senza esitazione: “La mia musica è il mio ritratto”. L’amico Britten che lo conosce bene ci chiarisce come la musica di Poulenc possa anche apparire spiritosa, audace, sentimentale, maliziosa, tipicamente francese, ma in realtà Francis è spesso depresso, impressionabile, insicuro, soggetto al panico.
In più vive con tormento il contrasto fra la sua dichiarata omosessualità (che lui chiama sessualità parigina) e la sua profonda fede cattolica. Il suo primo rapporto ufficiale è con l’autista Destouches al quale dedica la sua opera “Le Mammelle di Tiresia”. Poi, più importante, arriva il pittore Chanlaire, poi ancora Lucien Roubert, che però un giorno lo abbandona facendolo sprofondare in una cupa depressione, dalla quale per fortuna lo salva il grande successo dei “Dialoghi delle Carmelitane”, terminato e messo in scena proprio in quel periodo.
Da questa lista di amori sbuca una sola donna, l’amica d’infanzia Raymonde Lynossier che lui vorrebbe sposare anche se non arriverà mai a dirglielo personalmente per paura di perdere la sua amicizia. Raymonde muore prima che lui trovi il coraggio di dichiararsi e per un anno Francis non riesce a scrivere una nota. A lei aveva dedicato il suo primo balletto “Les Biches”, la cui partitura viene deposta nella bara dell’amica.
L’essenza artistica di Francis Poulenc emerge densa da questa sua propria dichiarazione: “I miei quattro compositori preferiti, i miei soli maestri sono Bach, Mozart, Satie e Stravinskij. Non mi piace per nulla Beethoven, detesto Wagner. Non sono né un musicista cubista, nemmeno un futurista e chiaramente neanche un impressionista. Sono un musicista senza un’etichetta”.
N° 641 - Microbiografie Irrispettose - Gaetano Donizetti 1797 - 1848

Troppe opere, troppe romanze, troppi quartetti, troppo di corsa, troppa musica! E non sempre capolavori. Tanto è vero che a un certo punto cominciano a chiamarlo “Dozzinetti”.
La fretta; il fatto è che ha sempre fretta, specialmente negli ultimi anni. Il Don Pasquale lo scrive in dieci giorni; la Maria di Rohan in otto. Corre a Vienna, lascia Napoli, si catapulta a Parigi. E’ come se sapesse che il suo tempo sta per finire. E infatti, dopo una serie di emicranie e febbroni, si avvia inesorabilmente verso la pazzia. Ha contratto quella che è la maledizione più comune per coloro che all’epoca facevano vita sregolata: la sifilide.
La crisi finale lo prende a Parigi nel 1846. Prima i medici lo dichiarano incapace di intendere e di volere, poi, con la complicità del nipote che gli fa credere si tratti di un albergo, lo ricoverano nell’Istituto per malati di mente dove rimane un anno e mezzo passando da stati di delirio a momenti di disperazione.
Finalmente l’intervento di amici influenti riesce a fare annullare il decreto di segregazione. Lo tirano fuori dalla gabbia e gli permettono di tornare a Bergamo. E qui trascina gli ultimi mesi della sua vita completamente fuori di sé, fino a morire l’8 aprile del ‘48.
Gaetano nasce a Bergamo quinto di sei figli del poverissimo guardiano del Monte dei Pegni Andrea e della altrettanto miserabile tessitrice Domenica. Vivono tutti insieme ammassati in un “triste tugurio ov’ombra di luce non mai penetrò”.
A sette anni è ammesso insieme al fratello Giuseppe alle lezioni caritatevoli di musica tenute da Simon Mayr. Naturalmente è un bambino prodigio, altrimenti non ne parleremmo, e si fa notare subito, tanto è vero che il suo maestro gli procura la commissione per un’opera al teatro San Luca di Venezia.
Da questo momento comincia la galoppata. Un contratto con l’impresario Barbaja lo impegna a scrivere quattro opere l’anno: per lui, velocista della composizione, una sciocchezza. Ha anche il tempo di inventarsi una nuova disposizione degli archi nell’orchestra: a semicerchio davanti al podio.
Entra in competizione di successi con Bellini, che lui ammira profondamente, per niente ricambiato dall’altro (avrà comunque la soddisfazione, quando Vincenzo muore nel 1832, di scrivergli un bel Requiem).
Da Parigi Rossini gli commissiona un’opera per il Teatro Italiano: il Marin Faliero. Diventa direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli, dove vedono la prima esecuzione ben diciassette opere sue, fra cui, con grandissimo successo, la Lucia di Lammermoor, scritta in trentasei giorni (ecco di nuovo la sua fretta). In questo periodo muoiono suo padre, sua madre e la sua seconda figlia, seguiti in un funereo corteo dalla terza figlia e dalla moglie “Senza padre, senza madre, senza figli, per chi lavoro dunque? Tutto, tutto ho perduto”. Ma intanto continua a comporre, a mettere inscena, ad avere successo.
Lascia Napoli e si precipita a Parigi dove il suo trionfo diventa immenso e internazionale, anche se all’amico Tommaso Persico scrive: “Immaginati come sto io, che soffro di nervi orribilmente. Oh se sapessi cosa si soffre qui per montare un’opera. Gl’intrighi, le inimicizie, il giornalismo, la direzione…auff!”, ma rimane e va avanti, sempre di corsa. E corre, corre, corre…
Nel 1875 riesumano la sua salma, ma il cranio non si trova. Si investiga fra gli otto medici che avevano effettuato l’autopsia e si scopre il reperto presso il nipote ed erede di uno di loro. Dopo vari giri, la preziosa reliquia è ricollocata nella tomba e fino a questo momento è ancora lì.

La storia di Gaetano ha una ramificazione curiosa in quella di suo fratello maggiore Giuseppe. Il quale, musicalmente dotato come lui, nel 1808 si arruola nell’esercito di Napoleone e lo segue in tutte le sue campagne fino a Waterloo.
Napoleone fuori combattimento, torna in Italia, entra nell’esercito piemontese e diventa direttore della banda musicale del reggimento di Casale, poi si sposta a Genova e lì, non sappiano come e perché, dal Sultano turco Mahmud II riceve la nomina a “Istruttore Generale delle Musiche Imperiali Ottomane”. Parte per Istambul e appena arrivato si trova a capo della banda imperiale Mizikay-Humayun.
E qui comincia la sua fantasmagorica e trionfale cavalcata come istruttore, compositore, direttore e soprattutto innovatore perché riesce a rivoluzionare la struttura musicale dell’Impero Ottomano, facendo adottare la notazione e i ritmi occidentali e organizzando nei teatri della capitale una nutrita stagione musicale con un ricco cartellone di opere italiane, fra cui parecchie del fratellino.
E, diversamente dalla tragica fine di Gaetano, anche lui a un certo punto muore, ma dopo aver vissuto in piena salute una lunga, felice, e ricca esistenza in Turchia.
N° 640 - Microbiografie Irrispettose - Charles Gounod 1818 - 1893

E pensare che con tutta la musica che ha scritto la fama gli arriva con una marcetta buffa e con una zuccherosa melodia matrimoniale.
Charles è un lattante prodigio: “Mia madre non mi allattava mai senza cantare; posso dire di avere preso le mie prime lezioni di musica senza rendermene conto. Attaccato alle sue poppe avevo già la nozione chiarissima delle intonazioni e degli intervalli…”
Ecco, magari il nostro esagera un po’, ma è un fatto che quella stessa madre, pianista, che lo allatta cantando si rende conto presto del talento del pupo e lo mette in mano a Antonio Reicha, notissimo insegnante di composizione e contrappunto, amico di Beethoven e tutore di altri famosi geni come Liszt, Berlioz e Franck.
A tredici anni mamma lo porta a vedere l’Otello di Rossini e a quattordici il Don Giovanni di Mozart. Detto fatto, decide di diventare compositore.
Studia, naturalmente progredisce come un fulmine e nel 1839 vince il Prix de Rome, due anni a Villa Medici. La sua impressione: “Roma è una città di provincia, volgare, incolore, sporca. La musica nelle chiese è da far rabbrividire. All’infuori della Cappella Sistina, non vale nulla: è esecrabile” (opinione condivisa in momenti diversi da Berlioz, Mendelssohn e Debussy).
Neanche i teatri d’opera a Roma gli piacciono: “Ho assistito al Teatro Apollo a una Norma in cui i guerrieri romani portavano un elmo da pompiere e pantaloni a strisce rosso ciliegia. Da morir dal ridere”. Di buono Roma gli dà l’incontro con Fanny, la sorella di Felix Mendelssohn, la quale lo introduce alle opere di Bach che il fratello proprio in quel periodo sta tirando fuori dall’ingiusto e incomprensibile oblio; e la conoscenza con Ingres, il famosissimo pittore, direttore dell’Accademia e amico di suo padre, che lo prende sotto la sua protezione e gli apre il mondo della classicità.
Tornato a casa Gounod sprofonda in una crisi spirituale, innescata da un altro incontro romano, quello con il predicatore domenicano Henri Lacordaire, e pensa seriamente di farsi prete. A rinforzare questa inclinazione contribuisce anche la frequentazione di un amico d’infanzia diventato sacerdote. Si iscrive come studente di teologia al Seminario di Saint Sulpice. Alla presunta vocazione non ci sarà seguito, ma intanto la quantità di musica sacra che scrive è sterminata.
Pare che sia stata la madre (ancora questa donna così importante nella sua vita) a portarlo con persuasiva discrezione a preferire la musica al richiamo sacro.
L’anno dopo, a Lipsia, conosce personalmente Mendelssohn che all’incontro gli dichiara: “Così lei è quel pazzo di cui mi ha parlato mia sorella!” però poi gli dedica quattro giorni in cui gli presenta il meglio della cultura cittadina e gli organizza concerti.
Nel 1870, spaventato dalla guerra franco-prussiana scappa da Parigi con la famiglia (nel frattempo si è sposato) prima in campagna e poi a Londra. E fa bene, perché le truppe nella loro avanzata gli distruggono la casa di Saint-Cloud, dove abitava.
A Londra Gounod viene presentato alla cantante Georgina Weldon e qui ha inizio una faccenda che, dopo più di un secolo, non è ancora chiara. Georgina diventa il motore della vita artistica, pubblica e forse anche sentimentale di Charles. Tutto è mistero, ma è un fatto che, alla fine della guerra, la moglie torna a Parigi con i figli mentre lui rimane in Inghilterra.
E ci rimane per ben tre anni, rinunciando perfino (fra i gossip della stampa francese) all’offerta da parte del Presidente della Repubblica della direzione del Conservatorio di Parigi. Però la pressione dell’opinione pubblica e quello che sta diventando uno scandalo cultural-politico gli provocano un vero e proprio collasso di nervi e allora, per fortuna, nel 1874, il suo amico Gaston de Beaucourt (che meraviglia questi nomi da belle epoque!) viene a recuperarlo e lo riporta a Parigi.
Georgina non la prende affatto bene: rifiuta di restituirgli alcune partiture che lui le aveva lasciato in custodia, pubblica un resoconto tendenzioso sul loro rapporto e in più gli fa causa, arrivando a una sentenza che gli impedirà per il futuro di mettere piede in Inghilterra (forse qualche ragione l’aveva anche lei).
Durante la sua assenza la scena musicale a Parigi è profondamente cambiata e Gounod, partito con il ruolo di primo compositore di Francia, al suo ritorno, pur mantenendo il rispetto del pubblico, scopre di non essere più un autore d’avanguardia, anzi, di trovarsi nelle retrovie della nuova pattuglia composta da Chabrier, Fauré, Massenet…
Nessuna amarezza da parte sua, anzi, un sincero sostegno per i nomi nuovi. Una brava persona.
Gli ultimi anni li passa nella casa (ricostruita) di Saint-Cloud a comporre musica sacra e il 15 ottobre 1893, di ritorno dalla messa dove ha suonato l’organo ha un colpo e se ne va.
Grandioso funerale a Parigi. Fra i portatori della bara ci sono lo scrittore Sardou e il futuro presidente francese Poincaré. Fauré dirige il coro.
A questo punto, prima di lasciarci, bisogna integrare le informazioni. La sua marcetta buffa, intitolata “Marcia Funebre per una Marionetta”, è diventata immensamente popolare da una cinquantina d’anni dopo che è stata scelta come sigla della serie TV “Alfred Hitchcock presenta…”
E la zuccherosa melodia matrimoniale? E’ l’Ave Maria, un tema originale e orecchiabilissimo, che Gounod ha appoggiato sul Preludio N° 1 in do maggiore dal primo libro del Clavicembalo Ben Temperato di Bach.
Sacrilegio, furbizia o un sincero omaggio a un grande del passato? Non lo sapremo mai, ma in fondo che ce ne importa?
N° 639 Microbiografie Irrispettose - Henry Purcell 1659 - 1695

Era una notte buia e tempestosa a Londra; lui stava tornando a casa dopo aver fatto bisboccia alla taverna. Trovò la porta sprangata: la moglie l’aveva chiuso fuori. Polmonite galoppante, dopo due settimane era bell’e morto.
(Altre fonti parlano di tubercolosi; meno pittoresco, forse più probabile).
Ed ecco a voi Henry Purcell, uno dei più grandi compositori inglesi, uno che ha sbaragliato tutti i contemporanei per qualità e quantità di opere. Ma a quanto pare aveva queste abitudini goderecce e una moglie poco tollerante. Ci dispiace per lui.
Bambino prodigio come tanti altri poi diventati adulti famosi, pubblica a undici anni un’ode per il compleanno del re. A quei tempi era opportuno, anzi indispensabile, ingraziarsi i potenti il più presto possibile perché la sopravvivenza degli artisti era legata solo al loro favore, visto che non esistevano diritti d’autore né pubblico pagante.
Più tardi compone una serie di arie per la straordinaria e all’epoca famosissima voce di basso profondo del reverendo John Gostling, solista della Cappella di Sua Maestà e suo protettore. Addirittura, come ringraziamento per lo scampato naufragio del Re Carlo II, Purcell musica i versi che il reverendo basso profondo ha scritto per l’occasione.
Insomma, è tutto un muoversi intorno agli stessi personaggi: una specie di corte astronomica, con il (re) sole al centro e tutti i (cortigiani) pianeti che gli girano intorno.
Sui registri della Cappella Reale, il 10 giugno 1673, quando lui ha appena quattordici anni, appare l’autorizzazione ad “ammettere Henry Purcell alle funzioni di custode, fabbricante, riparatore, accomodatore ed accordatore di organi, virginali, flauti e tutti gli altri qualsivoglia strumenti a fiato di Sua Maestà”.
Da qui, in una scalata vertiginosa della gerarchia musicale a corte, con incarichi sempre più prestigiosi, passiamo a Westminster, dove Purcell eredita la posizione di organista dopo le dimissioni del titolare Blow, suo professore (si dice che tanto amasse il suo allievo da rinunciare volontariamente alla propria posizione per favorirlo).
Poco dopo incassa anche la nomina di organista della stessa Cappella Reale, un doppio incarico che lo colloca al vertice dei musicisti d’ Inghilterra.
E qui, come compositore di Corte, si scatena producendo una serie infinita di inni e odi per i compleanni, i matrimoni, le nascite, i battesimi, i funerali e le incoronazioni di tutta la famiglia reale.
Amato dalla sua gente, è sepolto a Westminster, accanto al suo organo, sotto una lapide che dice: “Qui giace Henry Purcell, che ha lasciato questa vita ed è andato in quell’unico luogo benedetto dove la sua musica può essere superata”.
Tante sono state le utilizzazioni delle sue musiche per il cinema: “Arancia meccanica”, “Kramer contro Kramer”, “Orgoglio e Pregiudizio”; e tante le rielaborazioni dei suoi temi da parte dei Jethro Tull, dei Who, dei Pet Shop Boys, di Michael Nyman.
Vuol dire che era già moderno allora, e lo è rimasto fino ad oggi.
N° 638 - Microbiografie Irrispettose Alban Berg 1885 - 1935

Il 31 marzo 1913 danno alla Musicverein di Vienna un concerto di musiche di compositori della Seconda Scuola Viennese (fra cui c’è Alban Berg) diretto da Schoenberg: l’atteso e già battezzato “Skandalkonzert”, (concerto dello scandalo).
Il pubblico, irritato dall’espressionismo e dallo sperimentalismo della musica, dà in escandescenze, scoppiano discussioni e risse e a un certo punto l’organizzatore Buschbeck molla un bel ceffone a uno spettatore. La serata si chiude prematuramente e il concerto cambia nome e diventa il “Watschenkonzert” (il “concerto dello schiaffo”).
Il famoso compositore di operette Oscar Straus, presente al fattaccio, dichiarerà il giorno dopo alla stampa che quello schiaffo era stato “il suono più armonioso di tutta la serata”.
Bambino infelice e ragazzo depresso, Alban Berg a diciotto anni tenta il suicidio per un insuccesso scolastico. Passato dal benessere familiare alla povertà per la morte del padre, sopravvive con il suo stipendio di contabile comunale senza aver mai pensato a studiare seriamente la musica finché nel 1904 conosce Arnold Schoenberg il quale, impressionato dal suo talento naturale, lo prende come allievo, gratis.
Finalmente nel ’10 scappa dagli uffici del Comune e si butta a capofitto nella musica. Nel frattempo ha provveduto a sostituire la mancata figura paterna con quella di un amico di famiglia, l’architetto Hermann, che sommerge di lettere anche di trenta pagine l’una, scritte in una prosa fluida e drammatica, che tradisce quello che era all’epoca il suo interesse dominante: la letteratura.
Nel 1906 conosce e si innamora della cantante Helene Nahowsky, di famiglia benestante (gira il pettegolezzo che sia figlia illegittima dell’Imperatore Francesco Giuseppe I). Malgrado l’opposizione della famiglia si sposano nel 1911, accettando la condizione imposta dal padre di lei di unirsi “con una cerimonia protestante per facilitare l’eventuale divorzio, a suo parere inevitabile”.
Combatte la Prima Guerra Mondiale nell’esercito austroungarico, poi torna a Vienna dove collabora con Schoenberg nella gestione della Società per le Esecuzioni Private di Musica, originale organizzazione nata con lo scopo di creare lo spazio ideale per l’apprezzamento di nuove composizioni attraverso prove aperte, esecuzioni gratuite e l’esclusione dei critici professionisti.
Con la sua musica, soprattutto il “Wozzeck”, entra a far parte della crema culturale viennese insieme al compositore Zemlinsky, al pittore Klimt, all’architetto Loos e siamo sicuri che nel gruppo abbia fatto una capatina anche la onnipresente Alma Mahler, occupata a sedurre qualcuno di loro. Conquista una bella popolarità in Europa fino a quando i nuovi rigurgiti di antisemitismo e l’arrivo del Nazismo lo fanno fuori, in primo luogo per aver studiato e collaborato con l’ebreo Schoenberg e poi classificando la sua musica, insieme a quella di tutti gli altri talenti della Seconda Scuola di Vienna, come degenerata e proibendone l’esecuzione. Sublime manifestazione di stupidità di questa dittatura, purtroppo uguale a tutte le altre nella gestione di arte e cultura.
Berg e sua moglie fin dal ’32 si sono ritirati in una casetta acquistata in Carinzia sulle rive di un lago dove lui può lavorare in tranquillità, ma ormai le cose si fanno sempre più difficili e le finanze sempre più scarse.
Per fortuna all’ultimo minuto arriva una boccata d’ossigeno sotto forma della commissione per un’opera (Il Concerto per Violino) che verrà eseguita postuma ma che intanto gli permette di sopravvivere. Per scriverla interrompe l’orchestrazione della “Lulù”, che lascerà incompleta quando muore alla vigilia di Natale del ’35, a causa di un’infezione del sangue provocata dalla puntura di un insetto.
Per uno di quelle incomprensibili impuntature che bloccano il cervello di alcune vedove di grandi e piccoli artisti, e tutti noi ne conosciamo qualcuna, la signora Berg proibisce tassativamente a chiunque di completare la partitura della Lulù (a posto per i primi due atti, mancante dell’orchestrazione per l’ultimo).
Per fortuna si decide di non darle retta e di affidare in gran segreto questo lavoro di rifinitura al musicista Friedrich Cerha e quando finalmente la vedova Berg muore nel 1979, la Lulù, completa, va in scena a Parigi sotto la bacchetta di Pierre Boulez e ha il grande successo che merita.
N° 637 - Microbiografie Irrispettose - Alessandro Stradella 1643 - 1682

Ammazzato come un cane a trentanove anni in Piazza dei Banchi a Genova, ecco la fine che fa Alessandro Stradella. Da sicari pagati probabilmente dal nobile Giovanni Battista Lomellini convinto che ci sia una storia fra sua sorella e il musicista, che le dà lezioni. Naturalmente non ci sarà nessuna condanna per Lomellini: non si può neanche pensare di importunare un nobile per la morte di un musico, all’epoca considerato poco di più di uno sguattero di cucina.
Stradella non è un santo. Prima di fare questa brutta fine ne ha combinati parecchi di guai. Tanto per cominciare, a Roma nel 1676, insieme all’amico cantante Giovanbattista Vulpio cerca di arraffare qualche baiocco organizzando un “indegno matrimonio” fra una cortigiana e un nipote del Cardinale Alderano Cybo. E’ rischioso toccare un nobile di così alto livello. Infatti finisce dritto dritto in galera dove lo tengono per un po’, poi lo lasciano andare.
Questa esperienza non gli ha insegnato niente. Appena libero scappa a Venezia contando sulla protezione di un suo estimatore, il gentiluomo Polo Michiel, al quale chiede aiuto “per una certa desgrazia qua in Roma che no me permete per adesso il dimorare”.
Riesce a farsi assumere dal nobile Alvise Contarini come insegnante di canto della di lui amante madamigella Agnese von Uffele. Non passa un mese che imbastisce una tresca con la ragazza e, detto fatto, scappano insieme a Torino dove, in attesa di sposarsi, si nascondono, lui in un convento di frati, San Domenico, lei in uno di suore, Santa Maria Maddalena.
La sera del 10 ottobre 1677, mentre rincasa proprio da una visita ad Agnese, un paio di bravi mandati dal Contarini lo accoltellano per strada. I due tipacci, dopo l’agguato chiedono asilo all’ambasciatore francese a Torino, che glielo concede su richiesta di quello a Venezia. Putiferio diplomatico, ma niente di più di una sgridata per i due. Evidentemente anche allora tutto funzionava sulla base di influenze e favori. Stradella se la cava ma vede sfumare il suo progetto matrimoniale e la speranza di essere scritturato dalla corte dei Savoia.
E’ chiaro che non può più rimanere a Torino. Allora fugge a Genova, dove lo accolgono bene e riesce a farsi una posizione componendo musiche per il teatro del Falcone e per i “Barcheggi”, spettacoli allestiti su zattere galleggianti nel porto. Ma, come sappiamo, avendone fatta un’altra delle sue, pochi anni dopo ci rimette la pelle, questa volta sul serio.
La sua vita spregiudicata ha ispirato biografie romanzesche, melodrammi e film, tanto che si può dire che il personaggio è più noto per le sue avventure che per la sua musica.
Nato a Bologna, è battezzato Antonio Alessandro Boncompagno in omaggio al Principe Boncompagni di cui il padre Marcantonio, Cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano, è dipendente come governatore di Vignola.
Rimasto presto orfano, lo ritroviamo a Roma con la madre e il fratello nel palazzo della duchessa Maria Cristina Altemps, di cui i due ragazzi risultano paggi, e la madre dama di compagnia.
Avviata seriamente, e con un buon successo, la professione di musicista, collabora alla messa in scena e alla composizione di nuove arie di opere per il teatro Tordinona, il primo teatro pubblico di Roma, inaugurato proprio in quel periodo, e per il palazzo dei Colonna in Borgo. Una delle sue composizioni più famose, l’oratorio San Giovanni Battista, viene eseguito nella chiesa di San Giovanni de’ Fiorentini. Compone serenate e cantate su commissione della Regina Cristina di Svezia e per accompagnare i banchetti del cardinale Chigi.
A cui, sempre a corto di denaro, nel ’70 manda una supplica per avere un aiuto a saldare un debito di 7.000 scudi. Non si sa che risposta riceva.
E’ spesso al verde perché non è mai riuscito a ottenere un impiego fisso e, anche se ha parecchie importanti commissioni private, i suoi clienti lo pagano male e sempre in ritardo. Forse sarebbe riuscito a migliorare la sua condizione, ma con una vita così breve come la sua non lo sapremo mai
Diciamolo: un simpatico mascalzone, bravo musicista che avrebbe potuto dare migliori dimostrazioni del suo talento se fosse stato un po’ più attento alla gestione delle sue avventure galanti a agli incontri con brutte persone.
N° 636 - Microbiografie Irrispettose - Jean Sibelius 1865 - 1957

Quando non sta al pianoforte lo trovi con un bicchiere in una mano, una forchetta nell’altra e, se possibile, un sigaro acceso nella terza. Perché mangiare, bere e festeggiare è il suo obiettivo appena ha due soldi in tasca.
Solo che non gli capita spesso di averli, quei due soldi, almeno nella prima parte della sua vita, con grande rovello di quella santa donna di sua moglie Aino.
La fortuna di Sibelius è non solo di essere un musicista eccellente, ma anche di vivere in un paese civile, la Finlandia, che, quando lui ha poco più di trent’anni, gli garantisce un sostegno economico, prima decennale poi vitalizio. Finalmente finisce la miseria e vanno (lui e Aino) a vivere nella villa di Ainola anche se, come vedremo, lui ci si mette d’impegno in varie occasioni, a tagliare la corda e spendere e spandere come se fosse un milionario.
E intanto compone la sua musica nordica, in cui si intuisce la natura invernale e addormentata delle leggende finniche; della quale un critico del Manchester Guardian scrive: “Mentre gli altri compositori sono impegnati nella preparazione di saporiti cocktail, lui serve al suo pubblico pura acqua gelida”.
Jean, presto orfano di padre, cresce in una famiglia di donne con l’unica presenza adulta maschile dello zio Pehr Sibelius, che gli insegna il violino. Suona spesso in trio con la sorella maggiore e il fratello Christian, che diventerà un eminente psichiatra. Altra civile abitudine familiare dei paesi nordici: il gruppo musicale di famiglia, da noi del tutto sconosciuto.
Malgrado la sua applicazione, a un certo punto è costretto a rinunciare allo strumento. Ecco come racconta questa traumatica decisione: “La mia tragedia è stata che volevo diventare a tutti i costi un violinista famoso. Ho suonato il violino dieci ore al giorno da quando avevo quindici anni ed è stato terribile quando mi sono reso conto che avevo cominciato la mia preparazione troppo tardi”.
Per un periodo studia legge, ma poi abbandona tutto per la musica che gli permette di sopravvivere come insegnante fino all’arrivo del benedetto vitalizio, dopo di che finalmente può dedicarsi alla composizione.
Nel 1899 gli eseguono la Prima Sinfonia, che ha un certo successo, e nello stesso programma anche un coro patriottico, il “Canto degli Ateniesi” che lo trasforma all’istante in un eroe nazionale. Da quel momento la sua fama comincia a crescere.
Come crescono le sue scappatelle a Helsinki, dove, lasciata a casa la povera Aino, nel 1903 passa un periodo di eccessi gastronomici e alcolici con una scia di conti non pagati nei ristoranti di lusso (ma nello steso tempo compone il celeberrimo Valzer Triste). La povera Aimo gli scrive e lo implora di tornare in famiglia e dai figli. Niente: Sibelius preferisce stare lontano da casa, non solo per bere, ma anche per lavorare.
Di nuovo nel 1907, altra fuga a Helsinki, altre spese folli, che evidentemente non si poteva permettere tanto che la povera Aino non regge allo stress di un marito come lui e deve essere ricoverata in un istituto. Pentito, Jean promette di ravvedersi e si dedica alla composizione della Terza Sinfonia. Torna la pace e la serenità in famiglia.
Intanto scoppia la Prima Guerra Mondiale e questo riduce drammaticamente l’arrivo dei diritti d’autore dall’estero; il pianoforte su cui lavora sta per essere pignorato, quando l’amica cantante Ida Ekmann, organizza una colletta che lo salva dalla bancarotta.
Qualche complicazione ci sarà anche all’epoca della rivoluzione russa che, data la pesante vicinanza con la Finlandia si ripercuote anche sulla sua vita e sulla famiglia con perquisizioni in casa e minacce di arresto.
Nel ’17 Sibelius ricomincia a bere pesantemente, e addio all’idillio coniugale. La Finlandia si dichiara indipendente dalla Russia e la “Jager March” composta in quell’occasione gli porta nuova popolarità e rinnovata serenità in quell’altalenante inferno che deve essere la sua vita coniugale (soprattutto per la povera Aino che probabilmente non trova nessun sollievo nell’alcool).
All’inizio del ’19 sceglie un nuovo look e si rade completamente i capelli mettendo in mostra quel capoccione per cui lo riconosciamo da allora in poi. Anni dopo sarà costretto a portare gli occhiali da vista, con i quali però non permetterà mai che lo fotografino. Curiose civetterie senili.
A dicembre 1920, per il suo compleanno, riceve una cospicua donazione di 63.000 marchi, con la quale salda una parte dei debiti, ma con il resto se ne va di nuovo a Helsinki per un’altra settimana di follie etiliche e gastronomiche.
Viaggia in Europa dirigendo le sue musiche con successi alterni. Trionfo a Gotenborg, malgrado salga sul podio alticcio. Finisce la Settima Sinfonia e la dirige a Stoccolma e in parecchie serate a Copenhagen con un ottimo successo.
Dopo questo periodo intenso ritorna ad Ainola per riposarsi, ma proprio qui un tremito alle mani, che era apparso poco prima, si intensifica e c’è il sospetto che per tenerlo sotto controllo, come una medicina, Sibelius ricorra sempre di più al bicchiere.
Negli anni ’40, all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, dopo aver dichiarato agli amici che non sarebbe mai riuscito a scrivere niente di meglio della sua Settima Sinfonia, Sibelius si scatena in un sabba di autodistruzione. Racconta Aino: “Mio marito riempì una cesta di suoi manoscritti, accese un falò e ce li buttò dentro. Non ebbi la forza di assistere e me ne andai. Quindi non so cosa abbia bruciato. Ma dopo la cerimonia, Jean si calmò e diventò quasi allegro.”
La sera del 20 settembre 1957 la lunga vita di Sibelius finisce ad Ainola per un’emorragia cerebrale. In quel momento la Radio Finlandese sta trasmettendo la sua Quinta, e l’Assemblea dell’ONU che è in riunione, si ferma per un minuto di silenzio. Il Presidente dichiara: “Sibelius apparteneva al mondo. Ha arricchito l’umanità con la sua musica”.
Aino Sibelius, la povera Aino, alla quale il compositore ha fatto vedere i sorci verdi tutta la vita, dura altri dodici anni e muore a novantasette per finire sepolta comunque accanto a lui nel giardino di Ainola.
N° 635 - Microbiografie Irrispettose - Giuseppe Tartini 1692 - 1770

Archetto e fioretto. Giuseppe Tartini è un violinista sopraffino (“Il trillo del diavolo”), ma anche uno spadaccino imbattibile.
A Pirano, Serenissima Repubblica di Venezia, dove nasce, i suoi genitori, lo mettono a scuola all’Oratorio di S. Filippo Neri, poi lo mandano a Capodistria al Collegio dei Padri, tentando di farne un francescano, ma lui non ci sta e butta la tonaca.
A questo punto eccolo all’Università di Padova a studiare da avvocato. E’ talmente brillante che i compiti li finisce in pochi minuti. Il resto del tempo lo dedica alla sua grande passione del momento: la scherma.
Anche in questa diventa subito bravissimo ma tanto attaccabrighe da finire coinvolto in troppi duelli. Li vince tutti naturalmente, per la sua abilità, ma è comunque una faccenda che fa rumore. Allora decide di mollare l’università e andarsene a Parigi per diventare maestro d’armi.
Ma, colpo di scena, al momento di partire si innamora di una bella damigella, che per combinazione è nipote del cardinale arcivescovo di Padova, Giorgio Cornaro, il quale non gradisce affatto. Ma lui tanto fa che riesce a sposarla di nascosto.
Scandalo! Inseguito dalle ire di tutta la famiglia di lei e soprattutto da quelle del potente cardinale, scappa verso Roma, travestito da pellegrino, mentre la poveretta, su ordine dello zio, la chiudono in convento. Né a Roma né in altre città Giuseppe trova un rifugio; vaga spaventato finché finisce nel Sacro Convento di Assisi di cui è guardiano un suo parente che lo ospita per un paio d’anni con la speranza che il ragazzaccio riesca a mettere la testa a posto.
Intanto, visto che in convento la spada non è bene accetta, ha finalmente voglia e tempo di sguainare l’archetto e approfondire lo studio del violino e della musica in generale sotto la guida di un celebre professore boemo, Bohuslav Cernohorsky, che in quel periodo insegna ad Assisi.
E poi, forse a causa della vita ritirata che fa, riesce anche a migliorare il caratteraccio che aveva e diventa un signorino per bene, tanto che “Quando morì furono in molti a rimpiangerlo non solo per il suo genio ma anche per la sensibilità dimostrata nei confronti dei più deboli e degli indigenti cui aveva sempre prestato aiuto.”
E c’è anche il lieto fine. Mentre suona il violino durante una funzione nella chiesa del convento di Assisi nascosto dietro a una tenda, questa si sposta per una ventata e un padovano nel pubblico lo riconosce. Tartini pensa di essere fritto; invece scopre che non solo il cardinale cattivo lo ha perdonato, ma lo sta cercando per riconsegnargli la nipote, che nel frattempo ha tirato fuori dal convento.
Rientrato a Padova, è colpito dalla tecnica violinistica di Veracini che ascolta in un concerto. Decide allora di perfezionare ancora di più i suoi studi sull’uso dell’archetto. Inventa formule come questa: “Primo studio dev’essere l’appoggio dell’arco sulla corda siffattamente leggero che il primo principio della voce che si cava sia come un fiato e non come una percossa sulla corda”.
Diventa talmente bravo (sembra davvero che riesca bene in tutto) che dopo poco la Basilica di Sant’Antonio gli affida la direzione della sua orchestra, senza affrontare un esame, come si usava, e con l’autorizzazione ad assentarsi quando vuole senza nessuna riduzione del salario. Un massimo riconoscimento, simbolico, ma anche pratico.
Nel 1723 lo chiamano a Praga per suonare all’incoronazione dell’Imperatore di Boemia Carlo VI e fra una cosa e l’altra ci rimane ben tre anni, ma alla fine è costretto a scappare da quella città troppo fredda e se ne torna a Padova, dopo aver giurato di non accettare mai più (e rimane fedele al suo impegno) commissioni da uno straniero.
Nel ’28 fonda una scuola di violino, La Scuola delle Nazioni, a cui accorrono solisti da tutta Europa, tanto grande è la sua fama, e da quel momento diventa il “Maestro delle Nazioni”. Fra i suoi studenti c’è anche Antonio Salieri.
Questa vita, tutto sommato felice, che finisce tardissimo, a 88 anni, per uno scorbuto complicato da una gangrena, pare sia stata disturbata soprattutto da due fatti, che potrebbero anche essere solo pettegolezzi: le continue e insistenti richieste di denaro da parte della sua famiglia rimasta a Pirano, e un rapporto burrascoso con la mogliettina, a suo tempo tanto desiderata ma con gli anni trasformatasi in un’arpia.
In compenso risulta per certo che, sempre in questa lunga vita, Tartini abbia aiutato a sopravvivere più di una famiglia in povertà, salvato dalla strada parecchi orfani e dato lezioni gratis a giovani di talento senza mezzi per pagare.
Insomma, proprio una brava persona.
N° 634 - Microbiografie Irrispettose - Ottorino Respighi 1879 -1936

Nel 1926 molla tutto per dedicarsi solo alla composizione e produce i suoi immortali, colorati, suggestivi e popolarissimi poemi sinfonici: “I Pini di Roma”, “Le Fontane di Roma”, e le “Feste Romane”, che diventano da subito monumenti al suo genio (e a Roma, naturalmente, di cui da allora sono la firma sonora).
A questo punto è necessario il classico passo indietro.
Ottorino Respighi nasce in una famiglia di musicisti: padre buon pianista dilettante, nonno organista della cattedrale di Fidenza. Fino a otto anni la musica non gli interessa, poi evidentemente scatta qualcosa e si mette a studiarla sotto la guida del padre, per poi proseguire con il violino da un professore esterno, che abbandona, furibondo, perché lo ha picchiato con un righello sulle dita per un passaggio male eseguito.
Intanto studia anche geografia, lingue (arriverà a parlarne undici!) e scienza. La moglie racconta a tutti di un suo incontro con Einstein a Berlino e della profonda sorpresa dello scienziato per la sua preparazione sull’argomento.
Non diventerà mai un virtuoso di pianoforte, ma sugli altri strumenti va forte. Dicono che sia riuscito a imparare a suonare l’arpa in una settimana. Studia al Liceo Musicale di Bologna, e poi si perfeziona arrivando al diploma accompagnato dalla dichiarazione del suo professore, Martucci: “Respighi non è un allievo, Respighi è un maestro”.
Lo troviamo in seguito prima viola nell’Orchestra Imperiale a Pietroburgo; qui approfitta per studiare orchestrazione con Rimskij Korsakov.
Nel 1908 Etelka Gerster, famosa soprano ungherese, lo chiama a Berlino come pianista accompagnatore nella sua scuola di canto; qui conosce Ferruccio Busoni, studia composizione con Max Bruch e abbandona la viola, di cui ormai era diventato un solista popolarissimo, per dedicarsi solo al pianoforte.
Oltre che autore è acuto studioso della musica antica italiana con pubblicazioni e revisioni di Monteverdi, Vivaldi, Marcello e riscritture o arrangiamenti di canto gregoriano e trascrizioni per orchestra di opere monostrumentali antiche e contemporanee.
Finalmente, nel 1913 vince la cattedra di alta composizione al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove si installa e di cui in seguito diventa direttore.
Da questo momento in poi parte per lui una folle vita di tournee, di concerti, di viaggi in giro per il mondo che lo rendono sempre più famoso, anche grazie al sostegno di Toscanini che lo ha convinto a dargli le sue “Fontane di Roma” per una serie di trionfali concerti che lo consacrano fra i massimi musicisti italiani.
E con il trionfo entrano in gestazione anche i futuri guai con i posteri. Popolarissimo, ricco e amato dal pubblico, comincia a essere oggetto degli onori ufficiali, graditissimi allora, ma poi fonte di problemi. In quel momento lui è il compositore italiano più conosciuto e il regime se ne impadronisce per farne una bandiera della cultura fascista. Lo nomina Accademico d’Italia, il massimo per un intellettuale e artista.
Onorificenza concessa però solo a persone di dichiarata fedeltà al Partito.
Poco alla volta cominciano a emergere i suoi problemi di salute: fra gli altri difficoltà a dormire di notte, accompagnata da sonnolenze improvvise di giorno, anche durante le prove, che fanno pensare ad attacchi di narcolessia.
Alla fine gli si scatena un’endocardite batterica che lo fa fuori, a cinquantasette anni, in quattro mesi. Sua moglie Elsa, con la quale, anche a detta dell’amico Giacomo Puccini, ha vissuto un felicissimo e invidiatissimo rapporto coniugale basato sull’amore reciproco e su quello concorde per il can-to gregoriano, gli sopravvive di parecchio promuovendo, diffondendo, facendo eseguire le sue opere, finché muore anche lei, ma a centodue anni (meno una settimana).
Ancora oggi nell’ambiente serpeggia una certa diffidenza verso Respighi perché, insieme ad al-tri musicisti dell’epoca come Pizzetti e Mascagni, gli si attribuisce un’adesione al regime fascista (come Direttore di Conservatorio e Accademico d’Italia), dimenticando che all’epoca o si accettava l’appartenenza, anche se di facciata, al Partito, oppure si finiva ai giardinetti a leggere il giornale.
Se non peggio.
N° 633 - Microbiografie Irrispettose - Franz Lehar 1870 - 1948

“Se la mia ”Vedova Allegra” era l’operetta preferita di Hitler, non è certo colpa mia”.
Una dichiarazione abbastanza sorprendente, ma che in un certo senso compendia il bello e il brutto della vita di Franz Lehar, il secondo più famoso autore di operette al mondo, naturalmente dopo Strauss.
Franz nasce, ed è un buon inizio, figlio di un direttore di banda militare. Naturalmente precoce, studia al conservatorio di Praga, debutta come violinista nell’orchestra sinfonica di Elberfeld, ma poi prosegue prima nel ruolo di assistente di papà nella banda del 50° Fanteria, poi come direttore di quella del 25° reggimento di Losoncz (il più giovane direttore di banda dell’Impero Austroungarico), per finire a capo della banda della Marina di Pola dove si butta anche a scrivere arrangiamenti per ottoni di brani classici e canzoni popolari.
Ma non è tutto: nel 1898 va a dirigere la banda navale di Trieste e la sua carriera militare culmina sostituendo il padre alla direzione della banda dell’87° reggimento a Budapest.
A questo punto basta con le bande perché finalmente, in occasione del gran ballo mascherato organizzato dalla principessa di Metternich, l’evento più mondano della stagione, eseguono il suo valzer “Oro e Argento” che decolla come un missile, diventa in una serata famoso in tutto il mondo e lo lancia nell’olimpo dei compositori arrivati.
Il top arriva nel 1905 con “La Vedova Allegra” che debutta con enorme successo al Theater an der Wien (quattrocento rappresentazioni di fila e una testimonianza di Alma Mahler che nel suo diario racconta: “Una sera sono andata con mio marito Gustav a vedere l’operetta; ci siamo molto divertiti e poi a casa abbiamo ballato, per così dire a memoria, il valzer di Lehar”) e lo rende famosissimo e ricco in un batter d’occhio.
Il denaro guadagnato rapidamente, come spesso succede agli artisti, lui lo investe in azzardate operazioni finanziarie alla borsa di Vienna e lo perde con altrettanta velocità.
Però Lehar, artista sì, ma non scemo, impara la lezione e in poco tempo, grazie a una quantità di altre composizioni di successo e a investimenti più saggi, ridiventa ricco, anzi ricchissimo, anzi uno degli uomini più ricchi di Vienna. Si compra un castello e una villa, e apre anche una sua casa editrice musicale.
Una curiosità a proposito delle sue operette: ognuna la dedica a un paese del mondo: “Paganini” naturalmente all’Italia; “Amore di Zingaro” all’Ungheria; “La Vedova Allegra” al Montenegro; “Frasquita” alla Spagna; “Fredericke” alla Germania; “Lo Tsarevich” alla Russia; “Il Paese del Sorriso” alla Cina.
Franz è alto un metro e sessantacinque, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi. Parla e scrive il tedesco, l’ungherese, e il boemo. Poi, quando va a Pola, impara anche l’italiano e diventa amico di Puccini.
Nel ’21 sposa una signora ebrea, e da lì a qualche anno questo diventerà un problema, ma per Lehàr, non così grave, come vedremo, come lo sarà per altri cittadini del Reich.
Infatti, arrivato il nazismo, non scappa all’estero come fanno tanti altri: lui rimane a Vienna. Anche se rifiuta di entrare in politica riesce ad avere la costante protezione di Hitler che, fin dall’inizio dichiara la Vedova Allegra superiore a qualsiasi altra opera. La promuove, la sostiene, la fa rappresentare e questo naturalmente fa molto bene alle finanze e anche alla incolumità di Franz.
Addirittura (forse sempre grazie alla Vedova Allegra) sua moglie viene tutelata come Ehrenarierin (ariana onoraria per matrimonio) e salva la pelle.
Nel 1943 a Monaco, Hitler organizza una rappresentazione della Vedova per alcuni amici e Lehar gli regala per l’occasione una copia firmata del programma della prima rappresentazione del 1906, su cui appare una foto del tenore Treumann, all’epoca protagonista nella parte di Danilo.
Gasato, guarda caso, pochi giorni prima nel campo di sterminio nazista di Theresienstadt.
Questa associazione con il dittatore è rimasta come un’ombra sul nostro compositore che era, sì apolitico, sobrio, dal basso profilo, ma certo qualche vantaggio ne ha avuto.
Ma chi potrebbe dargli torto per aver cercato di arrangiarsi in un periodo come quello?
N° 632 Microbiografie Irrispettose - Domenico Cimarosa 1749 - 1801

“Egli diventò veramente quel prototipo di musicista italiano errante, da contrapporre al sedentario compositore tedesco…una specie di modello di moto perpetuo…sempre per strade e per cammini, oggi qua, domani là”
All’epoca infatti l’autore di un’opera dirigeva l’orchestra sedendo al cembalo per le prime due o tre rappresentazioni, poi partiva al seguito della compagnia in giro per le corti del circondario. E così via a ogni debutto.
Domenico nasce ad Aversa in una famiglia poverissima, figlio di Anna, lavandaia e di Gennaro, muratore. A un certo punto, in una di quelle migrazioni di poveri all’inseguimento del pezzo di pane, vanno tutti a Napoli perché il padre ha trovato lavoro nella fabbrica della nuova reggia di Capodimonte.
Ma la faccenda ha uno sviluppo drammatico perché papà cade dall‘impalcatura e muore precipitando (e non è una battuta) se stesso e la famigliola in una miseria talmente profonda che mamma Cimarosa è costretta ad affidare il piccolo Domenico ai frati del Pendino, presso i quali almeno non muore di fame e soprattutto si impadronisce dei primi elementi di educazione musicale con un tale profitto, che gli stessi frati, stupefatti, riescono a infilarlo nel conservatorio della Madonna di Loreto come orfano sprovveduto di ogni mezzo materiale, ma ricco di doni spirituali.
In un attimo diventa un superbo virtuoso di violino, organo e clavicembalo, nonché un eccellente cantante e un operista di sicura ispirazione.
Raggiunge presto un tale livello da essere esentato dal filtro del ciambellano che ha il compito di “minutare” le opere messe in scena alla corte di Napoli, cioè di controllare che non siano troppo lunghe per non rischiare di annoiare il re, che invece, Domenico lo vuole ascoltare tutto, dall’inizio alla fine.
E arriva anche per lui, come per tanti altri colleghi dell’epoca il momento di affrontare quell’esperienza forse non sempre portatrice di fama, ma di quattrini sì: la stagione in Russia alla corte di Caterina II. Così se ne parte senza fretta, determinato a sfruttare ogni miglio di quella lenta traversata cosparsa di tabacchiere (intendendo i doni, appunto molto spesso tabacchiere d’oro, con cui i nobili stanziali sull’itinerario compensano gli artisti di passo) che alla fine di qualche mese lo avrebbe portato a Pietroburgo. Tre o quattro anni e poi, con in tasca una bella sommetta, se ne riparte per tornare a casa.
Passa da Varsavia e si ferma a Vienna dove per il nuovo imperatore Leopoldo II compone e mette in scena quello che diventerà il suo capolavoro: “Il matrimonio segreto”. Che provoca un tale entusiasmo che l’Imperatore stesso, la sera della prima, pretende che sia bissato per intero, e versa sull’unghia al fortunato compositore ben 1.350 fiorini. Quando “Il Matrimonio segreto” arriva a Napoli insieme al suo autore, nel 1791, viene replicato più di cento volte senza interruzione. Sono numeri da rockstar del ‘700.
Purtroppo, da persona poco pratica a barcamenarsi nei subbugli politici, incappa nell’arrivo dei napoleonici a Napoli e nell’istituzione della Repubblica Partenopea alla quale dà un maldestro appoggio componendo un inno antimonarchico, di cui dovrà ben presto pentirsi, eseguito ai piedi dell’Albero della Libertà dagli studenti dei conservatori napoletani.
Poi inciampa nella restaurazione, durante la quale pare che gli devastino la casa buttandogli il clavicembalo dalla finestra e in più si avventura a comporre un altro inno, questa volta in favore della monarchia, intitolato “Bella Italia”. Ma fa ancora di peggio: scrive la “Cantata per Ferdinando – espressamente composta dal sig. D. Cimarosa in occasione del bramato ritorno di Ferdinando nostro amabilissimo sovrano”.
E qui commette un errore di etichetta che rovinerà i suoi ultimi giorni: questa musica la dedica al re senza prima avergliene chiesto il permesso, in più fregiandosi abusivamente del titolo di “Maestro di Cappella all’attuale servizio di Sua Maestà”.
Sua Maestà si offende a morte dichiarando che: “davvero non sa comprendere come quel tal Cimarosa, dopo aver servito la Repubblica e battuto la musica sotto quell’infame albero della libertà, abbia osato scrivere un simile componimento, ove con sorpresa ha la Maestà Sua veduto posta in scena la sua Real Persona senza averne dato il permesso”.
Insomma, alla fine il poveretto finisce in galera per quattro mesi e appena liberato viene vivamente consigliato di cambiare area; così se ne scappa a Venezia, dove ha ancora degli amici e soprattutto ha in piedi una commissione da parte della Fenice per l’opera, “La Artemisia”, che però non farà in tempo a vedere messa in scena.
Infatti, poco dopo l’arrivo a Venezia muore in modo inaspettato e questo, insieme ad alcuni sintomi sospetti, fa partire voci su un suo presunto avvelenamento ordinato da lontano dalla sua arcinemica, la regina Maria Carolina di Napoli.
Opportunamente, a tamponare le voci arriva negli stessi giorni un certificato ufficiale redatto dal medico di Pio VII, Giovanni Piccioli, che lo dichiara “…passato agli eterni riposi in conseguenza di un tumore che avea nel basso ventre, il quale dallo stato scirroso è passato allo stato canceroso.”
Esequie solenni, sfarzo di torce, musica e immenso concorso di popolo.
E buona notte ai suonatori.
N° 631 - Microbiografie Irrispettose - Giuseppe Verdi 1813 - 1901

Della sua musica hanno scritto, scrivono e scriveranno persone ben più competenti di noi, quindi non ci proviamo nemmeno. Ci interessano, incuriosiscono, divertono invece le notiziole, anche i pettegolezzi gustosi e colorati che insaporiscono la sua biografia.
Un contadino, ecco chi era Giuseppe Verdi. Ricco, non si sa se di diritti d’autore più che di frutta e granaglie. In realtà, certo che lo sappiamo, come vedremo in seguito, perché non c’è dubbio che renda di più un’Aida che un campo di carciofi.
Era davvero figlio di un contadino di Roncole che gestiva un’osteria e il resto del tempo lavorava nei campi. Una delle civetterie del Maestro Verdi fu sempre di raccontare di essere discendente di braccianti umilissimi. Invece i suoi erano piccoli possidenti con un occhio alla cultura, tanto è vero che appena si accorsero del potenziale che avevano fra le mani non fecero finta di niente, anzi lo sbocciare del talento del piccolo genio fu sì miracoloso, ma anche discretamente aiutato in famiglia.
Quello che è abbastanza anomalo per un artista è l’oculatezza con cui il maestro ha sempre saputo calibrare e ottenere compensi adeguati, spesso addirittura straordinari, per le sue due passioni.
La terra: Nel 1844 compra 23 ettari con casa colonica che mette subito a cultura con la sua esperienza personale, ma anche con l’aiuto di mezzadri e lavoranti. Ci aggiunge una casa per i genitori e Palazzo Orlandi a Busseto, dove va a vivere, con Giuseppina, non ancora sua moglie, accompagnato naturalmente da parecchie maldicenze locali, tacitate solo dopo il solito matrimonio riparatore. Nel ’48, dopo un periodo massacrante di lavoro che lui chiama “gli anni di galera”, compra il fondo e le case di Sant’Agata, una proprietà molto più ampia, che continuerà a ingrandire, e qui costruisce la sua casa definitiva, Villa Verdi, dove abiterà per mezzo secolo, ritornandoci appena può. E’ fra i primi a introdurre la coltivazione dei cachi. Si occupa di pioppicultura, di allevamento di cavalli, si interessa di irrigazione, di produzione di vino…
E’ anche vero che quando viaggia non si nega alberghi di lusso, come il Grand Hotel di Milano, dove nel 1901 muore, in cui dispone di camere fisse anche per i domestici e addirittura di una cucina con cuoco personale.
La musica: da bambino suona l’organo in chiesa, ma già riesce a farsi dare un piccolo compenso. Da grande “I Lombardi” ed “Ernani” gli fruttano, insieme, 12.000 lire; “Attila” e “Macbeth” 18.000 lire l’uno. Nel 1860 gli arriva un’offerta di 60.000 franchi più tutte le spese di allestimento dal Teatro imperiale di San Pietroburgo per “La forza del destino”.
Ma il top Verdi lo raggiunge con la commissione del Khedivè d’Egitto per l’Aida, che rimane uno dei contratti più favolosi che un musicista sia mai riuscito ad ottenere. (forse Celine Dion, i Rolling Stones hanno fatto meglio? Mah!). L’unico obbligo è la consegna: gennaio 1871, per l’apertura del Canale di Suez. Tutto il resto è un regalo. I diritti per il mondo intero, Egitto escluso, rimangono a lui; in più riceve un premio di partitura di 150.000 franchi oro, ha la libertà di scegliere i cantanti, l’orchestra, il direttore, il librettista; e soprattutto sa che razza di lancio sia questa operazione: per la fama e i quattrini! (come nota con piacere anche l’editore Ricordi).
Nel frattempo diventa non solo un grande musicista ma anche un simbolo. Non dimentichiamo i suoi non numerosi ma appassionati interventi nella vita politica dell’Italia che sta nascendo proprio allora (per quei pochi che ancora non lo sanno ricordiamo anche la scritta antiaustriaca che copre i muri all’epoca: il famoso Viva V.E.R.D.I. (Viva Vittorio Emanuele Re D’Italia).
Ogni volta che sta per finire un’opera gli spunta puntuale un malanno: un fortissimo mal di gola: come se si fosse stancato a cantare tutte le parti. Dopo la prima, passa.
Verdi ha un solo allievo, di qualche anno più giovane, anche lui figlio di contadini, Emanuele Muzio, che lo segue come collaboratore, scudiero, adoratore, (è lui che dirige la prima di Aida al Cairo) ma non fa in tempo a dedicargli la vita intera: muore dieci anni prima del maestro.
A proposito della bocciatura di Verdi al conservatorio di Milano, da tutti citata come esempio della stupidità delle istituzioni, ci è arrivato un sintetico giudizio dell’esaminatore: “L’allievo Verdi avrebbe bisogno di cambiare posizione della mano, locché, all’età di 18 anni si renderebbe difficile.” Quindi è bocciato come pianista, ma approvato, in un’altra nota, come compositore: “Applicandosi con attenzione e pazienza alla cognizione delle regole del contrappunto potrà riuscire plausibilmente nella composizione”.
Un bel giorno, durante le prove del Nabucco a Parma, proprio all’epoca quando conosce e si fidanza con Giuseppina Strepponi, gli cade di mano il libretto che si apre, guarda caso, sul “Va’ pensiero”. Colpo di fulmine (per Giuseppina e per il testo); il tema sgorga e alla Scala l’opera viene replicata 57 volte di seguito, una cosa mai successa prima.
Siamo al Rigoletto. Per tutto il periodo prima del debutto il tema de La donna è mobile viene provato in camerino, rigorosamente a porte chiuse, perché un’aria così felice potrebbe scivolare fuori, arrivare a orecchie indiscrete e bruciare la sorpresa.
La Traviata fallisce alla Fenice di Venezia per l’immoralità del soggetto, riconosciuta e stigmatizzata non dai critici ma dal pubblico. L’anno dopo trionfa al teatro S. Benedetto, sempre a Venezia e Verdi commenta, seccato: “Tutto quello che avete sentito alla Fenice c’era anche qui al S. Benedetto. Allora fiasco, ora furore. Giudicate voi”
Il debutto del suo ultimo capolavoro, il Falstaff alla Scala è un successo clamoroso con i biglietti venduti a trenta volte il prezzo e tutta Europa presente. Bis su bis e un’ora di applausi. Verdi portato in trionfo quando torna al Grand Hotel dopo lo spettacolo.
Per concludere, sul suo precoce talento c’è una simpatica e sgrammaticata nota dell’artigiano di Busseto che gli aggiusta la prima spinetta: “Fatti di nuovo gratuitamente questi saltarelli e la pedaliera che ci ho regalato vedendo la buona disposizione che ha il giovanetto Giuseppe Verdi, che questo mi basta per essere del tutto pagato”.
N° 630 - Microbiografie Irrispettose Georg Friedrich Haendel 1685 1759-

Georg Friedrich nasce, come si dice, in una buona annata, ovvero la stessa di Bach e di Scarlatti, mica gentucola. Grande compositore, grande drammaturgo, grande impresario e uomo di grande successo sociale e commerciale. Nella vita gli andrà tutto bene, tranne una complicazione negli ultimi tempi: la cecità (probabilmente una forte cataratta che oggi sarebbe curabile con pochi minuti di laser).
Papà, che lo ha a 63 anni, è un barbiere-chirurgo di grande successo alla corte di Sassonia, deciso, come in molte altre biografie di musicisti, a fare di suo figlio un avvocato e nello stesso tempo allarmato dalla evidente inclinazione del ragazzino per la musica.
Niente da fare: il giovane Georg riesce a contrabbandare un piccolo clavicordo in soffitta e lì passa le nottate ad esercitarsi mentre la famiglia dorme. Dobbiamo immaginare le grandi case dell’epoca piene di botole, scale e scalette, abbaini e porte segrete, dove era facile nascondere attività illecite anche se innocenti.
Alla fine il talento emerge e trionfa in un viaggio di tutta la famiglia alla corte del Duca Giovanni Adolfo di Schwartzenberg durante il quale il piccolo virtuoso si arrampica sullo sgabello dell’organo della cappella e stupisce tutti con la sua bravura.
Il Duca naturalmente riesce a convincere papà a farlo studiare e il gioco è fatto.
Cominciano i vagabondaggi da un’orchestra all’altra finché arriva come strumentista all’Opera di Amburgo. E qui assistiamo alla prima dimostrazione pubblica del caratteraccio di Haendel: la famosa scazzottata con Mattheson. Si esegue la “Cleopatra” di Mattheson che canta la parte di Antonio, mentre Haendel è al cembalo. A un certo punto è previsto che Mattheson sostituisca Haendel alla tastiera; quest’ultimo si rifiuta di cedergli lo sgabello. Scoppia la rissa e i due finiscono a riempirsi di legnate rotolando sulla scena fra le risate del pubblico. All’uscita del teatro Mattheson schiaffeggia Haendel e i due tirano fuori le spade e si mettono a duellare sulla piazza. La spada di Mattheson puntata al cuore dell’altro si spezza su un bottone della giubba (c’è chi dice contro una partitura provvidenzialmente arrotolata sotto la camicia) e la gazzarra finisce con una rappacificazione generale che poi diventerà un’amicizia per tutta la vita.
Cambiamo aria. Per tre anni Haendel gira per l’Italia dove, specialmente a Roma, si appoggia anche lui a quei personaggi che incontriamo in tutte le biografie dell’epoca. Il cardinale Ottoboni, il Principe Ruspoli, i cardinali Pamphilij e Colonna; insomma quei benedetti nobili e prelati di gran gusto e altrettanta ricchezza che fra il Sei e il Settecento tanto hanno fatto per mantenere in vita nutrendoli e in stato di creatività finanziandoli, praticamente tutti gli artisti di passaggio e anche quelli stanziali.
E poi, il colpaccio: Londra. In Inghilterra Haendel trova la terra promessa. Diventa il musicista ufficiale della famiglia reale inglese. Parte con una intensissima produzione di oratori (famoso oggi come allora il suo Messia) e di musiche operistiche e celebrative: la sua “Aci e Galatea” è l’opera più rappresentata dell’epoca; nel luglio 1717 eseguono la sua “Musica sull’acqua” sul Tamigi ben tre volte di seguito per il re e i suoi ospiti; alla prima della sua “Musica per i reali fuochi d’artificio” assistono dodicimila persone!
E’ ricco e lo diventa ancora di più con la sua oculata gestione di opere e altri spettacoli musicali che allestisce a getto continuo. Malgrado la sua abilità di investitore, pare che anche lui abbia avuto, come moltissimi altri inglesi, qualche dispiacere nel 1720 allo scoppio della bolla finanziaria cresciuta sulla società di commerci internazionali South Sea. Ma sopravvive.
Non si sposa e poco si sa della sua vita privata. Alla sua morte lascerà gran parte della sua ricchezza alla nipote Johanna. E’ anche un collezionista di arte; i suoi quadri, messi all’asta fruttano una bella somma.
Da giovane pare che fosse bellissimo: alto, snello, biondo con gli occhi azzurri, ma dotato di quel famoso carattere terribile, di cui perfino i reali avevano paura. Guai arrivare tardi a una sua rappresentazione o chiacchierare a un suo concerto!
Nel 1750 in un viaggio di ritorno dalla Germania si ferisce gravemente in un incidente di carrozza. Da quel momento la sua salute comincia a vacillare. Peggiora anche la vista, prima all’occhio sinistro, poi anche all’altro.
Era un’epoca in cui i medici invece di salvare i pazienti li ammazzavano. Haendel si rivolge al famoso chirurgo William Bromfield il quale interviene sulla sua probabile cataratta e naturalmente dall’operazione il poveretto non solo non ha nessun miglioramento, ma ne esce quasi cieco. Non contento, subito dopo si affida a un altro macellaio, il sedicente “ophthaliater” John Taylor, il quale otto anni prima aveva operato anche Bach con il risultato di non fargli comunque riacquistare la vista e probabilmente di ucciderlo con un’infezione indotta dai suoi ferri sporchi. Anche in questo secondo tentativo per Haendel il risultato è catastrofico.
Alla fine muore, cieco del tutto, nella sua casa di Londra per un ictus, sepolto con tutti gli onori niente di meno che nell’Abbazia di Westminster, dopo aver assistito all’ultima esecuzione del Messia.
A proposito di questa composizione che si identificherà poi per sempre con il suo nome, nel primo centenario della morte la eseguono al Crystal Palace 2.765 cantanti e 460 strumentisti per un pubblico di 10.000 spettatori. E da allora è sempre rimasta la colonna sonora di incoronazioni, funerali, celebrazioni, insomma tutto ciò che deve avere una veste trionfale e maestosa. Un vero monumento al suo creatore.
N° 629 - Microbiografie Irrispettose - Gli Scarlatti

ALESSANDRO 1660 – 1725
“Alessandro Scarlatti è un grand’uomo, e per essere così buono, riesce cattivo, perché le compositioni sue sono difficilissime e cose da stanza, che in teatro non riescono; in primis chi s’intende di contrapunto le stimerà, ma in un’udienza d’un teatro di mille persone, non ve ne sono venti che l’intendono.” Così un cronista contemporaneo, il conte Francesco Zambeccari, sistema il nostro eroe.
Alessandro nasce a Palermo figlio, fratello e più tardi anche padre di musicisti, fra cui il notissimo Domenico, clavicembalista egregio. Con la sorella Anna Maria, cantante, si trasferisce a Roma e lì comincia subito a farsi notare. A diciotto anni è maestro di cappella a S. Giacomo degli Incurabili, a diciannove, nel Carnevale, ha grande successo con un’opera che gli conquista il favore della regina Cristina di Svezia la quale lo assume seduta stante al suo servizio, una posizione che, insieme all’amicizia con Bernini, lo lancia definitivamente sulla scena del mondo che conta.
Il nuovo Viceré di Napoli lo chiama a corte come maestro della Real Cappella. E’ una apertura verso un elemento esterno che purtroppo indispone i musicisti napoletani contro di lui. Alla morte di Re Carlo ci si mette anche l’instabilità politica per convincerlo che è più prudente allontanarsi e fare ritorno a Roma.
Dove, grazie alla protezione del cardinale Ottoboni, inonda dei suoi oratori la Chiesa Nuova, il palazzo della Cancelleria, il Seminario Romano, il Palazzo Ruspoli.
Poi però torna al suo luogo del cuore, Napoli, e lì rimane, anche se, poco prima di morire deve mandare una supplica al Viceré per chiedere un aumento del suo stipendio diventato insufficiente.
Scarlatti scrive più di ottocento cantate. Questo numero impressionante si spiega forse con il fatto che in quegli anni papa Innocenzo XII ha vietato l’opera nei teatri di Roma e allora per ascoltare musica vocale non rimangono che i palazzi privati dei soliti principi o cardinali, che spesso, come l’Ottoboni firmano i testi, magari sotto pseudonimo.
Per la propria promozione professionale e sociale Scarlatti è insuperabile nel trovare i luoghi e le occasioni in cui farsi ascoltare. Un esempio fra tanti, dal verbale dell’Arciconfraternita di S. Carlo del 14 gennaio 1680: “Perché la chiesa si trova poco disponibile a simil spesa, il Sig. Alessandro Scarlatti, Maestro di Cappella della Maestà di Svezia si esibisce fare la musica per la messa in detta funtione non solo a proprie spese e senza ricompensa alcuna, ma farla solennissima e colma di perfettissimi virtuosi”.
E i padrini di battesimo? Tutti quelli a cui affida i suoi numerosi figli sono nobili: la Principessa di Colobrano, il Duca Carafa di Maddaloni, il Principe di Avellino, la Principessa Sanseverino, e così via di corona in corona. Forse arrampicamento sociale, certo necessità dei tempi.
In questo periodo arrangia per il teatro parecchie opere veneziane adattandole all’uso napoletano, il che significa dare maggior rilievo ai personaggi buffi perché, a quanto pare, quello vuole il pubblico del sud.
E continua a produrre, scrivere e creare finché muore portandosi dietro un così ricco alone di gloria che perfino la Principessa Orsini dichiara che non tener per casa composizioni di Scarlatti “n’est pas pardonnable a un homme de bon gout”.

DOMENICO 1685 – 1757
Cinquecentocinquantacinque. Non una di più né una di meno. E’ il numero monumentale di una raccolta di sonate per clavicembalo destinate a diventare immortali.
L’architetto di questo capolavoro è Domenico Scarlatti, sesto dei dieci figli di Alessandro, portato al battesimo dal duca Don Marzio Carafa (era un’abitudine di papà, come abbiamo raccontato, scegliere padrini di alto livello) e abbondantemente spinto verso la musica dal fratello Filippo, clavicembalista, dalle zie Anna Maria e Melchiorra, cantanti e dallo zio Francesco, compositore.
Già a quindici anni è organista della Cappella Reale di Napoli. Convinto delle qualità del figlio, il padre Alessandro lo manda a Venezia in compagnia del castrato Grimaldi, con tappa a Firenze sperando che gli riesca di acchiappare un impiego presso il principe Medici.
“Io l’ho staccato a forza da Napoli, dove, benché avesse luogo il suo talento, non era talento per quel luogo. L’allontano anche da Roma perché Roma non ha tetto per accogliere la musica; chi ci vive, mendica. Questo figlio ch’è un’aquila cui son cresciute l’ali non deve stare ozioso nel nido, ed io non devo impedirgli il volo”.
Questa orgogliosa opinione di padre non serve a ottenere all’aquilotto nessun incarico a Firenze o a Venezia, quindi Domenico torna a Roma, dove è tornato anche il padre e dove dà prova della sua abilità di strumentista in una sfida a Palazzo Ottoboni stracciando il grande Haendel alla tastiera del clavicembalo (Haendel però lo straccia a quella dell’organo).
Ci sono anche testimonianze dell’attività di Domenico come cantante nei saloni dei grandi palazzi gentilizi. All’epoca un musicista doveva sapere fare di tutto!
Nel 1719 se ne va a Lisbona “pazientemente atteso dal re” che lo aveva scritturato come compositore e maestro di musica della famiglia reale, per i cui onomastici e compleanni deve fornire serenate e cantate. Nel ’27, grazie a un simpatico sussidio regale di mille scudi, se ne torna a Roma per sposare, lui quarantaduenne, Maria Caterina, bella romanina di sedici anni.
Nel 1746 il nuovo re di Spagna chiama a Madrid Domenico, sempre con la mansione di maestro di musica della famiglia reale. Qui parte una bella e lunghissima amicizia e collaborazione fra lui e il castrato Farinelli, chiamato a occuparsi della direzione delle opere in musica e delle feste reali.
Per fortuna a un certo punto, incoraggiato, anzi spinto dalla Regina, Scarlatti si mette al lavoro per radunare, catalogare e far copiare (a mano, perché allora non c’era altro modo di salvare la musica scritta) le sue cinquecentocinquantacinque sonate in una serie di preziosissimi volumi.
Almeno cinque anni dura il lavoro dei copisti, fra cui il famoso Joseph Alaguero, ma ne viene fuori una magnifica opera, poi in parte finita in mano a Farinelli e in seguito, anche se divisa, al sicuro nella Biblioteca Marciana di Venezia, in quella di Firenze, a Parma, a New York, a Londra.
Le sonate di Domenico Scarlatti continuano a essere stampate e ristampate, suonate e risuonate e raccolgono da tre secoli un numero impressionante di ammiratori: Bach, Haendel, Clementi, Mozart, Beethoven, Czerny, Liszt, Chopin, Mendelssohn, Brahms, Verdi, Debussy, Bartok, Shostakovich, Casella……
N° 628 - Microbiografie Irrispettose - Hector Berlioz 1803 - 1869

Hector è un ipersensibile chiacchierone esibizionista che ha la fortuna di nascere in un’epoca in cui vanno molto questi tipi esagerati e viziati a cui lui corrisponde perfettamente.
È anche uno strano genere di musicista. Intanto non sa, né mai imparerà a suonare bene il pianoforte. Strimpella su una chitarra e fino ai 12 anni non capisce neanche cosa sia una nota scritta. Ma la musica gli piace.
Suo padre, un uomo rigido, e la madre, una bigotta fanatica anche se mondanissima, lo mandano a Parigi per studiare medicina e lui, proprio a Parigi, che è il centro di tutte le arti, perde interesse per la scienza e si butta nella musica.
Papà appena lo sa, gli taglia i fondi e mamma gli toglie il saluto e il povero ragazzo senza un soldo è costretto a fare il corista al teatro del ginnasio.
Finalmente riesce a iscriversi al conservatorio dove comincia furiosamente a concorrere al Prix de Rome, il premio soggiorno di due anni a Villa Medici che tutti gli studenti francesi sognano di vincere. Non è facile, tanto più che il direttore del conservatorio, Cherubini, lo ha in somma antipatia, lui e la sua musica. Gli ci vogliono cinque tentativi; alla fine ce la fa. Ma Roma non gli piace e non gli piace la musica italiana.
Intanto, anche se è occupato senza successo nel suo frenetico corteggiamento di Harriet (di cui parleremo in seguito) gli capita la prima delle sue disavventure sentimentali. Si è invaghito di una signorina che, quando lui vince il premio nel ’30, gli dimostra un particolare interesse e gli fa intravvedere qualche possibile concessione futura, ma appena lui parte per Roma gli soffia il posto all’Accademia, e poi sposa Monsieur Pleyel, fabbricante di pianoforti.
Torniamo indietro un attimo. Nel ‘27 va a una rappresentazione dell’Amleto e qui, da una poltrona di prima fila, si infatua perdutamente dell’attrice irlandese Harriet Smithson che invece sta sul palcoscenico. Comincia a corteggiarla, sempre più insistente, le scrive, le manda fiori, va a tutte le sue recite, affitta un appartamento vicino a dove abita lei in modo da controllarla quando esce e quando rientra. La pensa, la sogna, la vuole. Arriva a comporre la sua Sinfonia Fantastica dedicandola a lei. Dura quattro anni, di cui due da Roma dove sta vivendo il suo premio, questo vero e proprio stalkeraggio.
E per quattro anni Harriet lo snobba convinta. Finché, nel ’32 un amico comune la porta a un concerto a sentire la Sinfonia Fantastica e glie ne racconta l’ispirazione. Naturalmente la storia le piace, è lusingata, cambia idea, lo invita a casa. Diventano amanti e alla fine, contro le due famiglie e tutti gli amici, si sposano e hanno un figlio.
Lieto fine? Macché. Lui è sulla via della fama, lei invece ne sta uscendo e alla fine si ritira dalle scene, cade preda di una patologica e possessiva gelosia, si dà all’alcool e le sue sfuriate spesso mandano al pronto soccorso il povero Berlioz che la ama ancora ma a un certo punto non ce la fa più, e si trova un’altra, una cantante lirica, tale Maria Rocio. Harriet se ne va di casa e muore, paralizzata e in miseria, ma Berlioz non la dimentica e prima di morire chiede che il corpo di lei sia riesumato e messo a giacere accanto al suo.
Nel 1839 gli eseguono l’”Harold in Italia”. Paganini che ha assistito al concerto è così ammirato che gli manda un assegno di ventimila lire: un gradito sollievo per il povero autore.
Il quale, invece di pagare la pigione e il droghiere con quei soldi, scappa di casa con la sua nuova fiamma, abbandonando moglie e figlio. Se ne vanno in Germania dove Berlioz conosce Wagner, con il quale nasce un’amicizia che durerà pochissimo: caratteri incompatibili.
I soldi naturalmente finiscono subito; così Hector comincia una sarabanda di concerti che vanno ora bene ora malissimo, ma il cui incasso non è mai sufficiente. Si rimette a scrivere articoli di musica e relazioni di viaggio, attività nella quale il suo spirito, il suo acume critico e la sua onestà intellettuale non cesseranno mai di brillare, e pubblica il suo giustamente famoso “Trattato d’Istrumentazione” dedicandolo al re di Prussia.
Fa un salto in Russia, da cui torna con in tasca qualche rublo. Di nuovo a Parigi, mette in scena “La Dannazione di Faust” ma la serata va male: diluvia e la gente rimane a casa. Insomma, devono intervenire gli amici con prestiti a lunga durata (e improbabile restituzione).
Compone sempre meno e a un certo punto si ritira perfino dal giornalismo che gli aveva dato grandi soddisfazioni, una meritata fama, e anche gli spiccioli per sopravvivere.o rta Henrietta, Berlioz ha sposato la sua seconda fidanzata, che dopo poco muore anche lei. Muore anche il figlio, di cui era riuscito a recuperare l’affetto dopo averlo abbandonato anni prima. Una tragedia dietro l’altra.
E finalmente arriva anche il suo turno. Mai del tutto compreso, non ricco ma non più miserabile, originale scrittore di critica, padre dell’orchestra moderna, però stanco e sconsolato della vita, a un amico che al suo letto di morte gli racconta della gran folla presente all’ultimo concerto: “Loro vengono – dichiara – ma io me ne vado”.
Sipario.
N° 627 Microbiografie Irrispettose - Igor Stravinskij 1882 - 1971

“Dice: la mia “Sagra”, il mio “Uccello di Fuoco” come un bambino direbbe: la mia trombetta, il mio cerchio. È proprio un bambino viziato che ogni tanto mette le dita nella musica. Si aggira come un giovane selvaggio con cravatte da pugno in un occhio, baciando la mano alle signore mentre pesta loro i piedi. Da vecchio sarà insopportabile, ma per ora è straordinario.”
È il suo amico del cuore, Debussy, che ci racconta Stravinskij ancora giovane, ma già immortale.
Campione di eccessi, in quattro anni diventa il musicista più discusso, più controverso, più disprezzato ma anche il più famoso del mondo. 1910: “L’Uccello di Fuoco”; 1911: “Petruska”; 1913: “La Sagra della Primavera”.
Un crescendo di furia creativa che culmina il 29 maggio del ‘13 (lui ha trentun anni) con la prima della “Sagra”.
Più che di una serata teatrale si tratta di una furibonda battaglia con urla, fischi e scazzottate fra il pubblico, che gli regala un clamoroso successo, già nell’aria ma che esplode definitivo in quella occasione.
Dopo, non torna più in Russia e comincia a vagabondare per l’Europa: Svizzera, Francia, Italia per poi passare l’Atlantico e stabilirsi in USA dove rimarrà fino alla morte, travolto dalla gloria. Con un imbarazzante incidente: il 14 ottobre del 1941 in un concerto a Boston dirige un suo arrangiamento dell’inno americano. Immediato intervento della polizia che minaccia di arrestarlo per aver trasgredito una legge del ‘700 che ne proibiva qualunque trascrizione.
Igor è figlio di un padre autoritario, e questo fin dall’infanzia gli crea un difficile rapporto con la famiglia, che si porterà dietro tutta la vita. Comunque si sposa un paio di volte e ha quattro figli. Lo studio della musica lo comincia tardi e lo prosegue in maniera intermittente (fra i suoi insegnanti Rimskij Korsakov), tanto è vero che alla fine si dichiara autodidatta.
Quello che conta veramente nella sua vita è l’incontro con Djagilev, l’organizzatore della compagnia dei Ballets Russes, che gli commissiona, in collaborazione con Fokine coreografo e Picasso scenografo, le musiche dei tre balletti che, come abbiamo visto lo lanciano nella stratosfera della notorietà.
Appena diventato famoso, interpreta la parte fino in fondo e la mondanità sa benissimo come cavalcarla. Bello non è, ma è fotogenico; un vero uomo di mondo, molto chiacchierato per le sue presunte avventure con signore della buona società, fra cui Coco Chanel. Sarà vero? Intanto, nel ’20 e con tutta la famiglia, si trasferisce per un lungo soggiorno proprio nella villa di lei, vicino a Parigi.
È l’ospite più richiesto di ogni festa, ogni cena, ogni spettacolo in ogni città del mondo, l’orgoglio di ogni padrona di casa e ogni direttore di teatro, e questo sembra autorizzarlo a permettersi qualunque malignità ai danni dei suoi colleghi.
Richard Strauss: “Sciropposo”. Hindemith: “Indigesto come un pezzo di cartone”. Wagner: “Dopo un quarto d’ora non ce la facevo più”. Rachmaninov: “La sua musica? Acquerelli”. Glazunov: “Un pesante accademista teutonico” e, in più “L’uomo più antipatico che ho conosciuto”, e così via spettegolando.
Tanto per gradire, ecco di ricambio il giudizio di Adorno su di lui: “Stravinskij è un acrobata, un funzionario statale, un manichino da sarta; psicotico, infantile, fascista e devoto solo al denaro”.
In compenso va in brodo di giuggiole per Mussolini (riportiamo da Zaccagnini “Una storia dilettevole della musica”): “Mussolini è un uomo formidabile. Non credo che qualcuno abbia per Mussolini una venerazione maggiore della mia. A meno che le orecchie non mi ingannino, la voce di Roma è la voce del Duce”
Stravinskij non smette mai, letteralmente, di buttare giù musica, neanche negli ultimi anni della sua vita, passati quasi tutti fra cliniche e ospedali. Ecco come, non senza un certo ottimismo, interpreta le sue trombosi ricorrenti: “Colpi che contribuiscono a dischiudere i più remoti nascondigli della mia memoria e a spargere un prodotto chimico rigeneratore sul palinsesto del libro dell’infanzia”.
Nei momenti che gli lasciano liberi i ricoveri clinici dirige, ma seduto, perché ormai il corpo non lo regge più. Accoglie con interesse, ma non riuscirà a realizzarla, l’offerta della BBC di scrivere una musica da associare all’immagine di un occhio dipinto da Picasso, per usarla come sigla di un nuovo canale a colori. Durata: sei secondi!
Il suo è un calvario: emboli, ulcere, polmoniti, tubercolosi e più dolorosa di tutte, la proibizione dei medici di sedersi al pianoforte per comporre. A questo proposito, pochi giorni prima della fine: “Mi piace comporla, non ascoltarla, la musica. È tutta la vita che sono perseguitato dalle mie opere, ma delle mie opere non mi importa nulla. M’importa solo comporre. E adesso non posso più farlo” e muore.
Sarà sepolto accanto a Djagilev, nella limpida luce della laguna, all’Isola di S. Michele, il cimitero di Venezia.
N° 626 - Microbiografie Irrispettose - Pietro Mascagni 1865 - 1945

Collezionista. Maniaco. Quasi accumulatore seriale di: penne, sigari, sigarette, fiammiferi, banconote fuori corso, assegni, medaglie, pergamene, bacchette da direttore d’orchestra, pipe, bocchini, cravatte, bastoni, orologi, strumenti musicali…sfinita dall’immensità di questo elenco la figlia Emy Mascagni, nel suo libro su papà Pietro, racconta la sua smania di raccogliere di tutto.
E le passioni?
Intanto l’eleganza. È il punto di riferimento per i giovanotti dell’epoca. I suoi vestiti, i colletti duri, le scarpe, la pettinatura, l’essere perfettamente rasato in un’epoca di baffi e barbe abbondanti (voci maligne dicono che è perché a lui non crescono abbastanza).
È fissato con la bicicletta e il tamburello. Gioca a scopone e a biliardo ed è il tipo che costringe amici e parenti a interminabili tornei fino a notte inoltrata. Un tormento, dal quale nessuno si permette di svicolare.
La povera Emy è fra le sue vittime “Per parte mia tremo ogni volta che il babbo mi invita a giocare con lui e faccio patti chiari: fino a che mi chiama idiota, sopporto; in casi eccezionali anche bestia, ma oltre non tollero”.
Ammiratrici a plotoni. Famiglia doppia. Moglie legittima e tre figli: questa è la situazione pubblica. Naturalmente c’è anche l’amante fissa, nascosta. Entrambe innamoratissime di lui, sanno una dell’altra, e la moglie gli fa spesso tempestose scenate, ma si tollerano (per 35 anni!) odiandosi: quello che importa è stare vicine al genio.
Papà è un panettiere a Livorno, non ricco ma conosciutissimo in città, del tutto contrario all’idea di Pietro musicista. Naturalmente l’adolescente ribelle decide di fare proprio quello che papà non vuole e si mette immediatamente a studiare pianoforte e organo, facendo progressi perché ha talento. A Livorno c’è un gruppo di artisti ragazzi: musicisti, poeti, pittori, che si riunisce alla Casetta Rossa sul molo e molti dei quali rimarranno amici per la vita. A detta di tutti Mascagni è il più rumoroso del gruppo.
Va al conservatorio di Milano. Si accampa in una stanza con Puccini, squattrinato come lui. Nasce una fervida amicizia; dividono i pasti e le ore di studio, comprano gli spartiti di Wagner e Boito e li studiano insieme. Puccini riceve dai suoi una paghetta di 125 lire, Mascagni, un po’ più povero, solo 100. Se le fanno bastare, andando spesso a mangiare in un caffè di Via Manzoni, il cui proprietario fa loro credito, di sicuro sapendo che mai lo pagheranno.
Presto si stufa del conservatorio e, dopo una furibonda discussione con il direttore, lo molla buttandosi in una improvvisata carriera di direttore d’orchestra in compagnie di operette e riviste, fatta di ingaggi miserabili in teatrini di provincia.
A un certo punto arriva il colpo di fortuna. Nel 1888 l’editore Sonzogno lancia un concorso per un’opera in un atto. Mascagni e il suo librettista Targioni-Tozzetti (uno dei ragazzi della Casetta Rossa) scelgono “Cavalleria rusticana”, da una novella di Verga. La composizione procede fra furiosi entusiasmi e depressioni devastanti e si arriva all’ultimo giorno per la consegna, con il compositore demoralizzato e indeciso. Per fortuna la moglie Lina che ha più fiducia di lui nel suo talento, gli strappa la partitura dal leggio e corre all’ufficio postale riuscendo a spedirla appena in tempo.
“Cavalleria” si piazza fra i primi tre su 73 concorrenti. La eseguono al Teatro Costanzi di Roma, ha un successo clamoroso e si guadagna il primo premio. È la gloria. Anche se compone altre opere, “Cavalleria” si salda tenacemente al suo nome, facendo entrare anche lui nella categoria dei “compositori monotitolari” (in quel periodo possiamo citare come membri del club anche Leoncavallo con “Pagliacci”, Giordano con “Andrea Chenier” e Cilea con “Adriana Lecouvreur”).
Nel frattempo Verga, non del tutto soddisfatto dell’accordo per la riduzione del suo testo, fa causa all’editore, la vince e ottiene come risarcimento il 25 per cento dei diritti di esecuzione. Forse un problema per Sonzogno, non per Mascagni.
Dopo il successo di “Cavalleria” parte una brillantissima serie di viaggi e trionfi in tutto il mondo. Illuminata o funestata, comunque marcata da episodi davvero clamorosi, come il suo arrivo in nave a Buenos Aires, che lui stesso racconta in una lettera: “Quando scesi a terra l’entusiasmo di tutta quella folla divenne feroce ed ebbi paura di essere soffocato: fui sbattuto qua e là, pestato da tutte le parti tanto che per giorni ebbi dolori alle braccia e al petto”.
Negli USA gira come un matto fra le molte Little Italy della nazione e racconta (in un’altra lettera) che ogni comunità lo accoglie con la sua banda musicale e che spesso questa banda si chiama proprio Banda Mascagni
Dal 1927 abita fisso, come forse era il suo sogno di ex artista povero, in un sontuoso appartamento dell’Hotel Plaza di Roma.
Quello stesso anno rappresenta ufficialmente l’Italia per il centenario della morte di Beethoven a Vienna, nel ‘29 viene nominato Accademico d’Italia, nel ’32 si iscrive al Partito Nazionale Fascista legandosi sempre di più al regime tanto è vero che alla sua morte, dopo la guerra, il presidente del Consiglio Ferruccio Parri gli nega i funerali di stato.
Non importa: alle sue esequie private è presente una folla sterminata e la sua convinta o, come è più probabile dati i tempi, obbligatoria adesione per rimanere nel giro non ci impedisce di considerarlo un grande. Forse discutibile come persona, ma come artista, un grande.
N° 625 - Microbiografie Irrispettose Modest Musorgskij 1839 - 1881

Guardalo là, quel povero ubriacone! Guarda quel naso rosso, quegli occhi persi. È ricoverato all’ospedale militare; sono i suoi ultimi giorni di vita. Per le corsie gira un pittore, Ilja Repin, che gli fa il ritratto. Eccolo.
La sua è, fin da prima di nascere, una brutta storia complicata.
Mamma e papà hanno un primo bambino: si chiama Aleksej e a un anno muore. Ne replicano subito un altro, chiamano anche questo Aleksej e anche questo muore nello stesso modo.
A quel punto i genitori si fanno furbi: se la morte si prende gli Aleksej, per imbrogliarla basta cambiare nome ai bambini e tutto andrà bene.
Così al terzo danno un nome particolare: Filaret e infatti lui sopravvive. Ha funzionato, e allora il quarto, il nostro, sarà Modest, Modest Petrovic Musorgskij.
Modest nasce e cresce in campagna insieme ai contadini di suo padre, che è un ricco latifondi-sta, e impara le canzoni popolari dalla tata. Appena può prova a suonarle al pianoforte e la madre, colpita dal suo talento, comincia a dargli lezioni di musica. Forse è anche così che nasce il rapporto strettissimo del bambino prima, del giovanotto poi, finalmente dell’adulto, eterno immaturo legato in modo permanente e malato, con la figura materna.
Quando ha dodici anni, insieme a suo fratello Filaret, lo mandano a San Pietroburgo a studiare e, volente o nolente, finisce avviato alla carriera militare. Però continua a frequentare la musica e suo padre, l’anno dopo, fa pubblicare a proprie spese la sua prima composizione “Polka del portabandie-ra” dedicata ai compagni cadetti.
Quindi, sì alla carriera militare, ma senza chiudere la musica fuori dalla caserma.
Dopo qualche anno capita come ufficiale all’ospedale dell’esercito dove conosce Borodin, altro militare-musicista e tutti e due, durante le licenze, rallegrano i salotti borghesi della città suonando arie di Verdi e altri operisti alla moda. La fratellanza musicale prosegue, anzi si allarga fino a formare il Gruppo dei Cinque (Scuola Nazionale di Pietroburgo), con Kjui, Balakirev e Rimskij-Korsakov, che diventerà il battaglione d’assalto della nuova musica russa.
Sotto la guida di Balakirev, Musorgskij perfeziona moltissimo la sua tecnica; finalmente nel 1860 si trasferisce a Mosca, abbandona la carriera militare e diventa musicista a tutti gli effetti.
Qui gli casca addosso il primo dei macigni che gli rovineranno la vita. Lo Zar Alessandro II abolisce la servitù della gleba e all’improvviso il ricco proprietario terriero che prosperava sul lavoro degli schiavi contadini, suo padre, diventa povero, anche per l’incompetenza del fratello Filaret che amministra l’azienda. Lo sfortunato Modest non si può più permettere di vivere a Mosca e torna al paesello dai suoi, accettando perfino un impiego in un ufficio statale.
Arriva il secondo colpo: muore la madre, a cui, come abbiamo detto, lui era morbosamente lega-to e questo lo fa ricadere nell’abisso che poi lo inghiottirà: l’alcolismo (al quale si era già entusiasti-camente dedicato da ragazzo).
Malgrado tutto, adesso affronta decisamente la strada della composizione e dalle sue mani non ancora del tutto tremanti nel delirio dell’alcol, esce la famosa “Notte sul Monte Calvo” e poi, un par-to lento e faticoso, il “Boris” e finalmente i “Quadri di una esposizione”.
Sempre più squattrinato, accetta il posto di pianista accompagnatore in una serie di concerti del-la cantante Darja Leonova in Ucraina e Crimea, ma questa marchetta non basta a risollevarlo e alla fine si trova ridotto a insegnare il solfeggio ai bambini e ad accettare l’elemosina di colleghi più for-tunati, fra cui Rimskij-Korsakov, che lo ammirano ancora come musicista, ma non più come uomo; infatti, uno dopo l’altro lo abbandonano; come lo dimenticano la critica musicale e le istituzioni.
Intanto la miseria, l’infelicità e l’alcool continuano a lavorare alla sua distruzione fisica. Troppo tardi, tramite un impiccio burocratico organizzato da un amico medico, Modest riesce a farsi ricove-rare all’ospedale militare di San Pietroburgo. Qui muore il 28 marzo dell’81.
Per dare una sintesi della fragilità di Musorgskij il suo biografo Dobrovenskij ci spiega che “Con il passare degli anni Musorgskij non crebbe separato dalla figura materna, come fa la maggior parte delle persone, perseguendo l’interesse di una vita indipendente. Lui non si distaccò mai intera-mente, non divenne mai autonomo. Trovarsi orfano per lui fu veramente orribile: non perdonò mai la morte per questa pena inflittagli”.
N° 624 - Microbiografie Irrispettose - Georges Bizet 1838 - 1875

Bizet muore un paio di mesi dopo la prima della “Carmen”, convinto di aver perso la battaglia mentre invece ha vinto la guerra.
Ma non lo saprà.
Georges ha una personalità estremamente insicura che lo spinge a dubitare sempre delle proprie capacità artistiche. Per questo sintetizza, distrugge e lascia incompiute o inedite molte sue composizioni. E noi gliene siamo grati perché le sue raccolte di temi, le suite, che crea scegliendo il meglio della sua produzione, proprio perché non è mai sicuro di quello che ha scritto, risultano piacevolissime insalate miste, con le verdure più fresche e senza foglie appassite.
Papà Adolphe e lo zio Francois sono maestri di canto, la zia Charlotte insegna solfeggio, mamma Aimee è pianista. Lui a dieci anni è già al conservatorio dove studia con Gounod e Halevy. Come tanti ragazzi della sua età, anche lui è fissato con il Prix de Rome, l’ambito viaggio e soggiorno di studio in Italia. Ci prova una volta e gli va male.
Allora cambia obiettivo e, come niente fosse, vince un concorso organizzato da Offenbach con un’operina che ha un gran successo e gli apre le porte dei salotti di Parigi. Frequenta le serate di Offenbach il venerdì e quelle di Rossini il sabato. È la consacrazione.
Con Il Prix de Rome ci riprova, stavolta lo vince con il massimo dei voti e a meno di vent’anni parte. Georges è un ottimo pianista: una dote che lo lancia anche nell’alta società di Roma. È un momento molto positivo della sua vita, tanto che neanche si accorge del nemico che comincia a mangiarselo da dentro: una terribile angina.
Nel ’60 l’amatissima mamma Aimee si ammala gravemente; lui torna a casa per starle vicino. È arrivato il momento di decidere il futuro. Malgrado Liszt lo riempia di complimenti sulle sue doti di pianista, e anche la mamma dal suo letto di malata insista per farlo diventare un virtuoso, lui non ci sta. Vuole fare il compositore e non il concertista. E viene prontamente punito.
Rimane senza il becco di un quattrino è obbligato a dare lezioni, a fare trascrizioni e arrangiamenti e in più gli sale addosso una mania di persecuzione che lo accompagnerà tutta la vita.
Piano piano arrivano commissioni più serie e l’invito a collaborare a una rivista di critica musicale su cui brillano le sue inaspettate e fino ad allora sconosciute doti letterarie.
Poi, colpo di fulmine! conosce la deliziosissima Genevieve Halevy, figlia del suo insegnante al conservatorio. Naturalmente il papà di lei non ci sta a dare la sua bambina a un artista squattrinato e malaticcio (l’angina comincia ad affacciarsi seriamente).
Finalmente il suocero cede. Si sposano, hanno un bambino, ma presto Genevieve manifesta forti squilibri mentali e a questo si aggiunge il periodo drammatico dell’assedio di Parigi, della spietata repressione della Comune e delle crescenti difficoltà per affrontare la semplice sopravvivenza.
Davvero un brutto momento.
Nel 1872 comincia la rinascita. L’impresario amico Carvalho gli commissiona “L’Arlesiana” e lo mette a lavorare con il poeta Alphonse Daudet, col quale si intende subito. La prima teatrale, mal provata e mal eseguita, è un fiasco, ma Bizet non si scoraggia e dalla partitura dell’opera estrae una delle sue magnifiche suite per orchestra (di cui, come abbiamo già detto, gli siamo immensamente grati) che ha un grandioso successo. Finalmente!
E adesso, sotto con “Carmen”. Dopo tre anni di lavoro dalle sue mani esce l’opera che conosciamo e che entusiasma già gli spiriti liberi del tempo (Nietsche, Puccini, Brahms, Freud), ma non ancora la stampa e il pubblico della prima, il 3 marzo 1875, che, abituati ai personaggi stereotipati della lirica tradizionale, si scandalizzano per l’immoralità e lo spietato verismo di quella storia di zingare e toreri e la boccia.
Bizet è annientato, la sua angina si scatena costringendolo addirittura sulla sedia a rotelle. Qualche settimana dopo, se ne parte per la campagna in cerca di pace: passeggiate, riposo; ma azzarda un imprudente bagno nel fiume che gli scatena una crisi cardiaca e la sera della trentatreesima replica di Carmen (quando ormai il suo capolavoro ha cominciato la sua marcia trionfale, ma lui non lo sa e crede che stia ancora lì a zoppicare), muore convinto, come abbiamo già detto, di aver perso la battaglia mentre invece ha vinto la guerra.
N° 623 - Microbiografie Irrispettose - Luigi Boccherini 1743 - 1805

La vittima è il musicista Luigi Boccherini, l’epoca del crimine si colloca intorno al 1805, l’arma (impropria): il violoncello,
Si evidenziano:
Grave rizoartrosi del pollice destro causata dall’impugnatura dell’archetto.
Accentuata epicondilite del gomito sinistro dovuta alla costante flessione del braccio.
Perdita della lordosi fisiologica della colonna vertebrale attribuibile alla posizione rigida del corpo rispetto allo strumento.
Scoliosi sinistro-convessa imputabile alla inclinazione sul fianco destro a cui forza l’uso dello strumento.
Tibie valghe: anomalia provocata dalla necessità di tenere fermo con le ginocchia il violoncello barocco, privo di puntale.
Naturalmente il nostro povero Boccherini non soffre solo di questo; ha anche gli altri normali acciacchi del tempo: una grave aterosclerosi aortica e iliaco-femorale, nonché corpose calcificazioni pleuriche, segnale di tubercolosi polmonare in atto o pregressa. Riesce lo stesso a campare fino alla bella età (per il tempo) di 62 anni.
Luigi nasce a Lucca in una famiglia di artisti: il padre contrabbassista, un fratello e due sorelle ballerini (delle inclinazioni della madre le biografie non parlano).
Virtuoso di violoncello, istruito alla perfezione dal padre che rimarrà per tutta la vita suo compagno di scorribande musicali e non. La prima notizia del trasferimento in massa della famiglia, raccomandata a Corte dall’ambasciatore di Lucca, l’abbiamo nel 1757, quando tutti, padre contrabbassista, figlio violoncellista e i tre fratelli ballerini invadono Vienna, si impiegano al Teatro Imperiale e qui rimangono parecchi anni, ognuno con il meritato successo nella propria specialità.
Dalla base di Vienna Boccherini ogni tanto torna a Lucca dove, nel 1765, ha occasione di collaborare con Giacomo Puccini (non il Giacomo che conosciamo noi, ma un suo bis o trisnonno – la famiglia Puccini è da tempo attiva nella musica). Intanto si è legato di un’amicizia fortissima con il violinista Filippo Manfredi, con il quale fonda il primo quartetto d’archi stabile della storia e sul quale riverserà quell’affetto e quella complicità che lo legavano al padre, morto nel ’66.
Con Manfredi capitano a Parigi, dove hanno successo e dove l’ambasciatore spagnolo in Francia invita i due ad andare a Madrid garantendo una buona accoglienza da parte di Don Carlo, Principe delle Asturie. Partono ma vanno a sbattere il naso contro le trame di un temibile avversario, il musicista pisano Brunetti (fra Lucca e Pisa già allora non c’era un gran feeling), sovrintendente alla musica di Don Carlo.
Manfredi viene assunto nell’orchestra del principe; Boccherini rimane a spasso senza una peseta in tasca.
Finalmente trova un servizio come violoncellista di camera presso l’Infante Don Luis con l’impegno di comporre soltanto per lui, esclusiva che Boccherini, felice di questa protezione, rispetterà per quindici anni, anni pieni di una frenetica attività di composizione: concerti, quartetti, quintetti, fra cui il numero 5 Op. 11 che contiene il famosissimo Minuetto, che poi è il suo unico titolo che tutti ricordano in mezzo al mare delle altre opere (anche il nostro Boccherini, come molti altri, è un Compositore monotitolare).
Non è che in questo periodo manchino i dispiaceri: l’amico Manfredi lascia la Spagna e se ne torna a Lucca. Subito dopo, per un contrasto musicale con il Principe delle Asturie, Luigi perde la sua protezione e il permesso di frequentare il palazzo reale (si era appesi a un filo in quel tempo!).
Non gli rimane che seguire il suo secondo padrone, don Luis nel palazzo di Las Arenas dove sta tranquillo per un po’ con la moglie, i figli e un fratello, venuto ad abitare con lui. Ma anche questa serenità non dura: nel 1785 muore la moglie e poco dopo anche Don Luis.
Si trova da solo, senza protezione, senza soldi e con cinque figli da mantenere. Disperato, riesce ad ottenere una misera pensione dal re con il quale aveva litigato. Poi strappa un altro esiguo vitalizio a Federico Guglielmo II di Prussia.
Finalmente, in questo così poco dignitoso accattonaggio a cui sono costretti gli artisti dell’epoca, trova, come direttore dell’orchestra di casa, un rifugio nei saloni del palazzo di Puerta de la Vega, in cui Maria Josefa Alonso Pimentel, Contessa-Duchessa di Benavente-Osuna (!), tiene serate musicali per la migliore nobiltà di Madrid in concorrenza con la Duchessa d’Alba, Maria del Pilar Teresa Gayetana da Silva y Alvarez de Toledo (!!), la quale come favorito ha invece il suo arcinemico, il pisano Brunetti.
Nel 1787 perde (non sappiamo perché) questa comoda posizione e da questo momento in poi è tutto un rotolare verso il baratro. Ha un editore che tenta in ogni modo di truffarlo; muore il suo protettore prussiano, re Federico Guglielmo II e il successore gli revoca la pensione; un attacco di tubercolosi non gli permette nemmeno di suonare il violoncello. È la miseria (con l’aggravante dei cinque figli affamati).
Poi, nel 1800, ecco un piccolo intervallo di fortuna: Luciano Bonaparte, ambasciatore della Repubblica Francese in Spagna, appassionato di musica gli affida alcune ben pagate commissioni. Può rifiatare, ma dura solo due anni. Bonaparte torna in Francia e una violenta epidemia gli porta via tre dei suoi cinque figli.
Disperato, povero e malato l’infelice Boccherini si ritira presso i due figli ancora vivi, Luigi Marco, sacerdote e Giuseppe Mariano, archivista e alla fine se ne va anche lui il 28 maggio 1805.
Nel 1927 il suo corpo viene riesumato e finalmente riportato a Lucca, dove riposa tranquillo (fino al 1997, quando avrà luogo l’esame paleopatologico da cui inizia la nostra storia).
----------------------------------------------
N° 622 Microbiografie Irrispettose - Edvard Grieg 1843 - 1907

Diciamolo subito: Grieg è fortunato. È fortunato perché nasce in una famiglia ricca. È fortunato perché è l’unico compositore norvegese di livello, quindi in patria non ha rivali. È fortunato perché papà e mamma riconoscono subito la sua disposizione per la musica e la favoriscono in ogni modo. È fortunato perché un amico di famiglia, il famoso violinista Ole Bull, appena lo ascolta suonare a quindici anni, convince i genitori a mandarlo a proseguire gli studi a Lipsia, dove potrà approfondire tutto il repertorio del tempo.
È fortunato perché nel 1869 riceve dallo stato norvegese una borsa di studio che gli permette di andare in Italia a perfezionarsi con Liszt. È fortunato perché nell’82 riesce a firmare un vantaggiosissimo contratto con l’editore Peters di Lipsia che lo libera (anche se già è di famiglia benestante) da qualsiasi necessità economica. È fortunato perché vive in una nazione civile che, negli ultimi anni gli riconosce un vitalizio per i suoi meriti. È, infine, fortunato perché, quando muore (anche se troppo presto) è al massimo della sua fama e a salutarlo al suo funerale ci sono quarantamila persone.
Qualcosa che non funziona, ci sarà, no?
Infatti: è la salute. A diciassette anni salva la pelle per un soffio dal collasso di un polmone per una gravissima malattia respiratoria, che con gli anni va e viene e alla fine gli compromette il cuore, di cui muore nel 1907, dopo aver penato parecchio.
Per il resto, tutto bene. È un ottimo pianista, riconosciuto e onorato, un concerto dopo l’altro. È anche un profondo studioso del folklore musicale norvegese. Ricerca, raccoglie, rielabora un tesoro nazionale del quale nessuno si era occupato prima.
Fondatore dell’Accademia Norvegese di Musica, si dà da fare per far conoscere ai suoi connazionali il meglio del repertorio classico europeo. In pratica riesce a creare un canale culturale fra il suo paese, piccolo e relativamente arretrato fino a quel momento, con il resto del mondo che conta.
Ha una cugina, la cantante Nina Hagerup, con la quale ha formato un duo per i suoi concerti. La sposa, così da quel momento i viaggi, gli alberghi, i contratti; la vita insomma, si semplificano parecchio per lui, per lei e per gli impresari.
Durante un viaggio in Italia (che tutti i nordeuropei prima o poi affrontano in quell’epoca) conosce Henrik Ibsen, autore di quel Peer Gynt che rappresenterà la scintilla e il centro dell’immensa popolarità monotematica di Grieg, un esempio di fama universale basata su un unico brano di cui lui è un perfetto esempio.
Perché sappiamo anche che Grieg ha scritto un bel po’ di bella musica da camera, più un eccellente concerto per pianoforte e orchestra, più una serie di brani collegati al folklore norvegese ma l’unico titolo che ci scatta in mente quando pensiamo a lui è “Il Mattino”.
Che è uno dei brani nati per commentare la messa in scena del Peer Gynt, poi riuniti in due suite orchestrali (confezione che si presta ottimamente a mettere in risalto i motivi e la sapiente orchestrazione. E diciamolo pure con un pizzico di malizia: la sua sopraffina furbizia melodica). Un tema fra i tanti, tutti azzeccatissimi, sul quale si è appuntato nel suo modo arbitrario, imprevedibile e capriccioso il favore popolare.
Ci si è appuntato, e ci è rimasto inchiodato fino ad oggi.

Per concludere una esistenza felice, a un certo punto Grieg e sua moglie Nina se ne vanno a vivere (nei momenti liberi dai concerti) in una villetta vicino a Bergen, nella Valle dei Troll, completa di lago, capannina rossa con pianoforte per comporre in tranquillità e dotata anche di una tomba segreta, nascosta nella scarpata che scende all’acqua, dove troveranno posto le ceneri di Edvard e, parecchi anni più tardi, quelle di Nina.
N° 621 - Microbiografie Irrispettose - Vincenzo Bellini 1801 - 1835

Il Bellini è un cocktail a base di frullato di pesca e prosecco creato nel 1948 da Cipriani, proprietario dell’Harry’s Bar di Venezia, per l’inaugurazione della mostra del pittore Giovanni Bellini. Questo Bellini è buono ma non ci serve.

Poi c’è il Bellini delle cinquemila lire, andate fuori corso nel 2002. Questo invece fa al caso nostro: è lui, Vincenzo, un compositore italiano tra i più celebri dell’Ottocento.
E, collegato al suo nome, c’è di più: un conservatorio, un teatro e un aeroporto a Catania. Un teatro anche a Napoli. Un piatto della cucina regionale siciliana (la pasta alla Norma). Una varietà di fungo (il suillus bellinii). Un film intitolato “Casta diva”. Un asteroide (il 18509 Bellini).
Ultima curiosità: quasi tutto quello che sappiamo di lui ci viene dalle moltissime lettere che scrive per tutta la vita al suo amico e compagno di studi Francesco Florimo.

Cominciamo. Vincenzo nasce a Catania, figlio e nipote d’arte: papà compositore minore, nonno rinomato autore di musiche sacre. Nel ’19 il comune di Catania (segno che fin dall’inizio è riconosciuto meritevole) gli dà una borsa di studio per il conservatorio di Napoli. Arriva al porto stremato da cinque giorni di navigazione tempestosa, avendo rischiato il naufragio.
Nel ’26 il primo successo operistico con la prima delle dieci opere che compone in dieci anni: “Bianca e Fernando”, reintitolata “Bianca e Gernando, per non mancare di rispetto al re Ferdinando di Borbone (il che dimostra che la stupidità cortigiana era fiorente anche allora).
Questo successo gli porta le commissioni del famosissimo impresario Barbaja per il Teatro alla Scala, (puntualmente seguite da altrettanti clamorosi trionfi). E Vincenzo se ne parte per Milano dando il via alla sua brillantissima e brevissima carriera, ma lasciandosi alle spalle Maddalena Fumaroli, la ragazza di cui era innamorato e il cui padre gliela aveva negata; non gli piaceva questo matrimonio con un “suonatore di cembalo”. Poi, quando arrivano la fama e i soldi, il papà furbacchione cambierà idea, ma è troppo tardi: Vincenzo ormai non pensa che alla musica.
Ma la vera svolta è Parigi. Qui Bellini sale al massimo livello. Conosce Chopin e Liszt, diventa il pupillo di Rossini; con loro raffina tecnica e gusto. Verdi gli riconosce originalità rispetto ai suoi contemporanei e lo colloca in una nicchia solo per lui. Wagner, che raramente apprezza qualcuno che non sia sé stesso, è affascinato dalla sua capacità di abbinare la musica al testo e alla psicologia. Produce un gioiello dopo l’altro, la Norma, la Sonnambula, i Puritani. Entra nelle case di tutti i francesi e poi di tutti gli europei. Ma ci rimane davvero poco, perché, ad appena 34 anni se ne va stroncato da un’infezione intestinale, anche se c’è un sospetto, sicuramente infondato, di avvelenamento. A testimonianza della sua fama, i concittadini non lasceranno il suo corpo a Parigi: qualche anno dopo lo rivogliono a Catania, dove oggi si trova.
Bellini ha il merito di essere fra i primi a dare importanza e a intervenire sul libretto dell’opera, che fino ad allora veniva imposto al compositore, insieme al soggetto, dall’impresario e spesso affidato a un qualche immeritevole e scadente dilettante locale.
Tanto è vero che, una volta trovato nel poeta Felice Romani il compagno perfetto di un’intesa creativa, non lo abbandona più e in questo modo rende indispensabile e obbligatorio salire a un livello sempre più raffinato della parte letteraria, per sé e per gli altri operisti. Finalmente si comincia a stare attenti prima di mettere in musica testi che fino a quel momento erano stupide accozzaglie di parole antiquate, ridicole, squilibrate da accenti spostati, se non inventate per l’occasione.
Per Vincenzo “il dramma per musica deve far piangere, inorridire, morire cantando”. E infatti, tanto perfetta è questa unione che Romani, morto Bellini, non scriverà mai più una riga per il teatro d’opera.
All’epoca non c’era la fotografia e le banconote o i ritratti sono poco fedeli. Ma abbiamo una descrizione di Heine che ci pare abbastanza precisa, comunque suggestiva: “Egli aveva una figura alta e slanciata e si muoveva graziosamente e in modo civettuolo. Viso regolare, piuttosto lungo, di un rosa pallido, capelli biondi, quasi dorati, pettinati a riccioli radi, fronte alta, molto alta e nobile. Naso dritto, occhi azzurri, bocca ben proporzionata, mento rotondo. Anche il suo passo era virginale, elegiaco, etereo”. Fin qui tutto bene, ma ecco la punzecchiatura. “Bellini parlava francese molto male, anzi orribilmente, scelleratamente, catastroficamente, da cane dannato. Mentre lui era convinto di dire le cose più serie ed innocenti un silenzio di morte e nello stesso tempo una voglia convulsa di ridere regnava nei saloni”.
L’egocentrico, ipocondriaco Rossini sarà colui che, con sorpresa di tutti, (ne sarebbe stato sorpreso anche lo stesso Bellini che non valutava più di tanto il loro rapporto di amicizia) uscirà dalla sua proverbiale pigrizia per occuparsi dell’imbalsamazione del corpo e del cuore dell’artista e per aprire una sottoscrizione per il funerale che, celebrato nella Cappella degli Invalidi, il luogo più solenne di Parigi, riesce imponente, con il feretro seguito e il defunto pianto da tutti gli artisti della città e da migliaia di cittadini comuni.
N° 620 - Microbiografie Irrispettose - Carl Orff 1895 - 1982

Che Orff non poteva essere italiano è evidente fin dalle prime fantascientifiche righe della sua biografia.
“In casa Orff la Hausmusik, (l’esecuzione di musica da camera in varie formazioni fino al quintetto con pianoforte) faceva parte delle tradizioni della famiglia e fu il terreno ideale per lo sviluppo della musicalità del piccolo Carl.”
Figurarsi da noi! Per continuare l’impietoso paragone con il tipico bambino italiano, Orff va al primo concerto a otto anni, lo portano all‘Olandese Volante di Wagner a nove, e così via per tutto Mahler e Richard Strauss. In più ha un nonno musicofilo, un padre contrabbassista e una madre ottima pianista che lo segue anche dopo che, arruolatosi ragazzo nella Prima Guerra Mondiale, nel ’17 torna a casa mezzo suonato per via di una granata che gli è scoppiata accanto in trincea.
E’ da questo periodo in poi che Carl si dedica alla didattica, nella quale riesce benissimo, e a quella che all’epoca sembra una forma di bizzarra archeologia musicale: lo studio degli antichi maestri del rinascimento (Orlando di Lasso, Byrd, Monteverdi), studio che, integrato con quello di Catullo e altri poeti latini, lo porterà dove tutti sappiamo.
Gli capita, nel momento fondamentale della vita (nel mezzo del cammin…), di sbattere contro la nascita e il trionfo del nazismo. Riesce a scansare molte complicazione, anche se ha collaboratori e amici ebrei, integrandosi fin dall’inizio, con i suoi metodi educativi, nella politica musicale della Hitlerjugend.
Però è sempre accompagnato da una scomoda ombra di “bolscevico culturale” che lo oscura pericolosamente fino al 1937, alla prima a Francoforte della sua opera più famosa, i “Carmina Burana”, una trilogia di trionfi musicali su testi medievali in latino trovati nel monastero benedettino di Bura.
Un’opera modernissima costruita su un coro immenso e un’orchestra davvero spropositata (sei pianoforti, nove contrabbassi in blocco, più la consueta ma rinforzata formazione di archi e fiati e una batteria di percussioni mai viste prima).
La stronca con insistita malvagità l’influente critico nazista Hans Gerigk che lo accusa, in un ridicolo stile burocratico-dittatoriale, di “Linguaggio jazz e malinteso ritorno a elementi primitivi di strumentalità e di enfasi sulle formule ritmiche”.
Però i Carmina sono troppo forti e alla fine, malgrado gli sgambetti del critico trombone e le trappole dei funzionari ultraortodossi, trionfano e diventano quasi un sottinteso inno identitario del regime, e comunque un solidissimo podio per la sua fama.
Così autorevolmente testimoniano per lui i suoi Carmina, che il sindaco di Francoforte gli commissiona una nuova musica per il “Sogno di una notte di mezza estate” da sostituire a quella (bellissima, ma scritta da un ebreo, e quindi da buttare) composta da Mendelssohn.
Come rifiutare, quando si rischia la pelle a ogni passo? Orff ci sta, compone, ma in seguito ripudia questo nuovo commento all’opera di Shakespeare. Benché sostenitore dell’autonomia della creazione artistica rispetto al momento politico, probabili rovelli di coscienza fanno sì che dalle mani di Orff esca non solo un’opera fiacca e insignificante, ma anche che sia consegnata in ritardo (inconscio desiderio di autopunizione?) tanto da vedersi ridotto il compenso da 5.000 a 3.000 marchi (e lui in quel momento è in grande difficoltà).
Orff non si iscrive al partito nazista né ricoprirà mai una carica importante, però per lavorare, anche se a livello di bassa visibilità, deve comunque associarsi alla Reichmusikkammer, l’unione dei musicisti tedeschi del Reich.
Orff non è un eroe. Quando arrestano (e poi giustizieranno) il suo carissimo amico Kurt Huber, la moglie di questi cerca aiuto da lui che forse avrebbe potuto usare i suoi contatti per liberarlo. Orff si fa prendere dal panico, taglia la corda e la povera signora, diventata nel frattempo vedova, non lo vedrà mai più.
E la musica del “Sogno”? Orff ha sempre dichiarato di averla composta per una sua personale esigenza, ma ha anche riconosciuto di aver scelto un momento storico sbagliato per pubblicarla.
Gli psichiatri che hanno analizzato la sua posizione hanno comunque riscontrato che di base aveva un atteggiamento antinazista e che aveva sempre cercato di evitare qualunque coinvolgimento con il partito e poi con la guerra.
Con la sconfitta del Reich, Orff, insieme a tanti altri artisti che per sopravvivere avevano accettato come lui compromessi con il regime, è “denazificato”, il che significa che una commissione americana lo ha esaminato e gli ha dato una valutazione, nel suo caso con la formula: “Grigio C - Accettabile”, ritenendolo sì compromesso con il partito, ma non con la sua dottrina. In pratica è marchiato come recuperabile dalla melma nella quale (non per sua scelta) si era trovato a sguazzare.
Quindi può andare avanti a comporre e anche a dirigere liberamente, cosa che farà, sostenuto dall’immutato successo del suo capolavoro, fino al 29 marzo 1982.
N° 619 - Microbiografie Irrispettose - Olivier Messiaen 1908 - 1992

Ornitologo. Così voleva essere chiamato, invece che musicista. Come mai?
Un bel giorno (1951) gli commissionano un brano difficile da far eseguire ai flautisti del Conservatorio di Parigi per verificare il loro livello di bravura. Nasce “Il Merlo”, per flauto e pianoforte e insieme a questo pezzo spunta la reputazione di ornitologo–musicista che lo accompagnerà per tutta la vita.
Un po’ di cifre e di date per cominciare. Olivier entra, anche lui come tanti colleghi, prestissimo, a undici anni, al conservatorio di Parigi. A ventitrè anni diventa organista titolare della Chiesa della Trinità di Parigi, e tanto gli piace la panca del magnifico strumento di quella chiesa, che ci rimane seduto sopra fino a ottantaquattro anni, quando muore.
Nel 1940, viene fatto prigioniero dai tedeschi e rinchiuso nello Stalag VIII dove, grazie al sostegno di uno di quei simpatici e colti ufficiali nazisti, appassionati di camere a gas ma anche di musica, gli viene permesso di comporre e fare eseguire davanti ai compagni di prigionia il suo famoso “Quatuor pour la fin du temps” per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte, una formazione un po’ così, non per suo capriccio, ma perché quelli erano gli sgangherati strumentisti che aveva a disposizione fra gli internati.
Finita la guerra e salvata la pelle, Messiaen si interessa alla musica indiana e a quella dell’antica Grecia, nonché ai ritmi più strambi, agli strumenti esotici o tecnici, come il gamelan indonesiano e le Ondes Martenot, e anche ad attrezzi più curiosi come l’eolofono e il geofono (la macchina del vento e quella della sabbia).
E intanto percorre fino alla pensione tutta la carriera di insegnante di conservatorio, una carriera relativamente tranquilla, illuminata però dalla sua stupefacente folgorazione ornitologica musicale.
Anche se già aveva utilizzato sue trascrizioni del canto degli uccelli in precedenti composizioni, da “Il Merlo” in poi queste diventano il filo conduttore imprescindibile di quasi tutto quello che scrive.
Convinto che gli uccelli siano i più grandi musicisti della creazione, si mette a raccogliere, registrare, catalogare, da scienziato, i loro versi, per poi trascriverli, da musicista, per l’orchestra o il pianoforte. Ogni volta che ha un concerto da qualche parte, preferibilmente esotica, del mondo si ritaglia un paio di giorni per le sue escursioni, non va neanche a dormire e all’alba, accompagnato dalla moglie che oltre a essere una robusta camminatrice è anche una raffinata tecnica del suono, sovraccarichi tutti e due di una bella attrezzatura di microfoni e registratori da campo, parte per foreste e paludi a raccogliere trilli e pigolii.
Alla fine la più completa di queste raccolte si chiamerà, anche se non è un titolo molto originale, “Catalogue d’Oiseaux” e merita un ascolto, soprattutto per capire di cosa stiamo parlando.
Messiaen sa bene che gli uccelli sono più piccoli degli uomini e hanno un cuore che batte più rapido; il loro canto è più alto e veloce, perciò per riprodurlo e adattarlo agli strumenti e all’orecchio umano, lo dilata nel tempo, lo abbassa di vibrazioni, allarga gli intervalli, lo arricchisce di poesia e di bellezza, arriva perfino ad abbinarlo a colori e sfumature che gli servono per raccontare meglio questa magia; talvolta lo riproduce con strumenti a percussione.
Insomma, in realtà il suo è un pretesto tecnico-artistico per inserirsi nell’armonia del creato e così soddisfare anche la sua fortissima spinta religiosa (”Il primo aspetto della mia opera, il più nobile, il più utile, il più solido, il solo forse di cui non mi pentirò al momento della mia morte”), e senz’altro gratificare anche un suo vivo senso dello spettacolo che gli fa scegliere come soggetti manifestazioni di fede un tantino più pittoresche, come la predica agli uccelli di San Francesco, mettendo naturalmente sul podio del solista l’allodola, il cui canto è il più vicino alla lode di Dio.
“Musica da acquasantiera”, definisce la sua opera quella malalingua di Poulenc, ma noi ce ne infischiamo perché di sicuro si tratta solo di invidia.
Di lui un altro collega, più ben disposto, ha osservato che “Messiaen fu un ornitologo più coscienzioso di tutti i compositori e un osservatore del canto degli uccelli più musicale di tutti gli ornitologi che lo avevano preceduto.”
E lui stesso aggiunge una cosa interessante e illuminante quando dichiara: “Ho ricercato davvero tanto, ma ho sempre fatto in modo che questo non nuocesse alla qualità sonora: un’opera musicale dev’essere interessante, gradevole da ascoltare e toccante e non un arido elenco di dati”.
Ascoltare per credere.
N° 618 - Microbiografie Irrispettose - Jean Baptiste Lully 1632 - 1687

Lully è un furbacchione. Ottimo musicista e ballerino, comunque un furbacchione. In più fortunato. D’altra parte non è una novità che il talento non sempre va sottobraccio con la rispettabilità. Anzi.
Giovanni Battista Lulli nasce italiano, a Firenze, da un coltivatore di nocciole e da una mugnaia.
Nel 1646 il duca Ruggero di Lorena, arriva in Italia e, durante il carnevale, gli cade l’occhio su un ragazzino il quale, mascherato da Arlecchino con il violino al braccio diverte la folla. Siccome è in cerca per la nipote Maria Luisa d’Orleans di un piccolo italiano con cui lei possa giocare e conversare nella lingua che sta studiando, ecco come comincia l’avventura di Giovanni Battista, perché quel ragazzino è proprio lui.
Detto fatto, il piccolo saltimbanco è arruolato dal duca e lo segue a Parigi, dove per cinque anni è paggio della ragazza, studia composizione, si fa un nome come ballerino, violinista e chitarrista e soprattutto entra in contatto con tutto il gruppo di compositori che frequentano i palcoscenici della città più importante dell’epoca.
La fortuna gli fa di nuovo l’occhiolino nel ’53 in occasione del “Ballet royal de la nuit”, quando Luigi XIV, ancora ragazzo anche lui, ma già provetto ballerino, debutta interpretando la parte, appunto, del Re Sole. In quella circostanza si esibisce in travolgenti piroette anche Lully, facendo colpo sul re che lo onora del suo immediato favore. Grazie al suo indiscutibile talento e ancora di più al suo spirito intrigante e spregiudicato, un paio di mesi dopo è già Compositore Reale per la musica strumentale, poi Sovrintendente e finalmente Maestro della Famiglia Reale.
Naso grande, bocca ben formata, piccoli occhi miopi e figura che col tempo diventerà robusta, si naturalizza francese, sposa una francese figlia del maggiore musicista di corte, diventa Jean Baptiste de Lully e dichiara di essere il rampollo di un nobile fiorentino, esagerando un bel po’ il livello sociale di papà, il contadino che raccoglieva nocciole.
Con la concessione, resa vitalizia e addirittura ereditabile da Luigi XIV, del privilegio che consente di far pagare l’ingresso al pubblico (concessione appena perduta per fallimento da Pierre Perrin e da lui catturata con diabolico tempismo) Lully diventa il padrone dell’Opera Royale.
Qui, per quindici anni, mette in scena una serie formidabile di produzioni, mantenendo ben saldo il favore del re e sfruttando questo lucrosissimo monopolio. Ai suoi spettacoli fa pagare poco i posti in piedi per i poveri (30 soldi) ma carissimi quelli a sedere per i ricchi (1 luigi d’oro).
Purtroppo questo favore, con la morte della regina madre e il matrimonio segreto del re con Madame de Maintenon, comincia a impallidire, represso dalla nuova atmosfera di devozione e conformismo della corte.
Luigi XIV perde interesse per l’opera e comincia a dimostrarsi tanto seccato dalla vita dissoluta del suo una volta amatissimo musicista e dalle sue frequentazioni di una combriccola di noti omosessuali (il Duca di Vendome, il Conte di Tallard, e il Duca di Gramont) che, quando spunta addirittura una sua relazione intima con un paggio, gli nega l’autorizzazione a mettere in scena l’Armida a Versailles e lo allontana come “musicista geniale ma riottoso a disciplinare in pubblico il proprio modo d’essere”.
Nel periodo del suo successo a corte, Lully era riuscito a sfruttare molto abilmente le sue qualità di musicista, istrione, ballerino. Insomma di bello spirito. Era entrato nella Grande Bande des Violons du Roy, la migliore orchestra del momento, aveva collaborato con il sommo Moliere, e soprattutto aveva instaurato un ferreo (e all’epoca inconsueto) regime di disciplina nel suo lavoro: prove su prove e una inflessibile attenzione alla qualità delle esecuzioni.
Ma non aveva saputo calibrare la misura del suo successo. Era diventato ricchissimo, potentissimo e molto odiato. Un tiranno in grado di soffocare per anni la concorrenza delle altre compagnie. Ciliegina sulla torta, grazie a un altro privilegio del re era riuscito a intascare anche l’incasso della vendita dei libretti d’opera e addirittura della sua musica stampata (in un’epoca ancora senza il diritto d’autore). Troppo. E non si sa come sarebbe andata a finire, se non che…
L’otto gennaio 1687 sta dirigendo il suo Te Deum in onore del re. Allora l’orchestra la si conduceva battendo il tempo sulle tavole del palcoscenico con un pesante bastone di ottone.
Distrazione, entusiasmo? Fatto sta che la punta del bastone colpisce l’alluce del maestro. Presto la ferita si infetta, l’infezione diventa cancrena; si rischia il peggio. Per salvarlo i medici prescrivono l’amputazione. Lully rifiuta, forse perché un ballerino provetto come lui non può rimanere senza una gamba, forse perché spera comunque di guarire.
Invece, dopo due mesi di sofferenze è bell’e morto.
Curiosità. All’epoca di Lully il LA era a 392 Herz, (invece dei 440 di oggi: praticamente un tono più basso, cioè un SOL). Siamo sicuri che questo sarebbe piaciuto agli amici fissati con la teoria delle vibrazioni e del benessere che ne deriva, secondo loro, al corpo umano, organismo strutturato anch’esso, sempre secondo loro, sulle vibrazioni.
“Ascoltando la musica proposta da strumenti con questa accordatura, le onde sonore modificano la pressione sanguigna, la respirazione, il battito cardiaco, la resistenza elettrica della pelle, la sudorazione, la risposta neuroendocrina e le onde cerebrali stimolando il rilassamento della mente e il riequilibrio psicofisico”.
Una magia, altro che musica. Sarà vero?
N° 617 - Microbiografie Irrispettose - Isaac Albeniz 1860 - 1909

Sì, sono tutti bambini prodigio, lo sappiamo, ma Isaac esagera: debutta in concerto a quattro anni al teatro Romea di Barcellona. Neanche Mozart! A sette anni fa l’esame di ammissione al Conservatorio di Parigi, lo passa brillantemente, ma non lo vogliono: “Questo non è un asilo d’infanzia”.
Allora si sposta a quello di Madrid, e qui entra, ma trova il modo di litigare subito con i suoi professori. Alla fine manda tutti al diavolo e se ne va giurando di non mettere più piede in una scuola di musica.
Tanto per rimanere nell’esagerazione, a nove anni scappa di casa e se ne va in giro per la Spagna suonando e guadagnandosi da vivere come un adulto affermato.
La leggenda (ma pare che sia un po’ gonfiata) racconta anche che a un certo punto Albeniz, che ormai ha ben 13 (tredici) anni si imbarca per Porto Rico pagandosi il viaggio con la musica. Lo riacchiappa il padre, ispettore di dogana, che però poi, fiutato l’affare, se lo porta per un giro di concerti insieme alla sorellina nei paesi del Sud America.
Anche qui il paragone con Mozart e famiglia ci sta.
Nel 1877 raggiunge a Weimar Liszt, di cui è da sempre artisticamente innamorato, e lo segue per due anni in tutte le sue peregrinazioni mentali, musicali e geografiche (anche Liszt non è certo un tipo sedentario) facendo una grande esperienza con il maestro. Poi riprende a girare per conto suo di trionfo in trionfo, finché, stanco di tutto questo, secondo lui vano e faticoso arrabattarsi al pianoforte, dopo un ultimo concerto a Berlino nel 1893 appende la tastiera al chiodo.
E si piazza a Parigi, dove si trova benissimo (doveva essere un periodo di grande fervore e vitalità intellettuale), si mette a scrivere commedie musicali e opere, tutte scivolate discretamente nel dimenticatoio, ma poi, in un momento tragico della sua vita, con la moglie e una figlia malatissime, quasi in punto di morte, gli esce dalla penna una delle composizioni più brillanti, colorate, gioiose del repertorio mondiale: la suite “Iberia”.
La completa nel 1908 e poi, come una farfalla che ha fatto il suo ultimo volo, muore, giovane, nel 1909 (poche settimane prima, la Francia gli ha concesso la Legion d’Onore).
Di molte delle sue circa cinquecento composizioni le partiture sono scomparse nel nulla, perse nel vortice dei suoi viaggi, prestate e mai restituite, non edite, oppure cedute a editori inaffidabili e forse anche truffaldini. Di alcune che ci sono arrivate, c’è chi critica la approssimazione della stesura dovuta alla fretta, la eccessiva facilità con cui gli escono i temi e l’esagerato colore di cui li veste.
Ecco come lui stesso si commenta: “Alcune di queste cosette non sono da buttare. La musica è un po’ infantile, ingenua, vivace, ma in fondo gli spagnoli, noi spagnoli siamo un po’ così. In tutti i miei pezzi noto che c’è poca sapienza musicale, ma molto colore, sole, sapore di olive. E’ musica giovane con i suoi peccatucci e le sue piccole assurdità che però fanno uscire il sentimento. Ricorda gli intarsi dell’Alhambra, quegli arabeschi che in sé non dicono niente ma sono come l’aria, il sole, gli usignoli dei suoi giardini: sono la vera Spagna.”
Insomma di colui che è considerato il fondatore della nuova musica spagnola non esiste neanche un elenco completo delle opere. Questo succede quando si ha un carattere picaresco e avventuroso e non abbastanza metodico. A Bach non sarebbe mai capitato.
Perché, come abbiamo detto, Albeniz è un indisciplinato di costituzione, un confusionario, un disordinato.
Fra l’una e l’altra delle sue fughe da casa, nelle pause dei suoi giri concertistici senza contratti e senza progetti, lui ci riprova, ma inutilmente, a studiare ai conservatori, prima a Lipsia, in cui non resiste più di due mesi, e poi a Bruxelles dove conferma la fama del suo pessimo carattere e se ne va presto anche da lì.
Alla fine l’unica terapia che riesce a calmarlo è il matrimonio con una sua allieva con la quale ha due figli e finalmente si mette tranquillo.
Tutta la sua musica è scritta per il pianoforte, ma è assolutamente certo che dentro c’è anche un’altra anima ed è un’anima squisitamente spagnola.
E’ la chitarra. E infatti per primo Segovia, poi Tarrega e poi tanti altri solisti, attratti da questo richiamo nazionale, hanno trascritto (e continueranno a farlo) i suoi temi per le sei corde, fra le quali si sente subito che le melodie di Albeniz hanno trovato la loro seconda casa.
N° 616 - Microbiografie Irrispettose - Tomaso Albinoni 1671 - 1751

Ma Albinoni è una persona reale o è un mistero dietro un adagio? Vediamo un po’.
Tomaso nasce (e muore ottant’anni dopo) a Venezia, in una famiglia di mercanti di carta. È un’epoca in cui la carta è una merce pregiatissima, quindi gli Albinoni non se la passano affatto male.
Come primogenito sarebbe toccato a lui mandare avanti la bottega di famiglia alla morte del padre; invece quando aprono il testamento si scopre che il saggio papà lo ha liberato da questo sgradito peso, scaricato su un fratello. Quindi, via per la strada dell’arte!
Non ha bisogno di guadagnarsi il pane; è uno dei pochi fortunati dell’epoca che si può permettere di snobbare il servizio di principi, duchi, re o arcivescovi, che, certo, garantiva un tetto e la cena ma anche l’obbedienza ai capricci del padrone.
Fa, in anticipo sui tempi, il compositore indipendente e arriva a rifiutare di iscriversi all’Arte dei Sonatori della Serenissima, di cui invece è membro il suo amico Vivaldi, mentre mantiene l’associazione all’Arte dei Cartari.
Quindi non si esibirà mai in pubblico (perché senza l’iscrizione non glielo lascerebbero fare e comunque non gli interessa neanche un po’) né fa parte del mondo dei musicisti professionisti di Venezia; rimarrà sempre un “Musico di violino, dilettante veneto”, come gli piace presentarsi, che però riesce a tirar fuori un reddito dalla sua attività di compositore.
Intendiamoci, non è ancora arrivata la benedetta epoca dei diritti d’autore, quindi il suo è un reddito appena dignitoso, tanto è vero che a Venezia abita sempre in una zona poco chic e fuori mano, fra S. Trovaso e S. Barnaba, popolata da nobili decaduti, chiamati, appunto, Barnabotti.
Da tutti è stimato all’altezza dei suoi contemporanei Corelli, Scarlatti e Vivaldi. Sappiamo anche che è stato il primo compositore italiano a scrivere concerti per oboe, uno strumento ancora poco usato, che lui finalmente valorizza.
Poco però possiamo dire della sua musica a confronto con quella degli altri perché molti suoi manoscritti, che erano conservati nella Biblioteca di Stato di Dresda, se ne sono andati in fumo nei furiosi bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
E allora come mai il nome di Albinoni è così familiare?
In realtà non lo è mai da solo, ma sempre in coda al titolo: “L’adagio di…”, una bellissima composizione che ci viene servita da anni, mattina e sera come contorno di matrimoni, lauree, funerali (quello di Berlinguer nell’84 e quello della Thatcher nel ‘13), a commento di film (“Gli anni spezzati” di Peter Weir), citata in dischi (I Doors: “An American Prayer”).
Ma sotto c’è un quasi giallo storico-musicale. Eccolo:
Un bel giorno del ‘900 un musicologo, Remo Giazotto, già noto come studioso di musica barocca e specialista di Albinoni, si fa vivo e racconta di aver recuperato nella Biblioteca di Dresda una serie di frammenti che ha copiato e dai quali ha ricostruito un brano per archi e organo; e lo pubblica nel 1958, con il titolo di “Adagio in Sol minore” a firma di Tomaso Albinoni.
La scoperta non può essere documentata, dichiara il maestro Giazotto, perché quei frammenti sono andati distrutti insieme a tutto il resto nei bombardamenti citati prima. Da quel momento, un po’ per la sua storia avventurosa, un po’ perché è davvero bellissimo, il tema acquista quella immensa popolarità che ha ancora.
È solo nel 1998 che la nebbia si solleva. In quell’anno Giazotto muore e si viene a sapere che fra le macerie della biblioteca non ci è mai finito nessun frammento di musica di Albinoni perché non c’era neanche prima della guerra. Lo studioso si è inventato tutto!
L’Adagio è una composizione originale di Giazotto. Per quasi mezzo secolo il mondo della musica colta non ha avuto il minimo dubbio su questa faccenda. Ormai è troppo tardi per interrogarne l’autore. Un falso clamoroso come questo bevuto in un sorso da tutti: profani e, peggio ancora, esperti.
Il risultato è che Albinoni è diventato e rimarrà famoso per un brano di musica struggente e bellissima che non è suo, Giazotto è diventato e rimarrà famoso (magari un po’ meno) anche lui per la burla ben riuscita, e ancora di più per essere il vero autore di un brano di musica struggente e bellissima e i sapientoni studiosi del barocco sono diventati e rimarranno famosi per essersi fatti gabbare così bene e così a lungo su un brano di musica struggente e bellissima.
Bravi tutti.
N° 615 Microbiografie Irrispettose - Alecsandr Skriabin 1872 - 1915

“Visse tutta la vita sopra le righe, e poi morì per un foruncolo”. È la lapide che andrebbe scolpita sulla tomba di Aleksandr Skrjabin.
È un pianista compositore che parte galoppando all’inseguimento romantico di Chopin, ma poi il suo destriero si azzoppa e lui si ritrova sconcertato nell’atonalismo, guadagnandosi sulla Grande Enciclopedia Sovietica il podio di “Compositore più amato e nello stesso tempo più detestato di tutta l’Unione”. E anche la dichiarazione che “Nessuno fu più famoso in vita e pochi furono così rapidamente ignorati dopo la morte”.
Nasce a Mosca e giovanissimo già studia con Nicolaj Zverev che ha come allievo anche Rachmaninoff e, spesso a casa sua come ospite, Ciaikovskij. Insomma, nell’ambiente ci si trova a sguazzare subito.
Ha mani piccole; diventa lo stesso un abile pianista ma si sente inferiore al suo compagno Rachmaninoff che invece le mani le ha enormi e allora fa la stessa stupidaggine commessa a suo tempo da Schumann. Si sottopone a un esercizio massacrante: nel suo caso eseguire tutte le 32 sonate di Beethoven senza fermarsi mai. Naturalmente si procura un danno ai tendini, che il suo medico dichiara irreversibile, ma che, dopo un po’ di tempo per fortuna rientra.
Finiti gli studi di composizione e rifiutato il diploma per fare un dispetto al suo professore, Aleksandr si dedica all’insegnamento, sposa una pianista, ha sette figli; poi lascia lei, Mosca, i bambini, la cattedra di pianoforte al Conservatorio e parte per un giro di concerti in Europa con una studentessa con la quale ha un altro figlio, Julian, un bambino prodigio che annega a undici anni dopo aver composto opere sorprendentemente raffinate e mature. A questo punto torna a Mosca.
Si inventa una tastiera da cui il pianista può proiettare su uno schermo un fascio di luce del colore corrispondente (per lui) alla nota suonata e la fa costruire per l’esecuzione della sua composizione “Prometeo”.
A questo proposito Rachmaninoff riferisce nella sua autobiografia una accesa conversazione fra Skrjabin e Rimskij-Korsakov, dalla quale emerge un ovvio ostacolo al progetto: la probabilità, anzi la certezza che musicisti diversi troveranno sempre associazioni diverse fra suoni e colori. Per esempio, mentre il Re è per tutti e due gli interlocutori marrone, il Mi bemolle è rosso per Skrjabin, blu per Rimskij-Korsakov. E allora come ci si può intendere tra suoni e colori? Infatti l’idea non farà molta strada.
Fra le tante cervellotiche certezze Skrjabin ha anche quella che un giorno il calore distruggerà la terra. Nel frattempo annaspa in un confuso vortice di pensieri che lo sballottano dall’arte totale e dalle teorie superomiste di Nietsche alla teosofia, al misticismo e al cosmismo. Progetta la rigenerazione dell’umanità in una missione cosmica di evoluzione e trasformazione attraverso la spiritualità e la tecnologia.
Insomma è certo di avere il compito di salvare l’essere umano con la sua arte e questo risultato pensa di raggiungerlo con il suo “Mysterium”, un’opera multimediale della durata di una settimana fatta di suoni, danze, luci, profumi sul tema del giudizio universale, da mettere in scena in una struttura appositamente costruita ai piedi dell’Himalaya.
L’esecuzione non ci sarà mai, ovvio. Alla fine tutti d’accordo, amici e nemici, con la definizione di Horowitz: “Un folle ipocondriaco pieno di tic, incapace perfino di stare fermo a sedere”.
A 43 anni, al culmine della sua carriera, ammirato dal pubblico per le sue doti di pianista e per la visionarietà della sua musica, Skrjabin dà l’ultimo concerto che ha un immenso successo, a proposito del quale ricorda di avere corso un grosso rischio: “Durante l’esecuzione dimenticai completamente che suonavo per il pubblico…di solito dovevo controllarmi attentamente per non perdere la padronanza di me stesso”.
Una mattina, mentre si spunta i baffi, nota sul labbro superiore un foruncolo. Non ci fa troppo caso, ma qualche giorno dopo gli viene un po’ di febbre, l’infiammazione aumenta, il foruncolo diventa una pustola, poi un’ulcera. La temperatura sale a 41, si tenta un’incisione, ma ormai la setticemia gli ha infettato il sangue e in un paio di giorni Skrjabin è spacciato.
Quello che per qualsiasi altro uomo sarebbe stato un semplice fastidio, per lui è diventato una condanna a morte.
N° 614 - Microbiografie Irrispettose - Gustav Mahler 1860 - 1911

Gustav apre gli occhi in una affollata covata di ragazzini, figli di un cocchiere ebreo il quale, pochi mesi dopo la sua nascita, cambia mestiere e apre una distilleria.
I genitori litigano spesso, alcuni dei fratellini gli muoiono accanto e il locale di papà è frequentata dai minatori della zona, gente dalle ebbrezze funeree. Ecco il terreno su cui comincia a formarsi il carattere non proprio allegro del ragazzo.
Con la musica attacca subito. Data la durata media della vita a quei tempi, o i geni cominciavano prestissimo o non facevano in tempo a combinare niente.
A diciott’anni è diplomato, a venti parte la sua fenomenale carriera di direttore d’orchestra coronata da straordinari risultati nella valorizzazione del repertorio, da vette di perfezione delle orchestre che prepara, ma anche da continue, colleriche turbolenze direttoriali.
A questo proposito c’è da tenere presente la scarsa preparazione tecnica delle formazioni dell’epoca e l’imperfezione meccanica degli strumenti, tanto è vero che composizioni oggi perfettamente accettate, allora erano considerate ineseguibili. Quindi un direttore esigente com’era certo Mahler doveva essere subito dai suoi orchestrali come un implacabile rompiscatole.
Il suo percorso di compositore, invece, richiede più tempo; stenta parecchio all’inizio, non certo favorito da Brahms, dio della Vienna di quel tempo, che lo ha in antipatia; e arriva al livello di apprezzamento che merita solo verso fine corsa, con una botta di popolarità postuma grazie all’adagetto della sua quinta sinfonia inserito in “Morte a Venezia” di Visconti.
Pochi i numeri delle sue opere, ma ipertrofiche le dimensioni e le durate (in questo prende dal suo maestro Bruckner). Alcune delle sue sinfonie hanno soprannomi che ne richiamano il gigantismo: “Il Titano” “La Sinfonia dei Mille” e tutte richiedono un organico di minimo centoventi strumentisti più centinaia di coristi. E non durano mai meno di un’ora.

Costipato dai suoi trionfi come direttore d’orchestra, ruba il tempo per comporre durante le vacanze in Carinzia. Ha talmente bisogno di concentrazione che si fa costruire una capanna nel bosco (senza gabinetto, aggiunge il biografo, chissà perché questa precisazione), dove si rinchiude con il suo pianoforte e lì effettivamente riesce a lavorare in solitudine silvestre, come un Grande Puffo della Musica.
Anche nella sua vita, come in tante altre in quel periodo e da quelle parti, arriva l’incontro con l’antisemitismo. Se vuole occupare la più prestigiosa carica di tutto l’Impero Austroungarico, la direzione dell’Opera di Corte, lui ebreo deve convertirsi perché, per legge, il Direttore ha da essere cattolico (sorprendente, nella civilissima Austria).
E Mahler si converte, per opportunismo diranno i suoi nemici; per buon senso gli amici. Non si confesserà né andrà mai in chiesa se non per sposarsi, e se fosse stato saggio avrebbe saltato anche questo passaggio.
Invece nel 1902, sposa Alma Schindler e cominciano i guai. Gustav, grandissimo musicista, come uomo non è all’altezza di questa signora di vent’anni più giovane, che è una instancabile seduttrice e ancora di più una collezionista di grandi cervelli e nomi famosi.
Non è una sciocca falena, attenzione; è una leggenda vivente che lei stessa ha creato e continuamente rinnova. Compone musica e Mahler tenta di proibirglielo; discute con Thomas Mann che le risponde per le rime; provoca Gustav Klimt il quale le fa un ritratto; ispira Alban Berg e lui le dedica un concerto. Poi ci sono anche quelli che la odiano, come lo scrittore Canetti.
Un bel giorno lei, ancora sposata con lui, si innamora di Walter Gropius, un famoso architetto dell’ambiente viennese, quell’ambiente che è diventato il faro dell’Europa intellettuale, artistica e musicale anche per merito dello stesso Mahler. Dopo Gropius toccherà al famoso pittore Kokoshka, poi al famoso scrittore Werfel e poi a parecchi altri, naturalmente tutti famosi anche loro.
È allora, nel 1910, che il povero Mahler, pluritradito, si rivolge per aiuto a un altro viennese famoso, Sigmund Freud, il quale, dopo un colloquio di quattro ore con lui, scrive: “Nessuna luce illuminò i sintomi della sua nevrosi ossessiva. Era come scavare con un bastoncino in un edificio misterioso”. Anche se si fosse accesa, quella luce non avrebbe fatto in tempo a illuminarlo: un anno dopo muore.
Da tempo si porta dentro un’endocardite maligna che prima di ucciderlo gli rovina gli ultimi anni, rallegrati, è vero, dal trionfo in USA come direttore e dal riconoscimento universale come compositore, ma mortificati da una routine da invalido e da cure faticose e inutili, mentre tenta di finire la sua Decima sinfonia.
La Decima? Cosa combina di sciocco questo genio superstizioso? Contro la minaccia della Sinfonia Numero Nove (l’ultima per molti suoi colleghi che dopo averla scritta sono morti), pensa di fare il furbo. Finita l’Ottava decide di passare direttamente alla Decima e incolla un abusivo Numero Nove su una sua composizione già pronta, “Das Lied von der Erde” che sinfonia non è.
Non funziona. Questi trucchi contro il destino non funzionano mai, si sa.
N° 613 - Microbiografie Irrispettose - Anton Bruckner 1824 - 1896

“Per metà un dio, per metà un babbeo”. Così Mahler poco cristianamente (parlando proprio di lui che era cristianissimo) descrive Bruckner, grande musicista ma piccolo uomo. Umilissimo e insicuro, privo di carattere, terribilmente influenzabile da tutti: dai colleghi, dai critici, dai direttori d’orchestra, perfino dagli orchestrali.
Primo di undici figli, Anton Bruckner entra presto in contatto con la durezza della vita: uno dopo l’altro gli muoiono ben sei fratellini. A tredici anni gli muore anche il padre. Lo stesso giorno del funerale mamma Bruckner lo porta all’Abbazia di Sankt Florian per affidarlo al priore.
Qui è più fortunato: ha buoni insegnanti e fa bei progressi. Ma finiti gli studi si trova a un bivio e sbaglia subito strada: invece di continuare con la musica decide di seguire la carriera scolastica.
Passa anni a fare il maestrino nei paesi del circondario, ma per fortuna la musica non l’ha abbandonata. Come primo punto di partenza ottiene la carica di organista nell’Abbazia di Sankt Florian, dove ha studiato.
Avrà anche fatto un passo avanti ma è rimasto il solito semplicione di sempre: pensa di essere in grado di cercarsi una fidanzata e poi non riesce neanche a decidere a chi proporsi. Con la musica gli va ancora peggio: spedisce a Ignaz Assmayer, notissimo docente viennese, qualche sua composizione da esaminare. “È meglio che lei cambi strada e abbandoni la musica” è la risposta.
Abbattutissimo, Bruckner si iscrive al concorso per un impiego di funzionario statale ma, è il colmo, lo bocciano anche qui.
Alla fine la musica sarà, malgrado tutto, la sua strada. Decide di andare a Vienna per un esame di organo con quello stesso Assmayer che lo aveva così maltrattato e che questa volta lo promuove a pieni voti. A Vienna incontra il meglio dei musicisti dell’epoca e tutti insistono perché abbandoni l’ambiente provinciale di Sankt Florian e si decida a debuttare in società nella capitale.
Il nostro timidone si mette in movimento: vince il concorso di organista per la Cattedrale di Linz e in questa città va ad abitare per un po’; poi fa un figurone all’organo di Salisburgo per il centenario di Mozart; finalmente ottiene il certificato di maestro di musica dal conservatorio di Vienna, con questa nota da parte di uno degli esaminatori: “Se io sapessi la decima parte di ciò che lui sa, mi stimerei felice. È lui che avrebbe dovuto esaminare noi”.
In un viaggio a Monaco conosce Wagner e se ne innamora perdutamente e, lo scoprirà in seguito, questa passione sarà uno dei grossi problemi della sua vita perché lo sbatterà nelle trincee della guerra fra wagneriani e brahmsiani che in quel periodo infuria e fa morti e feriti.
Nel 1867 è finalmente pronto a lasciare Linz, dove è diventato il bersaglio della gente che lo trova bizzarro, scorbutico e mal vestito “abiti tagliati da un falegname”, ma è anche molto preoccupato per l’imminente trasferimento a Vienna.
E allora che succede? Gli dà di volta il cervello. “Crisi paranoica, sovreccitazione estrema mista a un sentimento di totale abbandono”.
La sua nevrosi si manifesta con ossessioni ridicole: ha paura che il Danubio si prosciughi; si sente costretto a contare e ricontare tutti gli oggetti di casa. Lo ricoverano, lo curano con frequenti docce (evidentemente all’epoca considerate soprattutto una medicina) e finalmente si calma.
Riesce a diventare professore al Conservatorio e organista di Corte malgrado la feroce opposizione di colui che da questo momento si manifesta come il suo arcinemico: Eduard Hanslick, un notissimo critico fanatico di Brahms e ostile a Wagner e a tutti i wagneriani, quindi anche a lui.
A Vienna Bruckner ce la mette tutta, ma il suo carattere timido e paesano lo tiene lontano dai circoli che contano. In più la sua amicizia per Wagner comincia a manifestare spiacevoli controindicazioni e ad allontanare molti di quelli che gli servirebbero. Perfino l’insolente segretario del conservatorio arriva a suggerirgli di buttare le sue sinfonie nel caminetto e dedicarsi alle più redditizie riduzioni per pianoforte.
Nel ’73 va a Bayreuth da Wagner e gli porta da esaminare la Terza Sinfonia. Wagner la dichiara un capolavoro e ne accetta con entusiasmo la dedica. Ma quando Bruckner torna a Vienna ci trova ad aspettarlo, suo dichiarato avversario, niente di meno che Brahms in persona.
La guerra entra nel vivo con l’esecuzione trionfale dell’Anello del Nibelungo, a cui Bruckner assiste invitato dallo stesso Wagner. Proprio a causa della dedica a Wagner molti direttori si rifiutano di eseguire la sua Terza Sinfonia e allora la dirige lui stesso in una serata disastrosa fra fischi e urla del pubblico, il tutto aggravato dal grande successo, pochi giorni dopo, della Seconda di Brahms. In un conflitto così violento ci va di mezzo come sempre il proverbiale capro espiatorio, e stavolta tocca a lui, al povero, ingenuo Bruckner.
A proposito di ingenuità c’è questo tenero aneddoto: febbraio ’81, il grande direttore Hans Richter porta al successo la Quarta Sinfonia di Bruckner. Alla fine del concerto, l’autore entusiasta va sotto il podio e gli porge un tallero: “Maestro, prendete e bevete alla mia salute”. Richter, commosso, invece che in birreria, il tallero lo porta al suo gioielliere e lo fa montare sulla catena dell’orologio.
Malgrado questi occasionali successi, la vita di Bruckner continua grama a Vienna, anche per le manovre dell’arcinemico Hanslick. Più tardi, quando in Germania la sua fama è ormai solida e c’è chi comincia a paragonarlo a Beethoven, l’eco di questo successo arriva, irritandolo, all’orecchio di Brahms che reagisce definendo Bruckner “Un uomo privo di senno che i preti di Sankt Florian hanno sulla coscienza”. E non manca la pugnalata dell’arcinemico che aggiunge: “Il cervello di Bruckner è obnubilato dall’incenso”.
Nell’autunno dell’89 un gruppo di musicisti viennesi, per tentare una riconciliazione fra i due nemici, organizza una cena sociale all’Istrice Rosso, la trattoria di Brahms. Imbarazzo iniziale, poi, quando arrivano i knödel: “Ah, Herr Brahms, vedo che c’è almeno un punto su cui ci intendiamo”, fa Bruckner indicando il piatto e da quel momento la cena procede in serenità, ma, a parte i knödel, tutto rimarrà come prima.
Poi il declino: il successo aumenta, la salute cala e alla fine il povero Bruckner perde anche la sua ultima corsa con la morte e non riesce a finire la nona sinfonia.
Il suo corpo tornerà definitivamente là dove tutto era cominciato: a Sankt Florian.
N° 612 - Microbiografie Irrispettose - Franz Joseph Haydn 1732 - 1809

Povera, poverissima è la prima parte della sua vita. Ci sono dei momenti che non ha neanche abbastanza da mangiare. E infatti quando si parla del suo aspetto vengono fuori la bassa statura e la taglia striminzita, colpa della denutrizione, a cui, dopo, si sono aggiunti la calvizie e in faccia i segni del vaiolo. Insomma non è una bellezza.
Figlio di un miserando carrettiere e di una cuoca che avevano una sterminata quantità di bambini dei quali sopravvissero soltanto (!) Joseph e cinque fratelli, comincia presto a trovare interessante quello che suo padre tira fuori da un’arpa con cui si accompagna quando trotta.
Intorno ai cinque anni inizia a studiare, tutto da solo, composizione. Trova una scodella di zuppa per sfamarsi cantando nel coro dei bambini del Duomo di Vienna, ma a un certo punto gli cambia la voce, naturalmente lo mandano via e così rimane senza zuppa e ritorna la fame. Che lui, con il condimento del suo naturale ottimismo riesce a tenere a bada suonicchiando ai matrimoni e ai battesimi e con qualche lezione privata.
Ha un piccolo lampo di fortuna quando incontra il vecchio compositore napoletano Nicola Porpora in visita a Vienna. A Porpora piace e lo assume con il doppio incarico di accompagnatore al clavicembalo degli studenti a cui insegna canto e di cameriere personale, pagato a forza di lezioni di composizione. Non senza la frequente gratifica di “asino” o “birbante” accompagnati da sonori schiaffoni, che Haydn riceve “senza prendermela perché da Porpora appresi molto di canto, di composizione e di italiano”.
Il suo menu migliora man mano che si guadagna la protezione di qualche piccolo nobile, senza la quale non si campava in un’epoca di profonda disistima della professione di musicista. Prima dalla contessa Thun, poi dal conte Morzin che lo assume come maestro di cappella della sua minuscola orchestra. Lo paga poco e quasi subito, finiti i talleri, lo liquida.
È la sua fortuna, perché questo licenziamento lo getta fra le braccia della famiglia Esterhazy, braccia generose che lo accoglieranno per trent’anni della sua vita permettendogli di comporre una quantità impressionante di sinfonie, concerti, quartetti e sonate e, man mano che cresce la sua fama, di scrivere musica anche per clienti al di fuori della corte dei principi, che, da quei magnanimi protettori che sono, gli permettono di farlo.
Alla corte degli Esterhazy, specialmente del Principe Nicolaus, favolosamente ricco e così appassionato di musica da essersi fatto costruire un teatro al castello, Haydn gode del massimo rispetto, riesce a lavorare sereno e anche a tutelare i suoi colleghi suonatori.
Nel 1790 Nicolaus muore e suo figlio Anton, a cui poco interessa la musica, sopprime l’orchestra ma garantisce a Haydn un vitalizio, così finalmente il compositore è libero di accettare le offerte dell’impresario Salomon che lo chiama in Inghilterra, dove ha un successo superiore a ogni aspettativa: gli danno addirittura una laurea honoris causa a Oxford.
A fine secolo, ricco e famoso, torna a Vienna, si fa costruire una grande casa e passa gli ultimi anni a comporre, con la calma che non aveva mai avuto prima (sempre affannato a rispettare le molte scadenze della vita musicale di corte) i due oratori che lo hanno reso ancor più celebre.
Muore nel 1809 durante l’assedio dei francesi. Al suo funerale Napoleone manda un picchetto d’onore.
Com’è la sua musica? Beh, il compito del compositore di corte del suo tempo è far sì che tutto sia progettato e realizzato per intrattenere il principe e i suoi ospiti, quindi festa, allegria e spensieratezza.
Quella serpe di Wagner, nel commentare il rapporto di Haydn con il suo signore scrive queste simpatiche parole: “Haydn era e rimarrà un servitore principesco al quale è affidato il compito, in qualità di musicista, di distrarre un padrone che vive nel fasto”.
Ma Haydn non fa nessuna fatica perché questa atmosfera corrisponde al suo carattere positivo e giocherellone. Un esempio è la Sinfonia numero 45 (Gli addii) in cui, nell’ultimo movimento, prende bonariamente in giro il suo principe facendo alzare uno alla volta i musicanti che smettono di suonare, spengono la candela sul leggio e lasciano il palco, finché in scena rimane, da solo, l’ultimo violinista.
Le sue quattordici messe sono talmente gioiose che irritarono Mendelssohn il quale le definì “scandalosamente allegre”. A questo giudizio Haydn così avrebbe potuto rispondere: “Quando penso a Dio il mio cuore è talmente pieno di gioia che le mie note sgorgano come da una sorgente”.
Amen.
N° 611 - Microbiografie Irrispettose - Erik, anzi EsotErik Satie 1860 - 1925

Erik Satie, anzi, EsotErik Satie, come lo chiamano gli amici: un rompiscatole di genio. Caratterizza con la sua personalità stravagante e scomoda il passaggio dall’Otto al Novecento, un periodo pieno di fermenti. Musicista, pittore, scrittore di teatro e cinema. Impressionista, simbolista, cubista, dadaista. Un tipo esoterico, appunto.
Gli muore la madre. Il padre si risposa con una maestra di pianoforte, la quale tenta di insegnare a Eric, dodicenne, lo strumento, ma lui si impenna e sceglie di detestare il pianoforte e la musica in generale.
Malgrado questo capriccio, da quel bastian contrario che è, nel ’79 entra al Conservatorio di Parigi, che battezza “una specie di prigione senza attrattive sia all’interno che fuori”. Dopo un paio d’anni i suoi professori lo giudicano un somaro e lo cacciano. Lui continua a studiare per conto suo e nel 1885 è riammesso ma il giudizio rimane lo stesso.
Deluso, si arruola in fanteria, capisce presto che l’esercito non fa per lui e una notte d’inverno rimane apposta fuori al freddo e alla pioggia; si prende una polmonite, ma insieme al malanno rimedia anche il congedo.
Capito il genere? Continua a sviluppare il suo carattere provocatorio, ruvido, imprevedibile. Che si ritrova nelle sue composizioni, per esempio “Ogives”, titolo bizzarro, scrittura senza segni di misura e di espressione e con annotazioni personalissime, difficili da seguire nell’esecuzione.
A 22 anni compone le tre famosissime Gimnopedie per piano solo. Ma fare l’autore non gli basta per vivere, quindi si deve trovare un lavoro come secondo pianista al “Le Chat Noir”. Naturalmente litiga subito con il proprietario e allora si trasferisce all “Auberge du clou” dove conosce il futuro amico di una vita, Debussy.
Dichiaratamente misogino, senza preavviso si fidanza con Suzanne Valadon, madre del pittore Utrillo, ma neanche questa faccenda dura e, finita la storia, Eric va ad abitare in una zona di Parigi miserabile e piena di zanzare. La notte continua il suo vagabondaggio fra i locali di Monmartre dove accompagna al pianoforte i cantanti.
Intanto ha composto i tre brani di commento per la pantomima “Jack in the Box”, ma al momento di metterla in scena non si trova più la partitura. È sicuro di averla persa in autobus e il progetto naufraga. Invece, dopo la sua morte la scoprono sprofondata nella cassa del pianoforte.
Finalmente nel 1917, insieme al poeta Cocteau e a Picasso come scenografo mette in scena su commissione di Diaghilev, il famoso coreografo dei Ballets Russes, “Parade”, in cui la musica è farcita di innesti per allora audaci: sirene, macchine da scrivere, pistole e altri attrezzi non propriamente musicali. Poco apprezzata dal pubblico, ma non da uno spettatore d’eccezione: Marcel Proust.
Nel 1925, a forza di serate passate suonando e soprattutto trincando nei locali di Parigi, il fegato di Satie viene fulminato da una bella cirrosi che lo porta dritto alla tomba.
In fondo è durato più del previsto.
A proposito di bizzarrie, Satie abita per tanti anni in un appartamento che lui chiama “l’armadio”, composto da due stanze: in una vive, l’altra è perennemente chiusa a chiave. Dopo la morte la aprono e la trovano piena di ombrelli che lui colleziona. Scoprono anche una quantità impressionante di completi di velluto tutti uguali, nonché cappelli a cilindro e cravatte a fiocco che indossa quando siede al pianoforte.
È anche fissato con il numero tre, tanto che molte sue composizioni si presentano, appunto, in forma di trinità. Non finisce qui; Satie è anche famigerato per aver scritto il brano più lungo della storia: “Vexations”, composto da trentacinque battute da ripetere 840 volte; venti ore in tutto.
E i suoi titoli? ”Tre pezzi in forma di pera”, “Preludi flaccidi per un cane”, “Embrioni secchi”. Stravinskij racconta: “Satie mi suonò al piano molte sue composizioni. La parte più interessante erano i titoli dei pezzi”.
Il modesto numero delle sue opere lo metterebbe nell’angolo dei musicisti poco prolifici e di scarso peso. In realtà la sua importanza non sta tanto nella musica che ha scritto quanto nella sua modernità e nel suo riuscire a essere il cardine di tanti scambi (alcuni pazzi e altri forse inutili, ma comunque interessanti) fra i movimenti culturali dell’epoca.
A proposito di modernità, ecco quello che un giorno, seduto in un caffè, disse al suo amico Fernand Leger: “Sai, bisognerebbe creare della musica d’arredamento, cioè che tenesse conto dell’ambiente in cui viene diffusa. Melodiosa abbastanza da coprire il suono metallico dei coltelli e delle forchette, senza però cancellarlo completamente. Da riempire i silenzi talvolta imbarazzati dei commensali e risparmiare il solito scambio di banalità”.
Suona familiare, anzi, proprio all’avanguardia, no?
N° 610 -Microbiografie Irrispettose . Gli Strauss Johann Strauss Figlio 1825 -1899

Papà era stato eletto Padre del Valzer; lui sale più in alto e ne diventa il Re (“Il Bel Danubio Blu”, che altro serve?) In una inchiesta dell’epoca risulta il più popolare personaggio di tutta l’Europa, preceduto solo dalla Regina Vittoria e da Bismarck.
A diciannove anni richiede al Municipio di Vienna l’autorizzazione a “guadagnarsi da vivere come direttore d’orchestra” La ottiene, inizia con un gruppo di 24 musicisti e si scontra subito con i maneggi del padre che continua ad opporsi al suo lavoro. Molti locali di Vienna non osano scritturarlo perché il veto del vecchio fa paura.
Solo il Casinò Dommayer rischia e il 15 ottobre 1844 organizza il primo concerto dell’orchestra di Johann Strauss Figlio. Il padre manda alcuni osservatori per sapere come andrà e magari disturbare. Il pubblico incuriosito riempie la sala in un attimo. In programma ci sono ouverture di opere famose, composizioni originali di Strauss figlio e per concludere con un gesto di omaggio, un valzer del padre.
La serata è un successo clamoroso. Alcuni brani sono bissati fino a diciannove volte. I disturbatori, venuti per fischiare, alla fine applaudono insieme al pubblico. I locali che lo avevano rifiutato per paura di offendere il padre ora gli aprono le porte e subito si formano due partiti: il passatista che sostiene il padre, il modernista fatto di studenti di Vienna e delle minoranze nazionaliste dell’Impero che appoggia il figlio, il quale li ricambia con titoli come: ”I Giovani Viennesi”, “Valzer Ceco”, “Quadriglia Serba”, “Pot-pourri Slavo”.
Questa guerra di famiglia ha anche dei momenti comici: papà Johann è da tempo Direttore della Musica del Primo Reggimento Cittadino. Johann figlio ottiene la stessa carica nel Secondo Reggimento e così succede che a volte i due si trovino a marciare fianco a fianco in piazza d’armi.
Ma ci sono anche i momenti storti: il giorno dopo l’incoronazione dell’Imperatore Francesco Giuseppe, Johann Figlio commette l’imprudenza di dirigere in un concerto pubblico la vietatissima Marsigliese. Arresto immediato, segnalazione alla polizia e una bella frenata per la carriera.
Nel ‘49 muore Johann Senior e il figlio finalmente sale sul podio dell’orchestra paterna in un concerto in memoria del defunto. Qualche resistenza da parte degli orchestrali, ma alla fine vince lui e diventa l’unico Strauss della città.
Durante il carnevale Johann Figlio, ormai famoso, si trova a dirigere contemporaneamente tre orchestre in tre locali diversi fra cui si sposta in carrozza con apparizioni fulminee per dare l’impressione di essere dappertutto.

Ma anche la resistenza di uno Strauss ha un limite, così nel 1853 ha un collasso da superlavoro e si deve fermare. Da questo momento lo Strauss unico diventa doppio perché il fratello Josef, avviato a una bella carriera di ingegnere ma con ottima conoscenza della musica, viene assorbito nella ditta e messo al lavoro. E quando anche lui si trova sopraffatto da tutti quegli impegni, diventa trino perché in ditta entra anche Eduard, un altro fratello, destinato alla diplomazia ma catapultato a forza sul podio.

Nel 1861 la valanga Strauss tutto travolge quando i tre fratelli con le loro orchestre si esibiscono insieme in una galoppata-monstre suonando fra gli applausi tutto il loro repertorio di valzer, polke e marce. Il quale repertorio ormai si è guadagnato il diritto di abbandonare le birrerie ed entrare in sala da concerto.
Quella stessa sala, il Musikverein, dove, ancora un secolo e mezzo dopo, si festeggia il capodanno con il pubblico che batte il tempo sulla Radetzky Marsch e sogna con il Danubio Blu.
Nel ’70 Josef muore. I due superstiti cominciano a litigare e Eduard accusa Johann di averlo ammazzato di troppo lavoro.
Il lavoro invece non è mai troppo per Johann, che nella sua fissazione efficientistica accetta contratti a condizioni decisamente non sindacali.
La linea ferroviaria russa Pietroburgo – Pavlovsk (rinomatissimo centro turistico) ha un teatro, appunto a Pavlovsk, nel quale, nei tre mesi estivi, tutti i giorni dalle 19 alle 22, quando parte l’ultimo treno, c’è un concerto per intrattenere i viaggiatori in attesa; un’idea davvero carina che piace molto ai nobili passeggeri.
Bene, Strauss firma un contratto per partecipare con la sua orchestra a queste serate nel teatro di Pavlovsk, tutte le estati, per tre mesi, per undici anni, con enorme successo, conquistando l’alta società russa e approfittandone per presentare nuove composizioni, fra cui la Marcia dell’Incoronazione dedicata allo Zar Alessandro II, il quale, quando può, prende il suo trenino da Mosca e lo va ad ascoltare. Verso la fine dell’impegno Johann bara un poco facendosi sostituire ogni tanto dai suoi fratelli.
Nei momenti liberi corre a Parigi per l’Esposizione Universale e lì dirige una sfilza di serate, lanciando in Francia il suo Danubio Blu che gli guadagna la Legion d’Onore.
Poi a Londra, dal 15 agosto al 26 ottobre 1867 si sfianca in sessantatré concerti alla Royal Italian Opera House. Il Times commenta: “Strauss dirige con il violino in mano e lo fa con trascinante vivacità”.
Nel ’72 parte per Boston dove ha un impegno per 14 concerti per i quali ottiene, anticipato, il colossale compenso di 100.000 dollari. Nell’enorme Coliseum, dirigerà un’orchestra di 1.500 elementi con un coro di 16.000 voci e una batteria di cannoni, per un pubblico di centomila spettatori, compreso il Presidente Grant.
Da una sua lettera all’amico Schnitzer al quale racconta la sua esperienza: “ E’ stata la cosa più incredibile che mi sia capitata…una schiera infinita di panche per gli oltre centomila spettatori…neppure con un cannocchiale si vedevano l’orchestra e i coristi…e tutto questo io lo dovevo dirigere. Mi erano stati messi a disposizione cento sottodirettori, ma io riuscivo a vedere solo quelli più vicino. Non c’era assolutamente da pensare a una esecuzione artistica, a sfumature e cose simili. Se mi fossi rifiutato di dirigere avrei probabilmente rischiato la vita. E così mi trovai sul podio più alto. Cominciò uno spettacolo infernale che non dimenticherò finché campo! Avevamo iniziato abbastanza contemporaneamente e grazie a Dio riuscimmo a finire tutti insieme. Gli ascoltatori urlavano la loro approvazione e io tirai un respiro di sollievo quando mi ritrovai di nuovo all’aria aperta e con i piedi per terra.”
I trionfi continuano, ma certo è impossibile ripetere un’esperienza simile. Fa un ultimo viaggio in Italia come direttore, poi affida la bacchetta ad Eduard, il fratello superstite, e si dedica a scrivere (ma ogni tanto ancora dirige) operette, in concorrenza con un collega altrettanto bravo e spiritoso: Offenbach. E produce capolavori come Lo zingaro Barone e il Pipistrello.
Un riconoscimento finale per Strauss è l’ammissione come socio onorario alla Società degli amici della musica dove si trova in buona compagnia: Brahms, Bruckner, Liszt, Verdi, Wagner, anche se ormai ha un’età e molti di quegli amici cominciano ad andarsene.
Il 22 maggio 1899 Strauss è sul podio a dirigere all’Opera di Corte il suo Pipistrello. Ha un attacco di vertigini, lascia l’esecuzione, si mette a letto e poco dopo se ne va anche lui.
Quel giorno il maestro Eduard Kremser sta dirigendo un concerto di musiche di Strauss Padre. Qualcuno si avvicina al podio e gli mormora la notizia. Kremser ferma l’orchestra, fa sostituire gli spartiti e attacca le prime note del Danubio Blu. Il pubblico capisce.

Supplemento agli Strauss
RICHARD STRAUSS 1864 - 1925
C’è ancora un altro Strauss, Richard; nessuna parentela ma l’omonimia suggerisce di citarlo qui. Famoso per le sue opere e i poemi sinfonici, ma soprattutto famosissimo per il “Così parlò Zaratustra” di Odissea nello Spazio.
E’ figlio del primo corno dell’Orchestra di Corte di Monaco, e della signorina Pschorr, rinomata birra bavarese. Comincia presto e raggiunge il successo soprattutto con alcune sue opere: “Elektra”, “La donna senz’ombra”, “Salomè”; ritirata quest’ultima dai palcoscenici americani su richiesta della Chiesa per via della scandalosa scena in cui la protagonista bacia la testa mozzata del Battista.
E’ sospettato di simpatie naziste, ma bisogna anche considerare che all’epoca se si voleva lavorare era impossibile non sporcarsi le mani. Sospetto fu anche, nel giorno del suo compleanno il regalo ricevuto da di Hitler: una foto con dedica.
Importante il suo lavoro per il riconoscimento della figura professionale del compositore, equiparato per la prima volta a un medico o un avvocato (fatto all’epoca di estrema avanguardia) e quindi col diritto a partecipare agli utili della propria opera.
Con questo obiettivo fonda nel 1903 un sindacato per la tutela dei diritti dell’autore.
Naturalmente per questo suo lavoro, a beneficio di sé stesso, certo, ma anche della categoria, è immediatamente accusato di affarismo e avidità.
Il gregge rimane stupido anche quando lavori per proteggerlo.
N° 609 - Microbiografie irrispettose - Gli Strauss - Johann Strauss Padre 1804 - 1849

C’era una volta…non c’è un modo diverso per cominciare questa bella fiaba che succede nel tempo giusto: l’ottocento, nel luogo giusto: Vienna, e dove alla fine tutti realizzano i loro desideri.
Ma torniamo al principio.
Come dicevamo, c’era una volta una giovane coppia che al numero 7 di Flossgasse a Vienna gestiva una locanda dove si fermavano a bere un bicchiere i marinai delle chiatte sul Danubio.
In questa locanda nasce Johann, insieme a altri cinque fratelli, tre dei quali morti da piccoli, come era normale a quei tempi. Anche la mamma muore poco dopo; il padre si risposa ma poi annega nel Danubio, forse suicida a causa degli affari che vanno malissimo. La matrigna sopravvissuta si risposa con un tale Herr Golder che riesce a sistemare i debiti della locanda e si affeziona ai ragazzini.
Johann comincia a manifestare interesse per le canzoni dei marinai e i concertini organizzati di tanto in tanto intorno al camino e allora Golder gli regala un violino giocattolo, ma quando si accorge che il bambino quel violino lo prende sul serio e volendo per lui una carriera rispettabile e non quella del musicista, cerca di fargli cambiare idea mandandolo, a dodici anni, a fare l’apprendista rilegatore di libri.
Johann non ci sta e dopo un po’ scappa nel bosco fuori città dove per sua fortuna incontra un bravo suonatore ambulante che lo riporta a casa e riesce a ottenere dal patrigno, a cui nel frattempo era passata l’arrabbiatura, il permesso di dare qualche lezione di musica al ragazzo.
Da qui parte tutto.
Presto le rozze lezioni dell’ambulante lasciano il posto a studi più seri.
Johann ha talento, evidentemente, tanto che già a quindici anni suona in una delle migliori orchestre da ballo di Vienna. Qui incontra e diventa amico (e futuro rivale) di Joseph Lanner, col quale, lasciata l’orchestra dove si sono conosciuti, ne fonda un’altra che diventa a sua volta la migliore della città (arrivano perfino a far pagare il biglietto d’ingresso, fatto inaudito all’epoca).
Ma poi litigano, si separano e per l’occasione Lanner scrive il “Valzer della separazione”, primo di una serie di composizioni come si usava allora, che con il titolo richiamano questo o quel fatto, questo o quel personaggio.
Nel 1825 sposa Anna e gli nasce il primogenito Johann, il futuro Johann Strauss Figlio, seguito da altri cinque fratellini. L’onda del successo si impenna: ha organizzato e coordina ben otto orchestre di venticinque elementi ciascuna, che suonano contemporaneamente sotto la direzione sua e di sostituti in giro per i locali di Vienna.
Wagner, presente in città in una di quelle serate, racconta di essersi annoiato a teatro, all’Ifigenia in Tauride di Gluck, a cui era stato portato da un amico intellettuale, ma di essersi poi divertito pazzamente in birreria dove “Il pubblico, inebriato più dalla musica che da quello che aveva bevuto, era infiammato da un entusiasmo quasi frenetico a ogni pezzo che Strauss dirigeva suonando il violino”.
Ormai padrone di Vienna, parte per una serie di giri trionfali in Europa: Austria, Ungheria, Prussia, dove la critica unanime dichiara: “Strauss è un fenomeno musicale. E’ il valzer personificato”.
Qualche tempo dopo, a Parigi, lo vanno ad ascoltare Berlioz, Cherubini, Paganini, Meyerbeer. Si congratulano con lui il Re di Francia e quello del Belgio. Poi, passata la Manica, si trova a Londra per l’incoronazione della Regina Vittoria che diventa una sua fan. E finalmente ritorna a Vienna dove incoronano lui stesso Padre del Valzer.
Ma è anche un padre infedele nella vita: Johann a Vienna, oltre a quella regolare con Anna, ha un’altra famiglia, con Emile, la quale gli darà a sua volta otto figli. Procreatore inveterato, finalmente scoperto, si trova costretto da Anna a scegliere fra lei e l’altra. Sceglie l’altra, divorzia e così Johann Figlio è finalmente sottratto al suo controllo e libero di prendere il volo.
Stranamente dimentico delle sue stesse difficoltà da ragazzo e cieco, invece di esserne orgoglioso, di fronte alla vocazione musicale di suo figlio, papà Johann è sempre stato ferocemente contrario al suo desiderio di diventare musicista e lo ha perfino iscritto al Politecnico per farne un bancario. Per fortuna mamma Anna, in contrasto da sempre con Johann Senior su questa decisione, riesce a organizzare per il ragazzo in gran segreto lezioni di musica con Franz Amon, che è il primo violino nell’orchestra del padre.
Quando papà Johann lo scopre fa una scenata terribile e distrugge il violino del figlio. Ma poi la simpatica e furba mamma Anna trova il modo di smorzare questa stupida ostilità, probabilmente puntando anche sui sensi di colpa che il fedifrago marito doveva avere per l’abbandono del tetto coniugale e il divorzio. E, come detto prima, Johann figlio è finalmente libero.
Durante la rivoluzione del 1848, Johann Senior ha appoggiato apertamente il potere, e ha composto in onore del Maresciallo Radetzky la “Marcia di Radetzky” diventata subito e rimasta per sempre il suo brano più famoso. Questo, specialmente fra i viennesi più giovani e barricaderi (compreso suo figlio), trasforma l’adorazione di prima in definitiva perdita di popolarità.
I tempi stanno cambiando ma il povero Strauss non lo capisce e aggrava la propria situazione scrivendo la “Marcia di Jelacic” e dedicandola al generale di questo nome che aveva represso ferocemente l’insurrezione.
Ormai non gli resta che scendere dal suo piedistallo.
Si ritira e poco dopo muore, ancora giovane.
Al suo funerale, malgrado tutto partecipano migliaia di viennesi e gli suonano il suo “Valzer del Viandante” che ha scritto prima di partire per l’ultima tournee.
N° 608 - Microbiografie Irrispettose - Jacob Bruskin Gershowitz 1898 - 1937

E’ il compositore più ricco di tutta la storia della musica.
Ma aveva cominciato come un galoppino in quello che, all’inizio del secolo scorso, era il sottobosco della musica popolare: Tin Pan Alley.
Un nome che letteralmente significa “Vicolo della Padella di Latta”, forse per lo strepito metallico delle pianole di quell’epoca, e identificava l’ambiente dell’editoria musicale di New York, raggrumato nella Ventottesima Strada, fra la Quinta e la Sesta Avenue.
Dove, in mancanza di altri mezzi per lanciare le nuove canzoni, c’era una miriade di stanzette dotate di pianisti tuttofare che le strimpellavano su pianoforti sgangherati per farle ascoltare a impresari, ballerini, cantanti e registi di musical.
Lui, figlio di una coppia di immigrati ebrei russi, è uno di questi pianisti.
Ci arriva dopo un po’ di lezioni sorbite di malavoglia. Comincia a quindici anni per quindici dollari la settimana. Riesce quasi subito a pubblicare una sua canzone che ha un piccolo successo.
Così sale il primo gradino che gli permette, arrivato a 18 anni, di portare il suo stipendio a 35 dollari, ma soprattutto di cominciare a scrivere sapendo che qualcuno lo ascolterà.
Altri due o tre tentativi, poi il botto: “Swanee”, incisa da Al Jolson, è prima in classifica per 18 settimane e lo spartito vende un milione di copie.
Inizia a collaborare con il fratello Ira che fa il paroliere, cambia nome d’arte diverse volte e, di successo in successo, arriviamo al 1924 quando, si dice in sole tre settimane, a soli venticinque anni, e da solo (ma con l’orchestrazione di Ferde Grofé perché proprio tutto da solo ancora non ce la fa) compone la “Rapsodia in Blu”, che debutta davanti al mondo culturale e artistico di New York, presenti Rachmaninoff, Stravinskij, Haifetz, con un successo fenomenale.
Stiamo parlando di Jacob Bruskin Gershowitz, ma ormai possiamo chiamarlo con il suo nuovo e definitivo nome americano: George Gershwin.
La Rapsodia non solo lo lancia in tutto il mondo, ma lo fa volare un po’ più in alto degli altri autori perché non è una canzonetta, non è un musical, non è un cabaret: è una composizione classica con la quale si entra nel repertorio rispettabile.
Lui ci tiene a essere considerato un musicista completo, secondo la tradizione, capace non solo di inventare i temi ma anche di scriverli per tutti gli strumenti e nel 1925 lo fa, stavolta veramente tutto da solo, orchestrazione compresa: il “Concerto in fa”.
Intanto continua a sfornare commedie musicali, piene di canzoni orecchiabili, una più bella dell’altra e soprattutto capaci di reggere centinaia di repliche che riempiono i teatri degli USA e il suo conto in banca.
Ma anche per lui è arrivato il momento speciale della vita: deve fare il grande passo. Un bel giorno fa le valigie e parte con il fratello per la Francia per diventare un compositore vero.

Che strano, nelle biografie di tanti artisti americani a un certo momento della loro vita si affaccia questo piccolo (o grande) complesso di inferiorità, questo debito, nei confronti della cultura, quella vera, che per i cittadini dell’ex colonia viene dall’Europa. E allora fanno le valigie e partono per il vecchio mondo per andare a pagarlo, quel debito.
Ma George proprio non ci riesce perché tutti i più rinomati professori lo accolgono sì a braccia aperte ma rifiutano di dargli lezioni: non vogliono inquinare con il rigore del passato la sua spontanea vena jazzistica, che tutti riconoscono immediatamente come roba fresca, di un mondo nuovo.
C’è addirittura il famoso aneddoto di lui che chiede a Ravel di insegnargli l’orchestrazione, e Ravel gli risponde: “Perché volete diventare un Ravel di seconda mano, quando siete già un Gershwin di prim’ordine?”
Naturalmente a Parigi scrive “Un Americano a Parigi”, e naturalmente anche questo è un successo strepitoso.
Poi, forse dispiaciuto per non essere riuscito nella sua missione di umiltà, ma forse anche convinto (a forza di successi) di avere raggiunto il livello superiore, se ne torna a casa per continuare a macinare musical milionari.
E ancora una volta supera sé stesso con “Porgy and Bess”, l’ultimo grande esempio mondiale (e il primo americano) di melodramma.
Nel ‘36 va a Hollywood per tentare di scrivere le colonne dei primi film sonori. Ci riesce benissimo, ovvio, anche se piano piano cominciano ad arrivargli i segnali della presenza di colleghi pericolosamente dotati. Si chiamano Cole Porter e Irving Berlin.
Ma non avrà mai la possibilità di sfidarli perché l’anno dopo appaiono i sintomi del tumore al cervello che lo ucciderà presto: orribili mal di testa e una continua sensazione di sentire odore di gomma bruciata.
Muore a Hollywood a 38 anni, dopo un’inutile operazione; cinque mesi prima del suo amato, irraggiungibile maestro, Ravel, anche lui portato via da un cancro al cervello dopo un inutile intervento.
Nel 2005 il “Guardian” fa una stima di tutto ciò che Gershwin ha guadagnato (e continua a guadagnare) e certifica quello che già sappiamo: è il compositore più ricco di tutta la storia della musica.
N° 607 - Microbiografie Irrispettose - Richard Wagner 1813 - 1883 - Secondo Appuntamento

A questo punto a Wagner riesce il colpo da maestro: cattura Ludwig II, Re di Baviera, bellissimo ragazzo, ma un mezzo mentecatto per via delle continue unioni fra cugini, abituali nelle case regnanti da cui discende. In più omosessuale accertato ma non dichiarato né in famiglia né a corte. All’epoca una confessione del genere non è neanche pensabile.
Il 3 maggio a Stoccarda, mentre Wagner, senza un tallero e inseguito dai creditori, sta cercando di convincere il direttore d’orchestra Eckert a rappresentargli il Tristano, il segretario del re si presenta chiedendo di lui che, convinto di essere ricercato dalla polizia, si fa negare. Il giorno dopo lo stesso personaggio si fa vivo all’albergo e gli consegna un anello e una foto del giovane re che lo invita a Monaco alla sua corte.
E a testimoniare l’inizio di un folle amore fra un personaggio con la testa non proprio a posto (convinto di essere il Re Sole della Baviera), e un individuo che invece la testa l’ha ben avvitata sul collo e puntata nella direzione giusta, ci sono due fondamentali lettere.
4 maggio 1864
Wagner al re (dopo l’invito a corte):
“Amato Re pieno di grazia, io vi mando queste lacrime della più celeste emozione per dirvi che i miracoli della poesia sono entrati, come una realtà divina, nella mia povera vita avida di amore. Le ultime armonie poetiche e musicali di questa mia vita e la mia vita stessa ormai vi appartengono, disponetene come di un vostro bene personale.
Fedele ed ebbro di gioia suprema, vostro molto umile suddito Richard Wagner
Il giorno dopo
Ludwig II a Wagner:
Signore, siate certo che farò tutto ciò che è in mio potere per compensare le vostre passate sofferenze…Vi garantirò la pace a cui aspirate al fine che voi possiate dispiegare le ali possenti del vostro genio nell’aere puro della vostra arte inebriante…Osavo appena nutrire la speranza di essere così presto nella condizione di provarvi il mio amore…Vostro amico Ludwig Re di Baviera
E’ curioso il fatto che il re, perennemente infatuato di bei tipi: lo stalliere capo Hornig, l’attore Kainz, il funzionario Weber, poi finisca a sospirare per Wagner: brutto, piccolo, con un gran testone e un’orrenda barba che gli scende per il collo. E’ un amore intellettuale per un artista che in Ludwig aveva svegliato travolgenti emozioni fin dal primo ascolto della sua musica.
E Ludwig mantiene la parola, concedendogli subito una ricca pensione, un alloggio degno e la possibilità di rappresentare le sue opere a Monaco che diventa ben presto la capitale musicale d’Europa.
Il re vive di notte e dorme di giorno in un mondo parallelo che si è creato, dove sentirsi un vero re da favola. Si sposta su carrozze e slitte di forme fantastiche che si è fatto costruire dagli scenografi di corte. Dopo la prima del Tristano, diretto da von Bulow, Ludwig sale sul treno personale per tornare a casa, poi lo fa fermare in aperta campagna e, travolto da una irresistibile passione, salta a cavallo e galoppa nei boschi fino all’alba.
Più tardi, malgrado le pretese del suo amato compositore che aumentano e le casse statali che si svuotano per la sua fissazione di costruire castelli su tutti i cocuzzoli del regno in una folle Disneyland prima del tempo, si assume anche l’onere del teatro di Bayreuth.
In avvenire tutto questo si rivelerà un ottimo investimento: già da tempo, con il turismo musicale e non, il festival e i castelli si sono ripagati abbondantemente delle spese di costruzione e gestione. Involontaria lungimiranza e occhio per il futuro; dove si vede che avere un matto in famiglia non è necessariamente una disgrazia.
Intanto però il sogno romantico e le spese esagerate di Sua Maestà hanno superato il limite di sicurezza. Nel 1885 le banche straniere minacciano di pignorare tutto, Ludwig rifiuta qualunque soluzione ragionevole e allora viene dichiarato pazzo, deposto e imprigionato al castello di Berg, dove, pochi giorni dopo (ormai il suo amatissimo Wagner se n’è andato da qualche anno) lo trovano annegato in modo mai chiarito nel laghetto sottostante, lui che era notoriamente un ottimo nuotatore
Naturalmente anche a Monaco, in città e a corte, Wagner riesce a crearsi intorno un vibrante clima di antipatia, tanto che deve alzare i tacchi e trasferirsi a Lucerna (pur rimanendo sempre a carico di Re Ludwig). Qui conosce Nietzsche, con il quale scoppia una furiosa amicizia intellettuale, anche questa finita malamente tempo dopo con una rottura irrecuperabile dovuta a un indegno pettegolezzo epistolare.
In una serie di lettere che si scambia con il medico curante del filosofo, Wagner insinua che il crescente squilibrio mentale di quest’ultimo sia da attribuire al suo onanismo. Nietzsche lo viene a sapere, si arrabbia molto e tronca l’amicizia.
In quel periodo esplode anche il suo amore, arricchito da ben tre figli, con Cosima Liszt, la quale, guarda caso, non solo è la figlia di Franz Liszt, ma anche la moglie del suo devoto sostenitore e direttore d’orchestra preferito Hans von Bulow, al quale elegantemente la sfila dal letto.
Insomma, in un colpo solo riesce a perdere la stima e l’amicizia dei suoi due più fedeli seguaci e sostenitori: papà Franz e marito Hans.
Nell’82 (Richard e Cosima ormai sono sposati) la famiglia si trasferisce a Venezia, forse non più inseguita dalle cambiali, dato il crescente successo, a Palazzo Vendramin sul Canal Grande, dove Wagner muore l’anno dopo.
Rimane sul campo la sua vedova che, instancabile, si occuperà per molti anni del festival e della promozione dell’opera del marito diventato ormai un indiscusso grande della musica.
N° 606 - Microbiografie Irrispettose - Richard Wagner - Primo Appuntamento

Una lista dei creditori lunga tutta una vita.
Ecco il leitmotiv che emerge dalla biografia di Richard Wagner, un uomo caparbiamente coerente nel farsi cacciare da qualsiasi posizione regolare e nel contrarre debiti sempre più cospicui senza mai saldarne uno.
Nasce a Lipsia. Autodidatta e all’inizio indeciso se diventare musicista, scrittore, pittore o architetto, studiacchia qua e là; alla fine sceglie la musica, sposa la cantante Minna Planer e nel 1837 lo nominano direttore d’orchestra a Koenigsberg, ma è subito licenziato. Prosegue, sempre come direttore, a Riga ma anche da qui lo cacciano e a questo punto registriamo la sua prima fuga dai creditori. Per evitarli passa illegalmente il confine prussiano e si imbarca per Londra su uno scalcinato battello. Si dice che, fra le onde di una tempesta in questo scomodo viaggio, gli sia arrivata l’ispirazione per “L’Olandese Volante”.
Leggende a parte, finisce a Parigi dove passa tre anni di miseria nera, fra pignoramenti e trascrizioni (da lui aborrite) di pezzi classici per banda. Finalmente il piccolo successo del “Rienzi” gli procura il posto di direttore d’orchestra all’Opera di Dresda a 1.500 talleri l’anno, con gran gioia di Minna che non ne poteva più della povertà.
Anche scrittore è, oltre che musicista, e in questo periodo produce vari saggi: “Opera d’arte dell’avvenire”, “L’arte e la rivoluzione” e altri. Sarà in seguito anche autore di “Il giudaismo nella musica”, una pubblicazione nata per dare addosso agli odiati colleghi Meyerbeer e Mendelssohn, poi diventata un imbarazzante libello antisemita: “La razza giudaica è nemica dell’umanità e di tutto ciò che vi è di nobile in essa”. Però se gli serve un bravo direttore d’orchestra o un cantante, va benissimo anche se è ebreo, perché l’opportunismo rimane sempre il perno della sua vita.
Da rivoluzionario, nel ’48 si trova sulle barricate al fianco di Bakunin. Per questo lo cacciano anche dall’Opera di Dresda. Inseguito da un mandato di cattura, Wagner scappa a Weimar sotto la protezione di Liszt, che ha conosciuto nel frattempo insieme al grande direttore Hans von Bulow, due sue future vittime. Liszt lo sostiene ma gli manda una lettera “Basta con la politica e con le chiacchiere socialiste. Occorre rimettersi al lavoro con ardore, il che non sarà difficile con il vulcano che Ella ha nel cervello” dopodiché gli presta 300 franchi e così firma la propria condanna.
Comincia una serie di avventurette sentimentali con risvolto economico. La signora Ritter gli fa avere 500 talleri e una pensioncina. Madame Laussot lo invita a casa sua a Bruxelles. Da qui, dopo le proteste di Minna e del marito di Madame, che non ha gradito l’intrusione, viene allontanato dalla polizia. Lo salva ancora Liszt, che ha diretto con successo il suo Lohengrin a Weimar e gli consente di stabilirsi a Zurigo dove finalmente, con Minna inizia un periodo di relativa stabilità.
Ma figuriamoci se dura.
A Zurigo ha conosciuto Otto Wesendonk, un ricco industriale con una bella moglie, poetessa dilettante. L’ignaro gentiluomo affitta a Wagner un’ala della sua villa, dove il maestro si installa con moglie, cani e pappagalli. E’ un amante degli animali; però una volta il suo cane Leo, mentre lo sta lavando e pettinando, gli morde la mano destra e questo gli impedisce di scrivere musica per due mesi. Un altro cane, il terranova Robber, nel periodo di miseria di Parigi gli scappa di casa e quando i due si incontrano per strada si affretta a scomparire nella nebbia – il cane, non il musicista.
Senza pensarci due volte seduce la signora Wesendonk, Minna se ne accorge, avverte Otto, e dopo l’inevitabile scandalo i Wagner sono cacciati anche dalla bella villa di Zurigo e Richard, tutto solo, finisce a Venezia dove alloggia per qualche mese al Danieli (e chi gli avrà pagato il conto?)
Vagabonda un po’ in giro: Milano, Lucerna e da qui, con un’ammirevole improntitudine scrive al cornificato Wesendonk e lo convince a comprargli i diritti dell’”Anello del Nibelungo” per 24.000 franchi. Con i quali si trasferisce a Parigi dove intende mettere in scena il Tannhauser, che gli sembra “il più appropriato a sostenere quest’atto di prostituzione che identifica il successo artistico con quello finanziario”. Naturalmente, appena arrivato, i quattrini di Wesendonk sfumano nel pagamento di tre anni di affitto anticipato per un appartamento di lusso all’Arco di Trionfo.
Dopo 164 prove il Tannhauser va in scena con un esito disastroso fra urla, fischi e risate. Durante la rappresentazione Wagner, seduto in platea, si alza più volte per battere un tempo diverso da quello del direttore ufficiale, col quale non è d’accordo, e per litigare a gran voce con gli orchestrali. Ritira l’opera dopo la terza replica, ma intanto lo scandalo lo ha reso famoso.
Ormai cinquantenne, si trova di nuovo senza fissa dimora, come dice il suo biografo Aldo Oberdorfer: “nel vortice di una pezzenteria grandiosa, di un accattonaggio magnifico che abita nei palazzi e negli alberghi di lusso”.
Ricomincia a batter cassa. All’amico Hornstein: “Sento che lei è diventato ricco…per tirarmi fuori dai guai mi occorre un anticipo di diecimila franchi. Il suo aiuto la renderà a me molto caro. In questo caso dovrebbe gradire di accogliermi l’estate prossima per circa tre mesi in uno dei suoi poderi, possibilmente in riva al Reno”. La signora Kalergis gli ha prestato 10.000 franchi, che non vedrà mai più. Suoi creditori sono anche Frau Ritter, Malwida von Meysenbug, Herr Peter Cornelius, il Maestro Liszt, parenti, editori, amici, eccetera eccetera.
All’inizio del ’63, con una tournee in Russia riesce a mettere in tasca 7.000 talleri che si volatilizzano subito, accompagnati da un nugolo di cambiali firmate irresponsabilmente, nell’arredo sontuoso del suo nuovo appartamento a Vienna, nel quale dà una principesca festa di Natale a cui invita tutti i creditori suoi amici, riempiendoli di regali invece di saldare i debiti.
Però ormai questi amici cominciano a perdere la pazienza e lo sfuggono. Anche lui deve fuggire in Svizzera per salvarsi dall’arresto per debiti. Con la consueta improntitudine scrive di nuovo a Wesendonk chiedendo ospitalità a Zurigo, ma si prende un bel no. Chiede a un altro amico dei tempi migliori; un altro no.
A questo punto a Wagner riesce il colpo da maestro.
(Che scopriremo al prossimo appuntamento).
N° 605 - Microbiografie Irrispettose - Giacomo Puccini 1858 - 1924

Quello che da grande diventerà un seduttore seriale, un guidatore sconsiderato, un immobiliari-sta compulsivo, un cacciatore convinto, un bravo musicista e, purtroppo per lui, un fumatore accani-to, nasce, sesto di nove fratelli, il 22 dicembre 1858, a Lucca e lo battezzano con i nomi del trisnonno, del bisnonno, del nonno e del padre, da quattro generazioni maestri di cappella del Duomo: Giacomo, Antonio, Domenico, Michele Puccini.
Il padre gli muore a cinque anni; la famiglia diventa povera e il ragazzo viene mandato a studia-re dallo zio che lo giudica poco dotato e molto indisciplinato. Prosegue al seminario della Cattedrale dove consegue questo brillante giudizio: “Entra in classe solo per consumare i pantaloni sulla sedia, non presta la minima attenzione a nessun argomento e continua a tamburellare sul banco come fosse un pianoforte”.
Intanto però il suo talento comincia a fare capolino, così che a quattordici anni già contribuisce alle spese di casa suonando l’organo in chiesa e facendo il pianista di piano bar al Caffè Caselli.
La sua fama di ragazzaccio complica i tentativi della madre per fargli ottenere dal conservatorio di Milano, considerato fra i migliori dell’epoca, una borsa di studio, che comunque alla fine gli viene concessa (parziale) dalla regina Margherita.
Ci entra, diventa allievo di Amilcare Ponchielli e, cosa ancora più importante, amico, anzi amicissimo di Pietro Mascagni, con cui divide la posizione di sostenitore di Wagner nel periodo in cui era in corso la guerra fra wagneriani e verdiani.
Grazie a un buon rapporto con l’editore Ricordi, una buona collaborazione con i librettisti Illica e Giacosa, e soprattutto alla sua miracolosa vena, gli parte una carriera brillantissima di operista. Quattro titoli: La Boheme, Tosca, Madama Butterfly (solenne fiasco alla prima alla Scala, riscattato dal successo immediatamente consecutivo – sembra una strada obbligata per molti capolavori) e Turandot (quest’ultima troncata da un cancro alla gola che uccide l’autore, fumatore accanito, prima di finirla). Non serve altro per l’immortalità.
Noi possiamo aggiungere, tanto per sorridere, che, come altri artisti famosi, anche lui cercò di collaborare con D’Annunzio e di farne il suo librettista. Niente da fare: come in tutti i tentativi precedenti, anche qui l’incontro fra prime donne non funzionò.
Malgrado l’universale successo della musica di Puccini (da un certo momento in poi, ogni stagione di ogni teatro di ogni città importante del mondo ha almeno una sua opera in cartellone), c’è naturalmente uno sciocco, studioso di musica antica, tale Fausto Torrefranca, che pensa bene di pubblicare un polemico libello in cui definisce la produzione di Puccini “l’estrema, spregevole, cinica e commerciale espressione dello stato di corruzione della cultura musicale italiana”.
Nei suoi quattro capolavori le protagoniste sono donne, donne condannate a perdere la felicità e spesso anche la vita, per un uomo. E quell’uomo, quel seduttore seriale è lui, Giacomo, cresciuto in una famiglia con madre amatissima e cinque sorelle, che comincia presto rubando a un droghiere lucchese la moglie Elvira, con cui poi rimarrà tutta la vita, dannandosi e dannandola.
La donna è senz’altro una vittima di Giacomo che la tradisce in continuazione dove e come può, ma dev’essere stata anche una formidabile rompiscatole, prepotente, gelosissima, possessiva, e per di più del tutto insensibile al genio di suo marito.
“Tu metti dello scherno quando io pronuncio la parola arte. E’ questo che mi ha sempre offeso e che mi offende”, le scrive lui nel 1915. Eppure le rimane attaccato; addirittura, secondo il suo studioso Rugarli, le protagoniste delle sue opere si riassumono e si rispecchiano in lei, Elvira, l’unica fi-gura femminile capace di ispirarlo.
La dannazione è nel fatto che Giacomo non riesce a star tranquillo e non smette di insidiare le domestiche e le commesse, le sartine e le contesse, le soprano e le pianiste, con scandali in serie, tan-to che perfino il suo editore, Giulio Ricordi, si vede costretto a scrivergli una lettera in cui lo invita a concentrarsi sulla musica e a lasciar perdere le gonnelle.
Finché succede il fattaccio: la servetta bambina Dora Manfredi, assunta a 14 anni e diventata presto una bella ragazza, naturalmente riceve anche lei le attenzioni del padrone di casa. Come forse nessuno si sarebbe aspettato, qualche tempo dopo, presa a schiaffi, insultata in pubblico e in tutti i modi perseguitata dalla padrona che le rimprovera di essere la tentatrice di quel diavolaccio di suo marito e la causa delle loro liti, il 23 gennaio 1909 si suicida.
Dramma e problemi giudiziari per la coppia ormai famosa. Alla fine, per 12.000 lire i familiari della ragazza accettano di chiudere la causa, però lo scandalo rimane (ma non impedisce al nostro seduttore di avere, a quanto si dice, una storia anche con una cugina della povera morta).
L’immobiliarista compulsivo aspetta solo che arrivino i primi diritti d’autore per abbandonare gli appartamentini in affitto dive ha abitato fino a quel momento.
Come e dove dev’essere la sua casa ideale lo spiega lui stesso in una enfatica e immaginifica lettera a Ricordi: “Sono stufo di Parigi! Odio i selciati! Odio i palazzi! Anelo il bosco olezzante; anelo il libero ondeggiare del ventre mio in largo calzone; anelo il vento che libero mi giunge dal mare; ne assaporo con le nari dilatate il salso iodico…” e così via dannunzieggiando.
In campagna, quindi, possibilmente vicino al mare. E allora, appena arrivato il primo successo di Manon Lescaut, compra una villa a Chiatri, fra Lucca e la Versilia. Il problema è Elvira che la trova troppo lontana dalla città.
Traslocano presto a Torre del Lago, vicino a Viareggio, dove si fa costruire la magnifica, amatissima, definitiva villa, che lui descrive così: “Paradiso, eden, reggia. Abitanti centoventi, paese tranquillo, con macchia popolata di daini, cinghiali, lepri, fagiani. Tanto gli piace quel posto che si dichiara affetto da torrelaghite acuta. Qui compone tutte le sue opere e qui è sepolto.
Poi si sposta per un periodo a Uzzano e a Pescia dove abita a Villa Orsi Bertolini e dove diventa presidente onorario della Società Venatoria della Valdinievole, ma poi torna a casa.
Nel 1919 molla, provvisoriamente, Torre del Lago, infastidito da un vicino impianto per l’estrazione della torba e va a vivere in una vecchia torre di avvistamento spagnola vicina a Orbetello, la Torre della Tagliata, diventata poi Torre Puccini, ma poi torna a casa
Per qualche anno ha pure una casa di villeggiatura a Boscolungo Abetone, e naturalmente (an-che se odia la città, proprio non ne può fare a meno) un sontuoso appartamento a Milano, ma torna sempre a casa.
Le automobili. Debutta con una De Dion–Buton 5 CV con la quale prende dal Comune di Viareggio una storica multa per eccesso di velocità nel 1902. Nel 1903, crash! la sua Clement–Bayard 11 CV finisce in un fosso. I passeggeri sono salvati dall’intervento di un medico che abita vicino al luogo dell’incidente, ma Puccini si rompe una gamba e si acciacca tutto.
Poi è il turno di una Isotta Fraschini e di diverse Fiat.
Però gli serve un mezzo per le sue battute di caccia su terreni difficili e allora ordina alla neonata Lancia quello che è probabilmente il primo fuoristrada italiano: telaio rinforzato, ruote scolpite, che gli costa la folle cifra di 35.000 lire, ma a lui non importa: ormai i quattrini gli entrano in cassa a fiotti.
L’ultima è una Lambda, con la quale guida da Torre del Lago alla stazione di Pisa per prendere il treno, il suo ultimo treno, per Bruxelles.
E’ il 1924, cancro alla gola. Lo hanno convinto a operarsi. Tre ore in sala operatoria all’Istituto del Radium con l’inserimento di sette aghi di platino irradiato. L’intervento, come si dice in questi casi, riesce perfettamente, ma il paziente, il fumatore accanito, quattro giorni dopo muore.
N° 604 - Microbiografie Irrispettose - Antonio Salieri 1750 - 1825
Un assassino, un avvelenatore, eccolo qui, questo criminale che ha rubato all’umanità il limpido genio di Wolfgang Amadeus Mozart. E perché? Per invidia di un talento a lui negato, per rabbia di non aver goduto degli stessi doni, per mettere fine a un tormento interiore che gli aveva rovinato la vita?
La storia di questa perfidia comincia a circolare nel 1830 (inconsapevoli sia la vittima che il carnefice, morti già da un po’) per colpa di Alecsandr Puskin il quale per primo in un suo breve testo intitolato “Invidia” inventa, questa è la parola, inventa la tragedia del mediocre frustrato, il confronto fra la geniale naturalezza con cui Mozart produce a getto continuo e senza fatica musica squisita e lo studio e l’impegno di una vita che Antonio Salieri deve metterci per scrivere le sue note, che poi neanche gli escono tanto bene.
Mezzo secolo dopo, nel 1898 Rimskij-Korsakov prende di peso il dramma di Puskin, lo musica e con il titolo “Mozart e Salieri”, lo rappresenta al teatro Solodovnikov di Mosca. Si tratta di un’operina in due scene in cui viene servita su un piatto diverso ma con la stessa salsa la leggenda dell’avvelenamento di Mozart da parte dell’invidioso Salieri. Uno dei due personaggi (indovinate quale) passa tutto il tempo a lamentarsi per come è ingiusto che qualcuno (lui) abbia lavorato tutta una vita e adesso arriva un tizio frivolo e superficiale (l’altro) che crea capolavori senza alcuno sforzo. La diceria del veleno cresce e si diffonde.
Quasi un secolo dopo, 1979, la TV sovietica ne ricava uno sceneggiato intitolato “Piccole Tragedie”. Ascolto limitato. Dopo la messa in onda, un critico dichiara: “Forse Salieri non ha ucciso Mozart, di sicuro Puskin ha ucciso Salieri”.
Il vero grande successo arriva nel 1978 con il dramma “Amadeus” del commediografo Peter Shaffer che travolge i teatri di Londra. La novità sta nel fatto che adesso è lo stesso Salieri che racconta. Racconta sé stesso e il suo disappunto di uomo religioso che, dopo aver lavorato sodo a creare la sua musica, pregando sempre Dio di assisterlo, è così offeso e ferito da quel Dio che si è preso gioco di lui dandogli la capacità di riconoscere la propria inferiorità rispetto al rivale, ma non la capacità di superarla, che cerca in tutti i medi di distruggerlo, quel Dio, ostacolando con il veleno il cammino della sua creatura.
E finalmente nel 1984 il cinema! Milos Forman, con lo stesso titolo “Amadeus” conquista otto Oscar e gli schermi di tutto il mondo e la leggenda, la logora leggenda dell’avvelenamento diventa indiscutibile vangelo (anche perché, dal punto di vista narrativo funziona meglio di qualsiasi altro trucco).
Beh, non è vero niente.
Intanto Salieri, considerato all’epoca il più importante musicista della corte di Vienna, ha molto più successo di pubblico, di stima e di cassa che Mozart. E, fortunato, ha anche più del doppio del suo tempo da vivere: 75 anni contro 35.
Alla sua scuola di composizione tira su una impressionante squadra di allievi eccellenti, fra cui Beethoven, Schubert, Liszt e perfino Franz Xavier Mozart, il figlio di Amadeus. Un orgoglio.
E’ il prediletto dell’Imperatore musicofilo Giuseppe II, che lo nomina, a soli 24 anni, Compositore di Corte e direttore dell’Opera Italiana di Vienna. Qui scrive una gran quantità di musica da camera, musica sacra e soprattutto opere. Proprio la sua “L’Europa Riconosciuta” è scelta nel 1778 per l’inaugurazione della Scala di Milano, un onore da non sottovalutare. Ha inoltre l’incarico di selezionare solisti e cantanti per l’orchestra di corte, la responsabilità dell’acquisto di strumenti e la conduzione della biblioteca musicale.
Certo, pettegolezzi sui due giravano anche all’epoca in cui erano vivi e attivi entrambi: nel 1786, per citarne uno, la prima delle “Nozze di Figaro” di Mozart a Vienna fu un mezzo fiasco. Cominciò a circolare la voce che sotto ci fosse il sabotaggio di Salieri. Balle, perché proprio in quei giorni lui era in Francia per una sua messa in scena, quindi impossibile che potesse, anche se avesse voluto, organizzare la faccenda.
In realtà, incoraggiati anche dall’Imperatore, i due erano in ottimi rapporti professionali e personali.
Lo dimostra questo brano di una delle ultime lettere di Mozart, scritta dopo aver invitato Salieri alla prima rappresentazione del proprio “Flauto Magico”:
“Non puoi immaginare quanto sia stato gentile e quanto gli sia piaciuta non solo la mia musica ma anche il libretto e tutto l’insieme. Ha detto che è un’opera degna di essere rappresentata in occasione delle più solenni festività e che certo l’avrebbe rivista altre volte, non avendo mai assistito a uno spettacolo più bello”.
Le possibili interpretazioni della vicenda.
O, pur essendo un ottimo insegnante di musica, e quindi necessariamente anche un ottimo giudice della stessa, Salieri non si è mai reso conto della superiorità del suo presunto rivale Wolfgang Amadeus Mozart (ma non ci si può credere).
Oppure, proprio per il fatto di essere un ottimo insegnante e giudice, ma anche un ottimo uomo, ha capito tutto e ha riconosciuto dentro di sé il primato di WAM, ma senza farsene un cruccio, e ha continuato a vivere al proprio livello, peraltro dignitosissimo, sia come artista che come persona. E senza invidia.
Ma ci interessa saperlo?
N° 603 - Microbiografie Irrispettose - Piotr Ilic Ciaikovskij 1840 - 1893

Nella Russia del suo tempo, l’idea che un ragazzo di buona famiglia studiasse musica per farne una professione era roba da matti. Per cui anche Piotr Ilic, come tanti altri, si prepara a diventare avvocato. Però appena aprono il nuovo Conservatorio di San Pietroburgo, molla i codici e si tuffa fra le note.
E inizia così una vita piena di successo e fama, ma anche di miseria, problemi personali, disagi sociali, sotterfugi sentimentali, conclusa a cinquantatré anni con una morte così melodrammatica (si racconta che per una stupida bravata a una cena di amici bevve un bicchiere di acqua non disinfettata e morì avvelenato dai germi del colera che infuriava in città) da far nascere la storia di un suicidio spettacolarizzato con il trucco del finto colera, in realtà commesso con l’arsenico (i sintomi sono simili).
Da dove spunta questa ipotesi? Ecco:
Il nobilissimo conte Sternbock-Fermor, imparentato con la Casa Imperiale, aveva un nipote molto caro al suo cuore. Si dà il caso che anche Piotr Ilic trovasse questo giovanotto molto caro, anzi carino, ma con un sentimento un po’ diverso da quello dello zio, e aveva cominciato a corteggiarlo (all’epoca, anche se in alcuni ambienti tollerata, l’omosessualità portava dritti dritti in Siberia).
Lo zio, piuttosto seccato della faccenda, aveva scritto una lettera di denuncia al Capo Procuratore del Senato con l’incarico di consegnarla allo Zar Alessandro III. Lo scandalo avrebbe trascinato tutti nel fango, compresi i compagni di studio di Ciaikovskij, i quali si riunirono, presente il compositore, e decisero che, per salvare l’onore della Scuola di Giurisprudenza, bisognava bloccare la lettera; ma la lettera poteva essere bloccata solo con la morte del colpevole. E allora Ciaikovskij, uomo d’onore, firmò insieme agli altri la sua condanna e la eseguì.
Leggenda? Rimane il fatto che, dopo un’infanzia segnata da un attaccamento morboso alla madre, l’omosessualità accompagna il nostro musicista per tutta la sua vita, procurandogli tormenti e complicazioni a non finire, compreso un matrimonio di copertura che lui tenta con una sua allieva la quale, non avendo capito niente della situazione, gli si era offerta con una lettera adorante e delirante, e che, quando arriva il momento di consumare questa mal concertata unione gli provoca (confessione sua) un disgusto invincibile, che poi si trasforma in odio altrettanto invincibile per la povera ragazza incolpevole. E prima di cominciare le nozze finiscono.
A cinque anni, prime lezioni di pianoforte; altrettanto presto manifesta insieme a quella musicale una sensibilità patologica: con scene isteriche a ogni rimprovero dell’istitutrice o disperate quando scopre di avere attaccato la scarlattina a un amichetto.
Alla Scuola di Giurisprudenza, insieme alle prime esperienze sentimentali, del genere citato sopra, inopportuno per l’epoca e il luogo, incontra la musica di Mozart, che gli indica la sua strada.
Forse alla ricerca di normalità o forse ancora inconsapevole del suo orientamento, corteggia la cantante Desiree Artot, la quale, più furba della futura moglie, si guarda bene dal dargli retta e sposa un noto baritono spagnolo.
Poi arriva l’incontro fondamentale, rigorosamente platonico come il precedente, con la ricchissima signora Nadezda von Meck, di una decina di anni più vecchia di lui, che, insieme a sua sorella e a sua madre, diventerà uno dei tre pilastri della sua vita.
La signora, buona dilettante di musica con velleità di mecenate, cerca qualcuno con cui duettare. Trovano il giovane Josif Kotek, violinista nonché ex fidanzato di Ciaikovskij, il quale, appena installato nell’incarico, fa il nome del compositore, che sa essere in difficoltà economica.
E qui sboccia il rapporto più romantico ed enigmatico che si possa raccontare, tipico di un’età in cui le vicende personali dei protagonisti si intrecciavano spesso con la creazione artistica.
Con la ferrea regola di non incontrarsi mai personalmente, fra i due comincia una storia fatta di una valanga di lettere da parte di lui, grafomane, (circa 700) a cui lei risponde con più moderazione, (circa 400), di cospicui versamenti di denaro di lei a lui e di altrettanto frequenti espressioni di gratitudine, abbinate a narcisistiche e un po’ furbette dichiarazioni di lui a lei: “Oh Dio, che grandezza d’animo, che generosità, che delicatezza possiede questa donna! Non ho il minimo dubbio che essa provi una grande gioia nel rendermi quest’inestimabile servizio.” E ancora: “Non mi turba sapere che io approfitto della sua ricchezza. So infatti quali sentimenti la spingano ad aiutarmi…”
Questo gioco, oltre a garantire a Piotr la libertà di abbandonare l’insegnamento per dedicarsi alla composizione e consegnare a lei il potere del benefattore sull’assistito, li stuzzica entrambi con restrizioni particolari: lui può andare ospite nelle ville e negli appartamenti di lei, ma solo quando lei non c’è, e sempre con orari rigorosi per evitare di incontrarsi.
E’ in questo periodo che capita il tragico quanto sciocco episodio coniugale e dopo il suo brutto finale Piotr corre a farsi consolare (sempre a distanza) da Nadezda, che oltre che da banchiere, ora gli fa anche da seconda mamma (quella vera ormai è morta).
Ma non dura perché un brutto giorno la von Meck, sempre per lettera, gli comunica che non è più in grado di sovvenzionarlo. Piotr ci rimane malissimo, anche perché circolano voci sul fatto che l’opposizione viene dalla tribù dei figli della von Meck: tanti, nullafacenti e sempre affamati di quattrini. Prova a ristabilire il contatto: niente! E’ il crollo del più importante dei suoi tre pilastri.
Intanto però, più violenti sono i rovesci della sorte, più grandiosa diventa la sua musica: è il teorema romantico dell’artista che distilla bellezza dalla propria infelicità
Un altro colpo è la morte dell’adorata sorella Alexandra. Adesso è solo. Allora scarica tutto il suo bisogno di amare sul figlio di Alexandra, il nipote Vladimir, che è uno scaltro scroccone e approfitta in ogni modo della debolezza dello zio. La sua musica, intanto, continua a migliorare…
L’ultimo sgambetto alla sua fragile psiche è l’incontro con la vecchia governante Fanny, episodio che, alla sua età di uomo maturo, dovrebbe essere solo un richiamo di tenera malinconia e invece quasi lo fa annegare sotto l’onda dei ricordi.
La sua musica ormai ha raggiunto la vetta, ma tutto quello che conta per lui, è sprofondato.
Ed è a questo punto che arriva il fatale bicchiere d’acqua avvelenata.
N° 602 - Microbiografie Irrispettose Gioacchino Rossini 1792 - 1868

Conosciuto da tutti come ghiottone e cuoco sopraffino, pare che nella seconda parte della sua vita fosse in realtà un depresso cronico, grasso, malfermo di salute, senza neanche un dente e con una pelata totale occultata sotto la sua sterminata collezione di parrucche (come si vede benissimo nell’immagine).
Superstizioso, nasce il 29 febbraio 1792, anno bisestile e muore in un altro anno bisestile, il 1868, a novembre, di venerdì 13.
Dotato di una grande disposizione musicale e di una bella voce di contralto, è un bambino precoce; in seguito riuscirà a essere anche un pensionato precocissimo.
Scrive la prima opera a 14 anni, dopo aver fortunatamente scampato il pericolo, ancora in agguato per i fanciulli musicali della sua epoca, di essere castrato e avviato alla carriera di “evirato cantore”, e l’ultima a 37 (in tutto sono 39), dopodiché campa nel lusso e nella gloria per altri quarant’anni, senza quasi più prendere in mano la penna (una delle pochissime sue composizioni di questo periodo la intitola con un certo qual senso dell’umorismo “Peccati di vecchiaia”.) A chi gli chiedeva il perché di questa rinuncia, lui rispondeva: “Ho scritto musica fin quando le melodie venivano a cercarmi; ma ho smesso quando ho dovuto andarle a cercare io”.
Beethoven. Un’occasione per definire la differenza di carattere fra due grandi fu un incontro: da una parte Rossini, trent’anni, famoso, elegante, ricco, pieno di gioia di vivere; dall’altra Beethoven, precocemente invecchiato, povero, sporco, incattivito dalla sordità. Difficile la comunicazione attraverso i taccuini di conversazione e tremenda l’impressione che l’alloggio, praticamente una catapecchia, fece a Rossini e all’amico che lo accompagnava, il quale a Gioacchino che non riusciva a trattenere le lacrime fece notare che la colpa era dello stesso Beethoven, un “bisbetico vecchio misantropo incapace di avere degli amici”. Quella sera stessa Rossini, a cena dal conte di Metternich tentò di aprire a favore di Beethoven una sottoscrizione che andò a vuoto perché tutti rispondevano la stessa cosa: “Beethoven è impossibile”.
Forse depresso, come dicono le biografie, era di sicuro un gaudente, dote probabilmente ereditata da suo padre Giuseppe, detto Vivazza per il suo carattere festaiolo ed espansivo, “trombetta comunale” nella banda di Pesaro. Esuberante doveva essere stato anche il suo incontro con la futura moglie Anna, dato che dovettero sposarsi in tutta fretta per evitare che il piccolo Gioacchino nascesse addirittura prima della cerimonia.
Il Vivazza, a causa della sua accesa adesione alla rivoluzione francese costretto a scappare continuamente da Ravenna a Bologna a Ferrara inseguito dai mandati di cattura del governo pontificio, rappresentò nel periodo dell’adolescenza di Gioacchino una costante fonte di inquietudine, che segnò per sempre il nostro rendendolo un adulto paurosissimo dei cambiamenti politici e delle novità tecnologiche. Ebbe sempre una fifa folle di viaggiare in treno, convinto che la velocità (i forse 30 km dell’epoca!) potesse distruggere i nervi di un uomo.
Pauroso nella vita pratica è invece avventuroso nella musica: produce capolavori a velocità prodigiosa. Capolavori che spesso non vengono riconosciuti subito come tali: famosissimo fiasco quello del Barbiere di Siviglia al suo debutto al Teatro Argentina di Roma, addirittura con scazzottate in platea, chissà se da attribuire a spettatori realmente insoddisfatti oppure a una claque organizzata dai nemici, come si usava allora (e anche adesso). Già alla terza replica, comunque, l’opera emerge e il fiasco diventa un trionfo.
Movimentata anche la sua vita coniugale. Sposa il soprano Isabella Colbran, con cui vive la prima parte della sua storia, quella della produzione frenetica, dei trionfi e del continuo viaggiare tra le città d’Italia e Parigi. Poi, diminuita la frenesia creativa e aumentato il capitale guadagnato insieme alla pigrizia, conosce a Parigi, ci convive e poi la sposa (solo dopo la morte di Isabella) Olympe Pelissier, una signorina dalla reputazione non proprio immacolata, la quale col tempo si rivelerà ottima moglie ed eccellente padrona di casa.
La sua storia merita due righe: nata a Parigi in una famiglia poverissima, a quindici anni la mamma la vende a un nobile, che a sua volta la rivende a un milionario americano. In seguito (non sappiamo esattamente come) debutta in società. Si fidanza con il pittore Horace Vernet, di cui è anche modella per alcuni quadri celebri, poi passa alla letteratura, con Eugene Sue e Honoré de Balzac (che evidentemente non è alla sua altezza, tanto è vero che dopo che si sono lasciati, la definisce stizzosamente “una cortigiana cattiva”).
Finalmente la ragazza approda alla musica: corteggiata da Bellini e Rossini allo stesso tempo, sceglie quest’ultimo con il quale va a vivere prima da concubina, molto chiacchierata dalle signore snob dell’epoca, poi da moglie ufficiale, diventando, come abbiamo già detto, una perfetta padrona di casa prima a Parigi, poi a Bologna, a Milano, a Firenze e finalmente di nuovo a Parigi.
Qui, fra un salotto letterario e una serata musicale organizzati impeccabilmente, cura, coccola e assiste fino alla morte l’amatissimo Gioacchino (il quale, poveretto, combatte la sua battaglia contro un doloroso tumore al colon; e alla fine, come tutti, la perde).
Rossini lascia in eredità il suo non indifferente patrimonio alla città di Pesaro, che ancora lo onora con un famoso festival, ma ne garantisce l’usufrutto vita natural durante a Olympia, la quale, prima di morire dieci anni dopo di lui, si dichiara grata e “glorificata già abbastanza dal nome che porta”.
Un’altra eredità del Maestro è quella gastronomica, piatti intensi che nella nostra epoca salutista fano un po’ paura. Famosi i tournedos alla Rossini: cuori di filetto di manzo coperti con foie gras e guarniti col tartufo: un trionfo del gusto e un avvio al colesterolo.
Già che siamo sulla gastronomia vale la pena di riportare uno scambio di simpatici giudizi culinari fra Rossini e un altro grande, Wagner, il quale, richiesto di descrivere l’italiano, lo definì “Un grosso epicureo farcito non di musica ma di mortadella”, al che Rossini ribatté: “Wagner è un arrosto senza sugo”. Prosit
N° 600 - Microbiografie Irrispettose - Sergej Rachmaninoff 1873 - 1943

Comincia con una data di nascita ballerina (primo aprile o venti marzo, a seconda se è calcolata sul vecchio calendario ortodosso russo oppure su quello europeo) la vita complicata di questo eccezionale virtuoso del pianoforte e ultimo grande compositore romantico russo: Sergej Vasilyevich Rachmaninoff.
Suo padre ha sposato una ricca ereditiera che gli ha portato in dote cinque grandi tenute agricole. Sergej nasce in quella di Semyonovo, ma quando ha quattro anni e sta cominciando le prime lezioni di musica, papà vende il terreno e la famiglia si sposta nei possedimenti di Oneg. Nel giro di poco tempo quest’uomo, totalmente incompetente e capace solo di far debiti perde tutte e cinque le proprietà e i Rachmaninoff finiscono in un appartamentino a San Pietroburgo.
Per Sergej è un vantaggio perché così può studiare al Conservatorio, ma arrivano subito altri guai: prima muore di difterite la sorellina e poi papà Rachmaninoff pianta la famiglia e se ne va a Mosca, lasciando il piccolo nelle mani della mamma e soprattutto della nonna, molto religiosa, che lo porta alle funzioni ortodosse, da dove torna a casa stregato dai canti e dalle campane (le sentiremo risuonare più e più volte nella sua musica).
Non è finita: nel 1885 muore anche l’altra sorella, pilastro della sua educazione musicale, che gli aveva fatto conoscere Ciaikowski. Sergej trascura lo studio, falsifica le pagelle e alla fine lo bocciano. Un cugino, ottimo pianista allievo di Liszt, suggerisce di mandarlo al Conservatorio di Mosca.
Così si fa e per quattro anni Rachmaninoff studia con profitto, tanto che a un certo punto vince una borsa di studio Rubinstein. Segue la Gran Medaglia D’Oro e un diploma che autorizza Sergej a firmarsi “Libero Artista”.
Arrivano anche i primi soldi. L’editore Gutheil gli offre 500 rubli per pubblicare alcune sue opere (per le lezioni di piano ne prende 15 al mese). Ma poco dopo ecco un altro colpo: il suo amico e protettore Ciaikowski muore di colera. Rachmaninoff è distrutto. Scrive il trio elegiaco N° 2 in memoria del defunto, poi sprofonda in una lunga depressione.
Si ripresenta lo spettro della povertà, e allora è costretto a ricominciare con le lezioni, che odia.
Si avventura in una tournee insieme alla violinista italiana Teresina Tua (sembra una dedica civettuola da mettere sotto una foto, invece è proprio il nome e il cognome di un’acclamatissima solista dell’epoca). Rachmaninoff non regge a una concorrente più famosa di lui, per di più donna, e molla tutto rimettendoci i soldi dell’ingaggio. La spiegazione è in queste righe che scrive all’amico Michail Slonov: “Al primo concerto a Lodz suonai abbastanza bene. Ottenni un buon successo, ma a lei, la contessa Teresina Tua Franchi Verney della Valletta, fu tributato un successo ancora più grande. Lei non suona particolarmente bene ma con i suoi occhi e i suoi sorrisi suona magnificamente, per il pubblico.”
Finalmente gli eseguono la prima sinfonia: un disastro perché il direttore d’orchestra Glazunov quella sera è ubriaco e fa un pasticcio. Segue altra depressione. Nel 1900, quando ormai neanche si siede più al piano, lo sottopongono a un trattamento di ipnoterapia, che gli ridà la carica.
Dal 1904 è direttore d’orchestra del Bolshoi per due stagioni. Dopo aver realizzato alcune notevoli innovazioni, fra cui la posizione in piedi del direttore e l’orchestra in buca, lascia il posto, comincia a viaggiare per l’Europa e finalmente vince il premio Glinka di mille rubli. Una boccata d’aria.
Si imbarca per un giro in USA. A New York suonano il suo Concerto N° 3 con Gustav Mahler sul podio e lui stesso al piano. Grandissimo successo, ma Rachmaninoff, come molti russi, ha questa maledetta nostalgia di casa, e non ce la fa a rimanere in terra straniera.
Torna a Mosca e lo nominano vicepresidente della Società Musicale Imperiale Russa, dalla quale si dimette quando viene a sapere che un collega ne è stato cacciato perché ebreo. Due costanti di quel periodo e da quelle parti: la nostalgia di casa e l’antisemitismo.
Se ne va in vacanza a Roma, dove a un certo punto lo incontriamo in un appartamentino a Piazza di Spagna, quando gli appartamentini a Piazza di Spagna ancora si trovavano. Però poi di nuovo torna a casa e finisce in mezzo a una gran confusione per via della prima guerra mondiale e della rivoluzione di ottobre.
A questo punto accetta al volo l’offerta di una serie di concerti in Scandinavia pur di avere il permesso di lasciare la Russia con la famiglia. Vanno in treno fino al confine con la Finlandia, poi in slitta fino a Stoccolma (è inverno!). Finalmente, in nave da Oslo, emigrano negli Stati Uniti.
A New York Rachmaninoff mantiene le abitudini russe, i gusti russi, la cucina russa. Si circonda di russi, fra i quali per sua fortuna ci sono impresari e organizzatori che in breve gli mettono in piedi una stagione coi fiocchi.
Nel 1920 firma un contratto con la RCA ed è uno dei primi virtuosi a registrare su disco. Ormai è il successo e il benessere. Si può permettere di viaggiare insieme al suo pianoforte su un vagone personale arredato con i suoi mobili e un guardaroba completo.
Ormai gli acciacchi sono così tanti da convincerlo che la stagione ’42-’43 sarà l’ultima, ma non ce la fa neanche a finirla. Il 26 marzo muore.
Si dice che, come Paganini, anche Rachmaninoff avesse la sindrome di Marfan, un disordine ereditario dei tessuti connettivi che permette un’estensione delle dita oltre il normale.
Che ce l’avesse o no, rimane il fatto che con quelle sue manone riusciva a suonare cose impossibili. Che scriveva lui stesso nei suoi concerti, mettendo nei guai i colleghi meno dotati.
N° 599 - Microbiografie Irrispettose - Adolphe Sax 1814 - 1894

Cronicamente incline agli incidenti era il piccolo Adolphe Sax, primo di undici fratelli, nato a Dinant in Belgio da un fabbricante di strumenti musicali e fin da subito vittima di questa impressionante serie di sciagure, peraltro tutte a lieto fine:
1. A tre anni cade a testa in giù dalle scale e rimane in coma per una settimana.
2. Ingoia un grosso ago, che poi espelle senza danni.
3. Beve una miscela di piombo bianco, ossido di rame e arsenico ma sopravvive.
4. Inciampa e cade su una stufa ustionandosi tutto un lato del corpo.
5. Scivola nel fiume gelato e viene ripescato semiannegato da un passante.
6. Nell’officina del padre è coinvolto in un’esplosione. Se la cava.
7. Si prende una tegola in testa che lo mette fuori combattimento per parecchi giorni.
Niente e nessuno però riesce a fermare il giovane Sax, il quale, pieno di indistruttibile energia, collabora con il padre nella fabbricazione di strumenti musicali; anzi, non fa altro che migliorarli, brevettando novità strepitose, presentando, a soli sedici anni, innovativi flauti e clarinetti all’Esposizione Industriale Belga, provando e sperimentando finché, nel 1844 elabora la sua famosa legge che dice: “Il timbro di un suono è determinato dalle proporzioni della colonna d’aria che vibra e non dal materiale del corpo che la contiene”.
Sembra un’inezia ma è fondamentale per rendere precisa un’attività che fino a quel momento era basata solo su tentativi artigianali: la fabbricazione degli strumenti musicali a fiato. Finalmente si possono realizzare strumenti perfetti per intonazione, timbro ed estensione, omogenei nel suono dai gravi agli acuti.
Ne inventa e brevetta una serie infinita: le saxtrombe, la saxtuba, un nuovo tipo di fagotto, un clarinetto contrabbasso, timpani, grancasse; progetta anche una sala da concerto di forma ovale a cui si ispirerà Wagner per il suo teatro di Bayreuth, e perfino un riflettore vocale composto di parabole di grandezza diversa da piazzare dietro il cantante (un amplificatore non elettrico, insomma).
Ma il colpo grosso è il sassofono.
Il debutto è all’Esposizione Industriale di Parigi, quando, dato che non ha ancora il brevetto e non vuole mostrare lo strumento, Sax si nasconde dietro una tenda da dove suona un travolgente assolo e ottiene un altrettanto travolgente successo.
Naturalmente bisogna catturare il mercato, che è quello delle bande militari, e allora Adolphe, dopo aver deciso di adoperare per i suoi strumenti l’ottone, più resistente del legno all’umidità e all’uso all’aperto, osa il tutto per tutto: organizza al Campo di Marte, davanti a ventimila spettatori, una sfida fra due gruppi, uno di 45 esecutori con strumenti tradizionali, l’altro di 38 con i sassofoni di sua invenzione. Trionfo di questi ultimi che gli conquistano l’esclusiva per le bande reggimentali di Francia.
Arriva anche la benedizione del mondo classico nella persona di Berlioz il quale, in un suo articolo fondamentale e con l’inserimento nell’altrettanto fondamentale “Trattato di Strumentazione”, sdogana e copre di lodi il nuovo strumento. Anche Rossini dichiara: “Il sassofono ha la più bella pasta sonora che io conosca”. Più tardi, con Ravel e Mussorgsky il sax entra con tutti i diritti nell’orchestra sinfonica.
Uno strumento nuovo richiede un solista nuovo. Ecco che appare la signora Elizabeth Coolidge-Hall. Ricca americana, amante della cultura francese e di Parigi, dove passa molto tempo, un bel giorno si ammala di tifo. Guarisce ma rimane con una lieve insufficienza respiratoria. Il suo medico le prescrive come cura di imparare a suonare uno strumento a fiato. E’ appena nato il sassofono, lei se ne innamora, ne diventa un’ottima solista e, per eseguirli nel suo circolo musicale di Boston, commissiona a compositori francesi (fra cui ci sono Debussy e d’Indy) una serie di lavori che diventeranno la base per il futuro repertorio del sax di Sax.
Un altro passo è la nomina di Sax a professore nella classe di sassofono appena inaugurata al Conservatorio di Parigi. Anche quello di Bologna adotta l’insegnamento dello strumento, e nel Corpo di Musica di Milano ne sono inseriti tre.
Questo successo commerciale e di stima irrita la concorrenza che si scatena trascinandolo in estenuanti processi, portandolo due volte alla bancarotta, rubando i suoi brevetti, boicottando la sua impresa, minacciando i suoi operai e perfino incendiandogli il laboratorio.
Nel frattempo la situazione è degenerata a causa della guerra franco tedesca che impone una riduzione delle spese per le bande militari (come sempre l’arte è la prima a rimetterci) e la ditta Sax cade in una crisi profonda. In più il Conservatorio sopprime il corso di sassofono, che verrà ricostituito solo nel 1942.
Quando ha ormai ottant’anni e non ha più un centesimo in tasca, tre famosi compositori francesi: Chabrier, Massenet e Saint-Saens chiedono per lui al Ministro della Cultura una pensione.
Ma è troppo tardi e prima che questa arrivi il grande Sax è già morto in miseria.
N° 598 - Microbiografie Irrispettose - Gabriel Fauré 1845 - 1924

A balia per quattro anni a Pamiers dove era nato; un periodo esagerato, ma allora si usava. Questo è il debutto nella vita di Gabriel Fauré, piazzato, diciamo così, a pensione da subito.
Quando lo riportano a casa, accanto alla scuola dove insegna il padre c’è una cappellina. Ne parla nei suoi ricordi: “In quella cappellina c’era un armonium, e appena potevo correvo lì; suonavo malissimo: nessun metodo, nessuno studio, ma ero felice; forse è questo che si chiama vocazione.”
A nove anni entra alla Scuola di Musica Classica e Religiosa a Parigi, un istituto preparatorio per fornire organisti alla chiesa. Quasi un carcere: austero il regolamento, cupe le camerate, scadente il cibo, ma l’educazione musicale, che livello! Fra i professori c’è Camille Saint-Saens, che poi diventerà suo amico per la vita.
Dopo il diploma Faurè è occupato da mattina a sera a guadagnare un magrissimo stipendio come organista in chiesa e insegnante di pianoforte a casa.
Spesso non va d’accordo con i parroci. Dal Salvatore di Rennes, una volta che si presenta per suonare alla messa della domenica in abito da sera, direttamente di ritorno dal suo peccaminoso giro nei locali notturni, lo cacciano.
Niente paura: con l’aiuto di Saint-Saens trova un altro organo in un’altra chiesa.
Questo andirivieni gli lascia pochissimo tempo per comporre. E’ un problema che lo importunerà tutta la vita, anche quando, da grande, è ormai un famoso organista nonché direttore del Conservatorio di Parigi; per trovare un’ora da dedicare alla creazione deve aspettare le vacanze e ritirarsi in qualche albergo in montagna, magari in Svizzera.
Nel 1883 sposa Marie Fremiet, una donna “priva di bellezza, spirito e anche di dote; fredda e limitata” secondo il simpatico commento degli amici, e per di più gelosa della di lui vita mondana, che in effetti è piena di incontri, flirt e amicizie, mentre lei (ma non è costretta da nessuno, tanto meno da Gabriel) rimane a casa.
Pare che, sempre a sentire gli amici, Gabriel piacesse moltissimo alle donne, che “gli cadevano ai piedi a frotte” in tutti i salotti di Parigi. Malgrado questo, il matrimonio con Marie andò avanti liscio, all’insegna dell’affetto e del rispetto.
Per mantenere la famiglia Fauré continua a sopportare questo martirio giornaliero fatto di ore all’organo nella chiesa della Madeleine e di altre ore a insegnare il pianoforte alle signorine di buona famiglia.
Le sue composizioni non gli rendono praticamente niente perché lui le vende al suo editore alla ridicola cifra di 60 franchi l’una rinunciando ai diritti d’autore.
In questo periodo scrive anche opere più impegnative, fra cui il Requiem, del quale il parroco della Madeleine, quando Fauré glielo propone, dichiara: “Non ci interessano queste novità: il repertorio che abbiamo è più che sufficiente”.
Questa mancanza di riconoscimento pubblico gli provoca grandi crisi di depressione. In più gli capitano spiacevolissimi infortuni professionali come quando una ben pagata e importante commissione per un’opera su versi di Paul Verlaine gli sfugge perché il poeta, perso nel suo delirio alcolico, non riesce a completare il testo, a rivederlo, a correggerlo e a consegnarglielo.
Nel 1905 scoppia lo scandalo del Prix de Rome, un prestigiosissimo premio consistente in un soggiorno di due anni a Villa Medici a Roma, che col tempo era degenerato in una specie di organizzazione mafiosa a vantaggio degli allievi di un professore, guarda caso a capo della commissione.
Ravel, allievo di Fauré, che non faceva parte di questa cosca, era stato eliminato tutte le volte che aveva concorso. Finalmente il presidente fellone è costretto a ritirarsi; al suo posto entra Fauré che riesce a moralizzare la faccenda. A costo di irritare la cricca tiene duro e si guadagna la fama di Robespierre della musica. Ravel non parteciperà più al premio; comunque giustizia è fatta.
Purtroppo in questo periodo capita anche a lui la maledizione dei musicisti: la sordità. Non solo ci sente sempre meno, ma in più le note del registro alto gli arrivano terribilmente stonate.
La situazione peggiora e così, nel 1920, all’età di 75 anni, Fauré deve dare le dimissioni dal Conservatorio. Riceve la Legion d’Onore, onorificenza che raramente arrivava all’occhiello di un artista, e due anni dopo chiude la sua carriera con un magnifico tributo pubblico da parte della Francia e del suo presidente.
“Una splendida celebrazione alla Sorbona, alla presenza dei più illustri artisti francesi, che gli diede grande gioia. Uno spettacolo commovente osservare l’artista, presente all’esecuzione delle sue opere di cui non sentiva neanche una nota, sedere pensoso guardando nel vuoto, malgrado tutto felice e appagato”.
N° 597 - Microbiografie Irrispettose - Ferruccio Busoni - 1855 - 1924

I suoi genitori dovevano essere entrambi un po’ megalomani perché il nome completo che decisero di dare al povero bambino fu Dante (Alighieri, ovvio) Michelangelo (Buonarroti, naturalmente) Benvenuto (di sicuro, Cellini) e finalmente un normale Ferruccio.
Il padre, Ferdinando Busoni era un noto clarinettista empolese, la madre una ugualmente nota pianista triestina; suonavano spesso insieme e nei loro viaggi si portavano dietro il pupo.
Fin da piccolo è introdotto dai genitori alla musica e a 12 anni ha già scritto un concerto per pianoforte e archi.
Comincia a girare; si diploma in composizione a Graz, poi si sposta a Lipsia e infine va a insegnare pianoforte a Helsinki, con Sibelius come allievo. Continua il suo lavoro a Mosca, dove, già che c’è vince il premio pianistico Rubinstein, poi riceve un invito dalla casa Steinway e se ne parte per gli USA, dove si ferma per un po’, anche qui a insegnare, a Boston al New England Conservatory, poi passa a Vienna dove incontra Brahms che lo riempie di preziosi consigli e finalmente si ferma a lavorare e ad abitare a Berlino. Un globetrotter.
All’inizio della prima guerra mondiale lo incontriamo a dirigere il Conservatorio di Musica di Bologna, dove però si trova male per la disorganizzazione e l’arretratezza dell’istituzione. Tanto che decide di trasferirsi a Zurigo.
In questo periodo conosce Umberto Boccioni, pittore esponente del movimento futurista, che gli fa questo magnifico grande ritratto.
Alla fine della guerra Busoni rientra a Berlino e da lì comincia una vita infernale di viaggi in tutto il mondo come direttore d’orchestra, come pianista solista, come insegnante in corsi di altissima specializzazione. Ogni tanto cerca di rallentare, ma invano, questa trottola che, a quanto confessa in alcune sue lettere, tiene in movimento quasi solo per ragioni economiche.
Mentre vorrebbe dedicarsi principalmente alla composizione.
A proposito di composizione, prima della guerra, intorno al 1913, era partito il progetto di un’opera ispirata a Leonardo da Vinci in collaborazione con Gabriele D’Annunzio. Dopo un corposo scambio di corrispondenza ci fu un incontro a Parigi, e venne fuori, come ci si doveva aspettare, che fra i due narcisi non c’era e non ci sarebbe mai stata quell’affinità di spirito (e quel pizzico di umiltà) indispensabili per una buona collaborazione. Episodio chiuso e niente di fatto.
Quando Busoni si renderà conto di essere arrivato in vetta alla sua carriera concertistica, applaudito da tutto il mondo musicale per il suo talento ”non potrà che dolersi di questo suo dono, da lui accettato piuttosto come un peso, che lo distoglieva dall’attività del comporre, verso la quale sentiva di essere naturalmente portato”.
A suo nome esiste dal 1949 un prestigiosissimo concorso pianistico, il cui primo premio è a un livello talmente esagerato che è quasi impossibile assegnarlo, e così il podio spesso rimane vuoto e trionfano i secondi e terzi posti.
Leggendarie sono le sue trascrizioni per pianoforte delle composizioni per clavicembalo di Bach, in realtà veri e propri trasferimenti delle vecchie geniali idee del vecchio geniale maestro alle nuove potenzialità del pianoforte, uno strumento molto più ricco ed espressivo di quello limitatissimo che Bach aveva a suo tempo a disposizione.
Busoni fa in tempo ad assistere ai primi passi della tecnologia e incide qualche disco a 78 giri, naturalmente oggi inascoltabile. Rimangono invece diversi rulli di pianola, recentemente ripuliti e trasferiti su CD che risultano interessanti come documenti, ma non sono abbastanza utili per indagare una sua innovazione tecnica: l’uso del terzo pedale di cui fu pioniere, riuscendo a convincere la Steinway a montarlo sui suoi nuovi gran coda.
Dopo tutto quel vagabondare fin da quando era piccolo da un teatro all’altro, da una scuola all’altra, al massimo dei giri senza fermarsi mai, il motore comincia a perdere qualche colpo e Ferruccio Busoni, ritiratosi nella sua casa di Berlino per di riposarsi come aveva in programma, invece muore, potremmo dire di stanchezza, il 27 luglio 1924.
N° 596 - Microbiografie Irrispettose Jacques Offenbach 1819 - 1880

Vienna, 8 dicembre 1881. E’ la prima replica dopo il debutto trionfale al Ringtheater. La sala, scintillante nella sua nuovissima illuminazione a gas, è gremita di un pubblico elegante e curioso. Sta per iniziare lo spettacolo.
Da una lampada difettosa parte una fiammella che si attacca al sipario. E’ un attimo: i velluti prendono fuoco e il teatro diventa una trappola fatale. Muoiono in quattrocento; enorme è l’impressione che va a confermare una voce in giro da anni sul potere occulto di…
Gli estremi della vicenda. Eccoli: in programma quella sera al Ringtheater c’è “I Racconti di Hoffmann” di Jacques Offenbach, morto l’anno prima in fama di iettatore e, come sa bene chi frequenta il mondo dello spettacolo, queste reputazioni partono da esili voci per diventare un tragico coro.
Insomma, la morte di quei poveri spettatori venne attribuita senz’altro al malefico potere del povero Hoffmann, ben vivo (il potere) anche dopo la di lui dipartita.
C’è una nostra vecchia conoscenza, un suo contemporaneo, che teneva per buona questa voce. Si tratta di Gioacchino Rossini, il quale, un po’ per burla, ma più probabilmente credendoci in pieno, da italiano superstizioso, compose e dedicò a Offenbach il “Petit Caprice style Offenbach”, un pezzo per pianoforte in cui la diteggiatura indica chiaramente che molti passaggi devono essere eseguiti con l’indice e il mignolo alternati o insieme: insomma, facendo le corna.
Il nostro protagonista (la cui immagine che vediamo qui in effetti non è molto rassicurante) nasce Jakob Levy Eberst, figlio di un cantore della sinagoga di Colonia che è anche rilegatore, editore, traduttore e insegnante di musica. Per difendersi dal diffuso antisemitismo del periodo, papà cambia il suo cognome in Offenbach (così si chiama il suo paesello di origine) e questo cognome passa anche a Jakob, che nel frattempo è diventato Jacques.
Il giovane Offenbach studia al Conservatorio di Parigi e arriva presto al livello di grande virtuoso di violoncello. Suona con Liszt, Rubinstein, Mendelssohn. Diventa talmente bravo da potersi permettere di ripetere con il suo strumento, notoriamente non agilissimo, gli stregoneschi virtuosismi di Paganini.
Poi passa alla direzione d’orchestra, ma non è contento.
Finalmente capisce cosa vuole, prende in affitto un piccolo teatro che chiama Bouffes Parisiens, dove comincia; poi si sposta in altri teatri più grandi dove continua per trent’anni la sua folgorante carriera di autore di operette. Più di cento: spiritosissime, brillanti, satiriche e pungenti verso la società di Parigi, molte delle quali famosissime all’epoca. E lo sono ancora: “La bella Elena”, “La Vie Parisienne”, “Orfeo all’Inferno” che lo rendono popolare e ricco.
Inutile ricordare che l’orecchiabile, geniale, immortale, Can Can viene proprio da lì.
Parigi è diventata la sua città e la Francia la sua patria di elezione. Eppure, durante la guerra franco tedesca del 1870 si trova accusato proprio dai suoi concittadini di essere una spia di Bismarck, tanto che, a scanso di guai, per il periodo bellico se ne va in Spagna. Ma poi torna, i parigini dimenticano e lui riconquista in un attimo la stessa favolosa popolarità di prima.
Muore, al colmo della fama, la notte del 4 ottobre 1880. L’indomani il suo amico del cuore, l’attore Leonce, passa a casa sua per informarsi sulla sua salute. Gli dicono che il Maestro è morto serenamente senza accorgersene. “Chissà come ci rimarrà – pare che abbia esclamato Leonce – quando se ne accorgerà”. Sciocchezze fine ottocento, ma in carattere con il personaggio ed evidentemente anche con i suoi amici.
Si dice che quel simpaticone di Wagner nutrisse per Offenbach una viva antipatia basata su alcuni per lui insuperabili stereotipi: essere Offenbach tedesco naturalizzato francese, quindi un traditore; essere Offenbach ebreo, quindi un individuo inferiore; essere Offenbach una persona spiritosa, quindi l’opposto di lui stesso; essere Offenbach capace di sfornare melodie irresistibili che tutta l’Europa fischiettava, il contrario dei suoi pesanti polpettoni.
Questo sovraccarico di bile deve averlo spinto a dichiarare, dopo l’incendio del teatro: “Gli sta ben, se lo sono meritato! Così imparano ad andare a vedere un’opera di Offenbach!”
N° 595 - Microbiografie Irrispettose - Alecsandr Borodin 1833 - 1887

Accademia Medica di San Pietroburgo, anno 1856. C’è uno studente che si diploma con il massimo dei voti discutendo una tesi su “L’analogia dell’acido arsenico con il fosfatico nell’azione sull’organismo umano”. Il neodottore in chimica si chiama Alecsandr Borodin.
E’ figlio naturale del principe georgiano Stepanov e della sua giovane, bella e intelligente amante Evdokija. Il principe però è sposato, e allora pensa bene di far adottare il bambino dal suo sottoposto Porfirij Ionivic Borodin.
In questo modo il piccolo Alecsandr risulta servo della gleba come suo padre, perciò proprietà assoluta del principe. Il quale, malgrado tutto doveva essere una brava persona perché poco prima di morire lo riconosce assicurandogli il benessere e il livello sociale (sempre, ma allora e in Russia ancora di più, essere un contadinello figlio di contadini non facilitava certo la vita).
Il ragazzo cresce con la mamma in un villaggio vicino a San Pietroburgo. E’ in gamba: studia e impara a parlare diverse lingue, a suonare vari strumenti, e soprattutto (la vera vocazione) a confezionare fuochi d’artificio.
Come abbiamo visto, si diploma in chimica e inizia il servizio all’Ospedale Militare. Qui, colpo di scena, incontra Mussorgsklj che apprezza e sostiene la sua disposizione per la musica e diventano amici. A Borodin non basta e si dà da fare per conoscere anche Balakirev che lo fa entrare nel suo circolo come artista ufficiale. E’ fatta.
A questo punto della sua vita troviamo il nostro chimico-compositore a San Pietroburgo, felicemente sposato e inserito nella professione (di chimico), che d’inverno si dedica all’insegnamento e alla ricerca; d’estate, con le scuole chiuse, riesce anche a scrivere qualche nota (di musica).
Il suo problema è il tempo: non ne ha mai abbastanza per tutte le cose che deve fare. C’è da terminare quello studio: “L’azione dello zincoetile sul cloroiodoformio” che interferisce con le scadenze di consegna della partitura del “Principe Igor” la monumentale opera che alla fine gli darà il successo nel mondo dell’arte (postumo, perché non riuscì mai a completarla; fatica toccata dopo la sua morte agli amici Glazunov e Rimskij-Korsakov).
Purtroppo gli piombano addosso grossi problemi di salute: colera abbinato a complicazioni cardiache. Tanto è vero che il 27 febbraio 1887, a una festa della sua Accademia, mentre balla mascherato da pastorella, cade a terra e muore di infarto sul pavimento.
Per spiegare il contesto di questo incidente, pare che una delle tante bizzarrie di Borodin fosse proprio quella di mascherarsi, preferibilmente da donna, in qualsiasi occasione.
E ce n’è ancora un’altra, di bizzarria, riferita dal nostro Alfredo Casella che lo conosceva bene: per un lungo periodo della sua vita Borodin fu preda di una crisi religiosa che lo spingeva a vagare da un convento all’altro, in cerca della vera icona miracolosa. “Era diventato spaventosamente bigotto e trascorreva intere giornate in chiesa”.
Dopo il lavoro di revisione e completamento degli allievi - amici, la sua opera “Il Principe Igor” andò in scena ed ebbe un tale successo che in dieci anni i suoi diritti d’autore erano arrivati alla folle cifra di 50.000 rubli, poi girati al Conservatorio di San Pietroburgo per istituire borse di studio a suo nome.
Borodin stesso considerava la musica un riposo dalle occupazioni più serie, che erano naturalmente le sue giornate passate fra alambicchi e provette. Eppure aveva una facilità melodica tale che i suoi temi, anche se non ci aveva lavorato troppo, riuscivano irresistibili.
Tanto è vero che nel 1953, due musicisti americani: Wright e Forrest, rielaborarono quelli del Principe Igor, realizzando il musical “Kismet” che divenne uno dei più grandi successi di Broadway, con il tema principale “Stranger in paradise” trasformato in una hit di Bing Crosby, Tony Bennett, Four Aces, eccetera eccetera.
Quando c’è la chimica (nella musica) …
N° 594 - Microbiografie Irrispettose - Franz (Ferenc) Liszt 1811 -1886

Liszt da bambino era così fragile che un giorno svenne, lo credettero morto e chiamarono il falegname del villaggio per le misure della piccola bara.
Papà era un musicista dilettante che capì subito le doti di Franz e le sostenne, tanto è vero che appena possibile si trasferì con la famiglia a Vienna, lui uomo di mezzi limitati, affrontando un bel rischio finanziario per permettergli di studiare con Salieri (l’eterno Salieri che all’epoca era dappertutto).
Poi, a Parigi.
Fin da subito Liszt non lascia dubbi sulla sua naturale disposizione per il pianoforte e sulla sua fortissima capacità di improvvisazione; la voglia di comporre arriverà più tardi. Alla fine di un trionfale concerto di lui dodicenne, Beethoven corre ad abbracciarlo sotto gli occhi del pubblico che applaude.
Parigi gli dà mille stimoli, fra cui l’incontro con Paganini, che con l’esempio della sua stregonesca abilità sul violino lo spinge a inventarsi una tecnica altrettanto funambolica sul pianoforte. Quando Liszt lo vede suonare rimane annichilito dal suo aspetto diabolico, dalla sua fama e dalla sua bravura sovrannaturale, e pur essendone affascinato finge distacco: “Un io mostruoso come il suo non può essere che un dio solitario e triste” (com’è facile sparare sciocchezze a diciott’anni!).
Dopodiché, siccome in realtà non è scemo, capisce che dietro non c’è niente di satanico ma solo fatica e disciplina, e si mette al lavoro anche lui.
La città gli dà anche la lingua francese, che da allora in poi diventerà la sua per tutta la vita; e ancora più importante, gli mette a disposizione il terreno su cui seminare la sua nuova idea di spettacolo musicale (sostenuta anche dall’amicizia e dall’esempio di Chopin): il recital per pianoforte solo, un tipo di concerto fino a quel momento mai praticato da nessuno e ora pronto per il pubblico francese.
Così diventa il simbolo della musica della sua nazione, l’Ungheria, e le dà un’identità, proprio attraverso questa musica (oltre a regalarle, con i guadagni dei suoi concerti, un nuovissimo Conservatorio). E’ il campione di una tecnica virtuosistica e sanguigna, in grado di elevare a una dimensione eroica uno strumento che in fondo era ancora nuovo: il pianoforte.
Insomma, fa nascere intorno a sé quella che da allora si chiamerà “Lisztomania”.
Poi c’è il turbine mondano, erotico, avventuroso che fa quasi tanto rumore quanto il successo artistico. Si spettegola, fra i tanti, dell’incontro con la Contessa Marie d’Agoult che per lui abbandona il marito e le due figlie e con lui comincia un inarrestabile giro di teatri e città: Venezia, Milano, Firenze, Roma, poi tutta l’Europa in un vortice di passioni, concerti, trionfi, riconoscimenti e figli (tre, fra cui la mitica Cosima Liszt, poi Cosima von Bulow, e per finire (male) Cosima Wagner).
Incontra un personaggio discusso, che presto diventerà pericoloso anche per lui: Richard Wagner. Costui gli si manifesta con una prima lettera, tale da mettere in guardia chiunque: “Eccellente amico, ecc. ecc.…io navigo in cattive acque e mi son detto che voi potreste venirmi in aiuto…ho intrapreso la pubblicazione delle mie tre opere…la somma occorrente si aggira sui cinquemila talleri. Potete procurarmela?” Uno scroccone professionale di altissimo livello, causa della rovina di industriali e re. Listz è un suo ammiratore e ci casca in pieno. E continuerà malgrado le truffe e gli inganni dell’altro, a sostenerlo. Un esempio di superiore onestà artistica (e di ingenuità).
Nel 1844 fine della passione con la Contessa. Passa a una nuova storia con la Principessa Carolyne zu Sayn-Wittgenstein e con lei si installa a Weimar, dove estende la sua attività all’insegnamento con fior di allievi eccellenti, troppo numerosi per elencarli tutti.
Poi ricomincia a girare e non si ferma da nessuna parte. Finché…
Finché a Roma, verso il ‘65 un nuovo richiamo, religioso questa volta, prende forma. Liszt passa un lungo periodo di ritiro nel Monastero della Madonna del Rosario e poi riceve la tonsura e gli ordini minori. Diventa per tutti l’Abate Liszt.
Facile immaginare, data la popolarità del soggetto, le malignità sulla veste del seduttore finalmente sostituita da quella del prete, su un abile trucco per ravvivare l’attenzione del pubblico, eccetera, eccetera. Invece pare proprio che questa vocazione senile sia sincera. Da questo momento tutto il suo interesse di compositore e organizzatore va verso la musica sacra.
Purtroppo Roma non è quell’ambiente internazionale al quale era abituato Liszt il pianista, Liszt il direttore d’orchestra, Liszt il sostenitore della musica nuova.
La sua musica non piace e tutto il resto è muffa camuffata da religione.
In più la sua situazione personale è penosa. La contessa abbandonata sparla di lui, la figlia Cosima, che lui aveva data in sposa all’amico, allievo, quasi figlio prediletto Hans von Bulow, dopo otto anni pianta il marito per mettersi con Wagner, quel grande musicista che lui tuttora stima, ma che è anche un bell’opportunista. I due si sposano e lui lo viene a sapere dai giornali. Un dolore e un’offesa.
Finalmente accetta uno dei ripetuti inviti del granduca Carlo Alessandro per tornare alla sua brillante posizione di responsabile di tutta la musica a Weimar e così, vecchio e con la tonaca ma sempre in grado di affascinare principi e contessine, guida la vita musicale di Weimar per molti anni ancora e muore per una bronchite presa in treno mentre va a Bayreuth, alla rappresentazione di un’opera di Wagner, ormai morto da tre anni, a cui lui aveva fatto tanto bene per esserne poi così indegnamente ricambiato.
Il suo pianoforte preferito, che lo accompagnò in gran parte del suo percorso era un Boisselot, del quale scrisse: “Sebbene i tasti siano quasi consumati dalle battaglie combattute, non accetterò mai di cambiarlo e ho deciso di tenerlo fino alla fine dei miei giorni come collaboratore di lavoro privilegiato”.
N° 593 - Microbiografie Irrispettose - Maurice Ravel 1875 - 1937

“Non c’è forma propriamente detta, non c’è quasi modulazione, niente sviluppi. Come è possibile che questo brano sia così amato, quando non c’è musica?” Così parlava del suo Bolero Maurice Ravel, che non smise mai di meravigliarsi del successo universale di questa sua composizione, per lui poco più di uno scherzo.
Il padre di Maurice era un ingegnere e inventore di successo. Fra i suoi tanti brevetti ci furono uno dei primi motori a scoppio e un “giro della morte”, grande attrazione di tutti i circhi dell’epoca. La madre era una brava donna che lo familiarizzò con la musica spagnola. Insomma la famiglia, anche se non ricca, era più che civile e Maurice, che non era un bambino prodigio ma solo uno eccezionalmente dotato per la musica, ci crebbe dentro confortevolmente insieme al fratello, poi diventato ingegnere anche lui come papà.
Nel 1889 Ravel vinse il primo premio al concorso di pianoforte e fu ammesso al Conservatorio di Parigi dove andò avanti senza speciali distinzioni. Con Fauré professore che lo capiva, Ravel studiò con buoni risultati, ma gli altri colleghi del corpo insegnante dichiararono che “gli si poteva insegnare solo alle sue condizioni” e questo non piaceva all’istituto; infatti nel 1895 fu espulso.
Nel ‘97 fu riammesso ma la sua posizione era diventata scomoda per l’ostilità del direttore a cui non piaceva il suo atteggiamento progressista in musica e in politica, tanto è vero che era diventato “un bersaglio contro il quale tutte le armi erano buone”.
Nei primi anni del secolo Ravel aveva concorso per ben quattro volte al Prix de Rome, un premio di grande livello che regalava agli studenti francesi un soggiorno biennale a Roma e una promessa di fama internazionale. Tutte e quattro le volte fu rifiutato. Finalmente il bubbone esplose: venne fuori che un professore in giuria favoriva solo i propri studenti, fra cui non c’era Ravel. Il furbacchione fu costretto a dimettersi e Ravel, anche se poi non andò a Roma, ebbe la sua giustizia.
Era basso di statura, uno e sessanta, e di corporatura esile con una grande testa. Sempre elegantissimo; quando partì per la sua tournee in USA nel bagaglio aveva sessanta camicie, venti paia di scarpe, sessantacinque cravatte e venticinque pigiami. Le cravatte avevano un’importanza fondamentale nella vita di Ravel. Ogni anno a Natale erano il regalo tradizionale dei suoi amici. Ma la faccenda non era così semplice: bisognava mettersi in tasca ritagli di stoffa dei suoi abiti per essere ultrasicuri che la tal cravatta si adattasse perfettamente alla tal giacca, altrimenti il regalo si trasformava in un insulto.
Così piccolo e magro com’era, allo scoppio della guerra chiese di arruolarsi nell’aviazione visto che qualche chilo in meno, con gli aerei dell’epoca contava, ma fu riformato perché troppo vecchio (quasi quarantenne) e forse anche perché aveva solo 76 cm di torace.
Nel 1913, insieme a Debussy era presente alla tumultuosa prima esecuzione della Sagra della Primavera di Stravinskij, e in seguito, lo stesso Stravinskij dichiarò che fu l’unico fra tutti i presenti che capì immediatamente la sua musica.
Si racconta anche che, qualche anno dopo, Gershwin chiese lezioni di orchestrazione a Ravel, il quale ci pensò su, poi rifiutò dichiarando: “E’ meglio che lei rimanga un buon Gershwin, caro amico, piuttosto di diventare un cattivo Ravel”.
Di lui come maestro dell’orchestrazione si dice che, insieme a Stravinskij sia l’unico musicista al mondo capace di conoscere “il peso di una nota di trombone, le armoniche di un violoncello o il pianissimo nella relazione fra due sezioni dell’orchestra”.
Nel 1928 Ravel partì per una lunga tournee in Usa, portandosi dietro l’elegante abbigliamento citato, con un compenso minimo di 10.000 dollari a concerto (roba da rock star), più una fornitura permanente di sigarette Gauloises Caporal. Fu un successo clamoroso ma Ravel non ne fu particolarmente colpito. Anzi commentò che l’attuale entusiasmo dei critici non aveva più importanza dei loro primi giudizi quando lo avevano definito l’esempio più perfetto di insensibilità e mancanza di emozione.
Più o meno in quell’epoca apparve il Bolero, come abbiamo già detto un fenomeno che non finì mai di stupire l’autore. La sua biografa Jourdan - Mourange ci dà la formula che spiega perché questo brano funziona sempre, con qualunque pubblico: “Tramite la ripetizione ossessiva del tema il contagio estatico si sviluppa subdolamente nella sala e quando gli ottoni proclamano la liberazione della tonalità fino allora tenuta prigioniera, ognuno riacquista il senso di sé stesso che aveva perso”. Ma intanto sono passati diciassette minuti di magia.
Poi ci fu la polemica con Toscanini che, secondo Ravel, alla prima a New York il 4 maggio 1930, aveva diretto il pezzo troppo velocemente, sostenendo che così lo voleva il pubblico. Ravel commentò: “I direttori virtuosi sono incorreggibili: sprofondati nelle loro chimere come se i compositori non esistessero”.
Nel ’32 Ravel prese un colpo in testa in un incidente stradale. Da quel momento cominciò a perdere la memoria, ad avere difficoltà a parlare, a comporre; insomma a smarrire sé stesso.
Un giorno che uno studente gli aveva chiesto un autografo, Ravel dovette pregare un amico presente di aiutarlo: non riusciva neanche più a scrivere il proprio nome! Si parlò di demenza o di alzheimer. Si tentò anche un’inutile operazione, nell’ipotesi di un tumore al cervello.
I funerali furono solenni; partecipò tutta la cultura e la politica di Francia. Senza cerimonie religiose perché Ravel era ateo.
Riposa nel cimitero di Levallois a Parigi, da semplice cittadino che aveva rifiutato tutte le onorificenze, anche la prestigiosa Legione d’Onore che il suo paese gli aveva offerto.
N° 592 - Microbiografie Irrispettose - Sergej Prokofiev 1891 - 1953

Eccentrico, arrogante e insofferente verso la scuola, così è descritto dai compagni e dai professori Sergej Prokofiev.
Ma bravissimo; tanto è vero che passa l’adolescenza a vincere concorsi di pianoforte a destra e a sinistra.
Comincia presto anche lui, sotto la tutela della madre, una discreta pianista dilettante, la quale, convinta del suo talento, a un certo punto lo porta a San Pietroburgo per studiare musica seriamente. Qui, anche se di parecchi anni più giovane degli altri studenti, entra al conservatorio, dove però ba-ruffa spesso con gli insegnanti a causa del suo stile troppo moderno e del carattere aggressivo.
Nel 1907 incontra Stravinskij che riconosce immediatamente in lui un suo simile. Nasce un rap-porto di amicizia, stima e, naturalmente, rivalità che li accompagnerà a lungo.
Nel 1910 muore suo padre e lo lascia senza un rublo. Per fortuna la prima piccola notorietà in arrivo, insieme ai primi diritti d’autore lo aiutano a non morire di fame.
In questo periodo vince il primo premio al Concorso Rubinstein, gara di altissimo livello, e compone il secondo concerto per pianoforte e orchestra, opera difficilissima e virtuosistica, che alla prima esecuzione provoca reazioni furibonde nel pubblico per la sua modernità.
Durante la prima guerra mondiale rientra al conservatorio per perfezionarsi all’organo. Scrive l’opera “Il giocatore”, ma le prove sono sospese e poi l’esecuzione salta definitivamente per lo scoppio della Rivoluzione d’Ottobre.
Subito dopo compone la sua prima sinfonia in stile classico, ispirata a Haydn. Tanto per non smentirsi Prokofiev dichiara che se Haydn fosse stato ancora vivo l’avrebbe scritta nello stesso identico modo.
Nel 1918, a 27 anni, lascia la Russia per Parigi, Londra, Chicago. Serie di successi, ma con alti e bassi. Compone ed esegue altre opere, finché comincia a nascergli dentro quella pericolosa nostalgia della patria che spesso colpisce gli esuli, specialmente quelli russi.
E allora, nel 1932 torna a casa, deciso a partecipare attivamente alla marcia trionfale del suo paese verso il sol dell’avvenire. Ma trova una realtà molto diversa da quella che si aspettava. Tanto per dargli il benvenuto viene accusato di formalismo e del declino della cultura da parte dell’Unione dei Compositori, onnipotente organo del regime.
A questo punto il povero Prokofiev ripiega sulla musica per bambini (è allora che nasce il famosissimo “Pierino e il lupo”) scrivendo, secondo le direttive dell’Apparato, melodie facili e orecchiabili.
Un altro bello schiaffone lo riceve nel ’38 quando la sua “Cantata per il XX anniversario della Rivoluzione d’Ottobre” viene solennemente bocciata dal Comitato per le Arti e non sarà mai eseguita. Anche la sua musica di commento per il film “Alecsandr Nevskij” subisce pesanti revisioni, imposte dallo stesso comitato, perché non sufficientemente patriottica.
Infatti, esaurita la distrazione rappresentata dalla Seconda Guerra Mondiale, il Partito, con la minuzia burocratica dei regimi, è tornato a occuparsi degli artisti; e ricominciano i guai.
La musica di Prokoviev viene di nuovo accusata di formalismo e di eresia.
Nel ’48 la sua ex moglie viene arrestata per spionaggio, poi muore il suo amico di una vita Miaskovskij e per finire il teatro Kirov cancella tutte le sue opere dal programma.
E’ la fine.
Ma di lì a poco accade quello che potrebbe essere un capovolgimento della malasorte: alle 10 di sera del 5 marzo 1953 muore Stalin.
Fine dei guai di Prokofiev? Macché: lo stesso giorno, solo un’ora prima, è morto anche lui. Quest’uscita di scena fuori tempo lo priva del giusto risarcimento dopo i maltrattamenti subiti dal Piccolo Padre; e oltretutto lo deruba di qualsiasi celebrazione perché le autorità impongono alla stampa di concentrare l’attenzione su Stalin, e di comunicare la notizia della morte del musicista solo una settimana dopo.
Al suo funerale ci saranno sì e no una trentina di persone.
N° 591 - Microbiografie Irrispettose Giovanni Paisiello 1740 - 1816
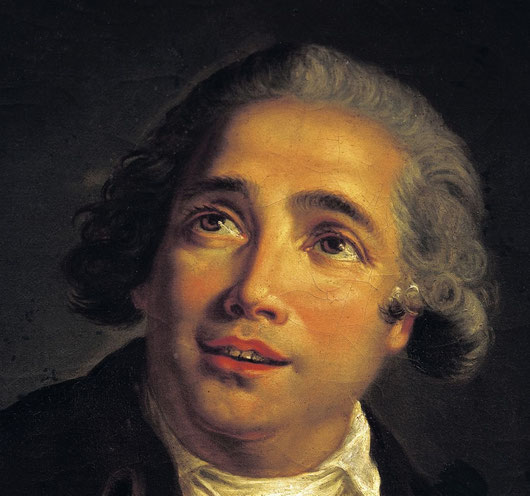
Nasce a Taranto, figlio di Francesco, stimato veterinario al servizio di Carlo III, Re di Napoli. A otto anni entra nel Collegio dei Gesuiti di Taranto con obiettivo (non suo ma dei suoi genitori) la carriera giuridica. Ma presto rivela un orecchio finissimo e una bella vocina, così gli amici di famiglia convincono papà Paisiello a mandarlo a studiare musica a Napoli.
E per fortuna, perché in quell’epoca i bambini con belle vocine e buona disposizione per la musica rischiavano di essere simpaticamente castrati nella speranza di farne musici di successo. Lui la scampa.
A 13 anni Giovanni entra al Conservatorio di S. Onofrio. Diventato mastricello nel 1759, comincia a sfornare il flusso ininterrotto di opere e operine che riempiranno fino all’orlo la sua carriera.
In viaggio fin da subito, nel ’63 a Bologna e poi a Modena si fa apprezzare per il suo spirito e la vena melodica. Passa da Roma, mette in scena al Teatro Valle “La Finta Contessa”, e prosegue per rientrare a Napoli, dove riceve dai Borboni una quantità di commissioni per la Reggia di Caserta e il San Carlo.
Nel ’68 troviamo Paisiello nei pasticci per un episodio grottesco ma anche vagamente rischioso. A fine agosto il nostro maestro indirizza una supplica al Re per dribblare il matrimonio con una Cecilia Pallini, finta vedova e priva di dote, a cui si era promesso. Perde la causa e da una relazione della polizia sappiamo che il 14 settembre è costretto a sposare la furba Pallini nel carcere di S. Giacomo degli Spagnoli dove lo hanno rinchiuso per farlo ragionare.
Sempre a Napoli, altro fatto non chiarito: dopo cinque acclamatissime repliche del “Socrate” al Teatro Nuovo, Re Ferdinando IV ne vieta le rappresentazioni. Censura politica o baruffe interne fra impresari trafficoni?
Nel 1776, conclusi gli impegni in Italia, Paisiello parte per San Pietroburgo come direttore triennale degli spettacoli alla corte della zarina Caterina II, con un salario di 9.000 rubli l’anno. Diventa anche insegnante di musica della Granduchessa Maria Fjodorovna, moglie dell’erede al trono e per un certo periodo si dedica alla composizione di brani strumentali, mettendo da parte l’opera (anche e soprattutto per l’assenza alla corte di San Pietroburgo di un librettista italiano all’altezza della situazione).
Nel 1784 lascia la Russia per tornare a Napoli e durante il viaggio (immaginiamo un San Pietroburgo – Napoli come un’infernale odissea, dati i mezzi e il confort dell’epoca – eppure molti affrontavano questi percorsi eterni come niente fosse) si ferma un attimo a Vienna per mettere in scena, senza troppo successo, la ripresa di una sua vecchia opera. Fra il pubblico c’è Mozart, che già l’anno prima aveva assistito al Barbiere di Siviglia (e infatti lo zampino di Paisiello si farà vivo nelle Nozze di Figaro e nel Don Giovanni).
A fine ottobre ’84 arriva a Napoli, dove si mette subito al lavoro. Osa chiedere e, quello che conta, riesce a ottenere un privilegio che i suoi colleghi neanche se lo sognano: una pensione fissa di 100 ducati al mese, che gli garantisce una bella tranquillità, insieme allo stipendio di 240 ducati annui come maestro della Real Camera. In cambio deve rimanere da quelle parti e produrre per il San Carlo un dramma ogni anno. Ma…
…ma nel 1798 anche quelle parti sono sconvolte dalla storia quando il 1 dicembre la Corte salpa precipitosamente verso la Sicilia per sfuggire all’invasione francese. Paisiello rimane, convinto che la sua fama lo proteggerà; infatti il 4 maggio ’99 è nominato Maestro di Cappella della Repubblica Napoletana. Ma dura poco e al ritorno dei Borbone, finisce in castigo fino al 7 luglio 1801.
Grande cambiamento di vita, di panorama e di abitudini nell’aprile del 1802, quando l’ex Maestro di Cappella di Napoli arriva a Parigi, convocato per i festeggiamenti di Napoleone.
Il quale è un suo sfrenato fan addirittura dal 1797 e lo tratta con imperiale magnificenza dandogli l’incarico di direttore della musica di corte e uno stratosferico stipendio di 10.000 franchi, più 4.800 per le spese. Tanto lo ammira che appena arrivato a Parigi gli chiede di comporre un’opera, una “tragedie lyrique”, compito che Paisiello (malgrado il genere non sia nelle sue corde, ma ricordiamoci che è napoletano) assolve brillantissimamente. A metà 1804 torna a casa.
Nella Napoli di Murat, fino al 1815, Paisiello vive nel lusso, negli onori e nel benessere. Pieno di decorazioni: Legion d’Onore, Accademico d’Italia, Cavaliere dell’Ordine delle Due Sicilie, e con una pensione di mille franchi.
Si trova faccia a faccia con il risentimento del re spodestato (tutto sommato abbastanza blando), quando i Borboni ritornano il 9 giugno 1815.
Ma questo disagio non dura nemmeno un anno. Vedovo, senza decorazioni, ma con una comoda situazione economica, muore il 5 giugno 1816.
Gli fanno un funerale con tutti gli onori e lascia in eredità, oltre a un gran mucchio di composizioni strumentali, ben 94 opere traboccanti di melodie una più fresca dell’altra.
Riesce anche a firmare, prima di andarsene, “Viva Ferdinando Re”, inno nazionale (anche se per poco tempo) del Regno delle Due Sicilie.
N° 590 - Microbiografie Ristrette Fine Estate - Una coppia barocca

CARLO FARINA 1600 – 1639
L’anno di nascita è approssimativo, niente si sa dei suoi studi. Ma è probabile che il suo primo maestro sia stato il padre, suonatore di viola al servizio dei Gonzaga.
A 25 anni Carlo ha già la reputazione di essere un ottimo violinista, tanto è vero che viene assunto come Konzertmeister alla corte di Giorgio I di Sassonia a Dresda. Purtroppo un paio d’anni dopo se ne deve andare perché Giorgio ha finito i soldi per via delle spese della Guerra dei Trent’anni. Si è sparato tutto in fucili e cannoni e non ha neanche mezzo tallero per pagare i suoi musicisti. La storia si ripete: i fondi per l’arte sono sempre quelli che finiscono prima.
Durante il suo periodo alla corte di Sassonia, oltre a suonare deve insegnare il violino ai bambini della cappella. Per questo incarico ha 11 talleri al mese più la legna per il camino e una brocca di vino al giorno.
Nel 1631, lo chiamano a Parma. Qui i deputati della chiesa, “avendo stimato che nel concerto della musica dell’Oratorio della B. V. della Steccata fosse buona la parte del violino” decidono di assumerlo per sei scudi al mese. Più tardi ancora (1635) finisce a Lucca. Qui il nostro Carlo deve essere particolarmente apprezzato perché per la sua prestazione riceve ben otto scudi, compenso molto superiore a quello dei colleghi.
Dopo questa brillante conferma si perdono le sue tracce fino al 1639 quando lo troviamo a Vienna al servizio dell’Imperatrice Eleonora, e si presume che qui sia morto lo stesso anno.
Straordinario virtuoso e audace innovatore al violino, Carlo Farina contribuisce a creare una tecnica e un gusto molto progrediti, che influenzeranno la letteratura solistica per anni e anni. Con lui si utilizzano per la prima volta il pizzicato, il glissato, il legno sulle corde, il tremulo, il ponticello e le scale veloci con i passaggi a corde doppie.

GEORG PHILIPP TELEMANN 1681 - 1767
Autodidatta, a dodici anni già suona una mezza dozzina di strumenti e scrive un’opera che va in scena nei teatri della sua città. La famiglia però non lo incoraggia, anzi, dopo aver dichiarato che fare il musicista è come fare il clown o l’acrobata, insiste perché diventi avvocato.
Come tanti altri ragazzi, prende la laurea per dar soddisfazione a papà, dopo di che molla la legge, punta decisamente verso quello che gli piace davvero e diventa direttore musicale dell’Opera di Lipsia.
Da quel momento inizia una carriera brillantissima sia come impresa artistica che finanziaria: nel 1705 è Maestro di Cappella del Conte di Promnitz, nonché Direttore dei Concerti e Maestro di Cappella a Eisenach. Ancora: riceve una doppia nomina a Kapellmeister nella chiesa dei Frati Minori Recolletti e in quella di S. Caterina a Francoforte.
Ma non finisce qui: il Margravio di Bayreuth gli affida la direzione della sua Cappella e, tanto per gradire, su tutto cumula la direzione della Musica della città di Amburgo, che manterrà per ben quarantasei anni. E, colpo da maestro, conservando intatti gli stipendi relativi a tutte le cariche precedenti.
Un genio della finanza, del sapersi muovere in società e, già che ci siamo, anche della musica.
Molti colleghi gli riconoscono una grandissima abilità tecnica oltre a una grande ispirazione. Haendel ricorda come “Telemann fosse capace di scrivere un mottetto a otto voci più velocemente di una comune lettera”. Anche la sua forza produttiva è formidabile. Da solo ha composto di più dei suoi due famosi contemporanei Bach e Haendel messi insieme: almeno cinquemila brani.
N° 589 - Microbiografie Ristrette Estate - Antonin Dvorak 1841 - 1904

Prima di parlare di sofferenze e drammi della creatività adulta diamo un’occhiata a due passioni di Dvorak, che molto adulte non erano. I piccioni, per i quali andava matto; li allevava, li collezionava, ne seguiva le gare e le prodezze. E i treni. Era per lui una meravigliosa immersione nella favola andare a guardarli ai passaggi a livello, alle stazioni, parlare con macchinisti e fuochisti, farsi spiegare locomotive, scambi e binari. Un bambino. Ah, c’è un’altra notiziola interessante: gli astronomi hanno dato il suo nome a un cratere scoperto su Mercurio.
Antonin nasce a Nelahozeves, uno di quei villaggi centroeuropei dai nomi non proprio facili e prosegue la sua infanzia a Praga, dove suo padre ha una macelleria con locanda e suona la cetra. Papà lo vorrebbe macellaio e locandiere come lui; invece, per fortuna, accortosi del talento del figlio lo fa studiare e diplomare. Come tanti altri musicisti poveri, Dvorak comincia a guadagnarsi la vita suonicchiando qua e là viola e violino e dando lezioni.
A un certo punto si innamora di una sua allieva, che però non lo ricambia. Questo rifiuto lo ispira a comporre un bel ciclo di canzoni per voce e piano. Qualche anno dopo, non sappiamo se per ripicca o per amore, ne sposa la sorella minore. E vissero felici e contenti.
Per l’interessamento di Brahms, di cui è diventato grande amico, ottiene nel 1875 una borsa di studio statale, che gli permette di dedicarsi a tempo pieno alla composizione. Sempre Brahms lo mette in contatto con un importante editore che contribuisce alla diffusione e al successo della sua musica. Poi finalmente la svolta: su invito di una ricca ereditiera americana, Dvorak si trasferisce a New York per dirigere il Conservatorio Nazionale. Accetta la nomina a condizione che gli studenti poveri nativi americani e afroamericani siano ammessi gratis ai corsi.
In USA, dopo che in patria si era interessato ai canti popolari cechi e boemi, è incuriosito e approfondisce lo studio degli spiritual e dei gospel.
Dopo qualche anno oltreoceano, il richiamo della vecchia Europa lo riporta a Praga, dove diventa direttore del Conservatorio e muore contento nel 1904.
N° 588 - Microbiografie Ristrette Estate - Paul Hindemith

Paul Hindemith, personaggio discusso per la sua musica d’avanguardia e anche per il suo rapporto con il regime nazista, dal quale ebbe qualche onore, qualche condanna e un non richiesto spintone a occuparsi della situazione musicale della Turchia.
Impara da solo e molto giovane a suonare il violino. I genitori non sono d’accordo sulla sua scelta di studiare musica, ma Paul se ne infischia; frequenta il Conservatorio di Francoforte e intanto sbarca il lunario suonando in complessi da ballo. Presto diventa direttore d’orchestra del Teatro dell’Opera.
Suona in concerto la viola d’amore, uno strumento medievale e barocco che tutti considerano ormai estinto e del quale lui è virtuoso. Si sbizzarrisce anche in composizioni per strumenti particolari e addirittura scrive per le voci cercando effetti per niente ortodossi (nel suo “Cardillac” il coro imita una folla urlante).
F. T. Marinetti, sobrio come sempre, lo incorona “Esponente del macchinismo futurista”.
In Germania c’è il Nazismo e, anche se Goebbels ammette che “Hindemith è senza dubbio uno dei più importanti talenti della giovane generazione di compositori” la sua musica, considerata degenerata, da un certo momento in poi è vietata.
Lui galleggia nel compromesso: un po’ accetta le imposizioni, un po’ frequenta colleghi di sinistra; a un certo punto firma un giuramento di fedeltà a Hitler, ma rimane marito di un’ebrea.
Nel 1934 scoppia lo scandalo Hindemith, quando il direttore d’orchestra Furtwaengler propone di presentare in prima assoluta la sua opera “Mathis der Mahler”. Goering proibisce l’esecuzione; Furtwaengler minaccia le dimissioni. Niente da fare: il potere fa fuori l’arte.
Anzi, Hindemith è “consigliato” da Goebbels a chiedere un congedo illimitato e accettare l’invito del governo turco per fondare una scuola di musica a Istanbul.
Fine della sua carriera in Germania. Nel 1940, invece che in Turchia, emigra negli USA. Nel ’53 è in Svizzera. Qui riprende l’attività di direttore d’orchestra e finalmente ritorna a Francoforte, dove tutto era cominciato e dove muore nel 1963.
N° 587 - Microbiografie Ristrette Estate - Cesar Franck 1822 - 1890

Il povero Cesar Franck inizia in Belgio la sua carriera musicale come vittima del padre Nicholas. E’ bravissimo al pianoforte e al conservatorio di Liegi vince premi su premi. Papà, che ha da sempre l’intenzione di sfruttare il suo talento di bambino prodigio, quando compie 13 anni gli organizza una serie di concerti che vanno molto bene.
Lo stesso anno, la famiglia trasloca in Francia e Cesar entra al conservatorio di Parigi come allievo di Reicha. Di nuovo acchiappa il primo premio di pianoforte.
Sempre più coinvolto nel piano di impresario-sfruttatore, il padre lo ritira dal conservatorio, cosa che gli impedisce di partecipare al Prix de Rome, chimera di tutti gli studenti di musica dell’epoca.
E’ un periodo non molto felice per Franck: scarse soddisfazioni professionali e peggioramento progressivo del rapporto, già cattivo, con il padre. Il colpo definitivo alla situazione lo dà il suo matrimonio con una attrice per niente gradita in famiglia, che si celebra nella chiesa della Madonna di Loreto, in cui è organista.
Tutta questa pressione fornisce a Cesar l’occasione e forse la forza che non aveva trovato prima, per rompere definitivamente con il padre e liberarsi della sua asfissiante tutela. Ma non gli toglie l’energia per continuare, intensificandola, la sua attività di compositore.
Diventa organista di Santa Clotilde e Valeria, dove inaugura il 1º dicembre 1859 uno dei più begli strumenti di tutta la Francia; e per un solista che non può andare in giro con lo strumento personale sotto il braccio ma deve accontentarsi di quello che trova sul posto, suonare il migliore organo in circolazione dev’essere una bella soddisfazione. Ne rimarrà titolare fino alla morte.
Nel 1871è nominato professore al conservatorio di Parigi dove, insegnante di grande livello, forma un buon numero di allievi che poi diventeranno famosi. Per ottenere questo posto, deve rinunciare alla cittadinanza belga e diventare francese, cosa che, crediamo, non gli dispiace affatto, anzi gli consente di allungare un bello schiaffone simbolico alla memoria del padre oppressore.
Era famoso per le mani straordinariamente grandi che gli permettevano di coprire ben dodici tasti bianchi sulla tastiera, più di un'ottava e mezza. Di lui dicevano che "con la beata tendenza a dimenticare che non tutti i musicisti hanno mani enormi come le sue, riempie la parte del pianoforte di accordi di decima maggiore e gli esecutori normali devono smembrarli per poterli suonare."
N° 586 - Microbiografie Ristrette Estate - Fritz Kreisler

Il violinista Fritz Kreisler nasce ebreo, poi, a 12 anni lo battezzano. Studia al conservatorio di Vienna e a quello di Parigi, dove prende il diploma lo stesso anno del suo battesimo. E insieme vince la medaglia d’oro contro quaranta concorrenti, tutti più vecchi di lui.
L’anno dopo (appena compiuti i 13) debutta a New York, alla Steinway Hall e da lì prosegue per la sua prima tournee professionale. Poi torna in Austria e si presenta per un posto nella Filarmonica di Vienna, ma lo bocciano. Allora molla la musica e si mette a studiare medicina e pittura. Passa un breve periodo nell’esercito e poi, nel 1899, torna al violino per un trionfale concerto con la Filarmonica di Berlino, che gli dà la gloria.
Un tipo che non si risparmiava neanche fuori della musica: sposa Harriet Lies, una divorziata americana, ma poi devono ripetere la cerimonia tre volte in Europa a causa di complicazioni legali sorte dalla precedente situazione coniugale di lei. Non si conoscono i dettagli, sicuramente piccanti; peccato.
Prima Guerra Mondiale. E’ nell’esercito da cui è congedato con onore per una ferita riportata in azione. Suona con successo in Francia e Germania, ma poi, con le persecuzioni razziali, fa fagotto e se ne va definitivamente negli Stati Uniti, si naturalizza e con soddisfazione lì rimane.
Una marcata caratteristica di Kreisler era la voce che riusciva a tirar fuori dal suo violino. Critici e colleghi contemporanei giurano che bastava sentire una sua nota per riconoscere immediatamente la firma del suo, e solo del suo archetto (per non parlare dello strumento).
A proposito di strumenti: Kreisler ebbe fra le mani parecchi violini di altissima liuteria. Uno Stradivari, un Pietro Guarneri, un Giuseppe Guarneri, che lasciò in eredità alla Library of Congress di Washington e un Carlo Bergonzi.
Per chiudere, la sua celebre burla: nel programma dei suoi concerti erano sempre presenti brani di Vivaldi, Tartini e altri autori barocchi, che accendevano invariabilmente l’entusiasmo del pubblico e dei critici. Un bel giorno Kreisler confessò che i brani erano scritti alla maniera di, ma che l’autore vero era lui. Ai critici, seccati di essere stati presi in giro, Kreisler replicò: “Se queste musiche vi piacevano prima, devono piacervi anche adesso: sono cambiati i nomi, non la qualità”.
N° 585 - Microbiografie Ristrette Estate - Bela Bartok-

Pioniere dell'etnomusicologia, compositore e pianista ungherese, Bartok aveva l’orecchio assoluto e molta memoria per la musica. Era anche un esperto botanico e grande conoscitore di farfalle. E in più era straordinariamente dotato per le lingue: ne parlava correntemente otto.
Il padre di Bela Bartok, anche lui di nome Béla come il primo figlio di Bartok, anche lui di nome Bela (insomma, in famiglia c’erano tre Bela di tre generazioni diverse - quello che stiamo raccontando era quello di mezzo: figlio del precedente e padre del successivo) era musicista dilettante; la madre, insegnante di pianoforte. Grazie a loro a otto anni già suonava e componeva.
Bartok stava tentando una carriera solistica (che non riuscì mai a decollare), quando, nel 1907, ottenne il sospirato posto di professore all'Accademia Reale. Questo gli permise di rimanere in Ungheria, di mandare al diavolo i concerti e di dedicarsi a quello che gli piaceva veramente: la raccolta delle musiche contadine ungheresi.
Bartók aveva anche scritto un’opera, “Il castello di Barbablù”, con la quale partecipò a un concorso della Commissione Ungherese per le Belle Arti: respinta perché considerata ineseguibile! Adesso piace a tutti. Negli anni venti dovette affrontare, malgrado non ne avesse nessuna voglia, una serie di tournée concertistiche per l'Europa che gli procurarono “molto onor, poco contante”.
Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, finalmente Bartók decise di andarsene dall'Ungheria e traslocò (malvolentieri) in USA. Anche se fu accolto con molto rispetto come professore alla Columbia University, non si sentì mai a suo agio in America.
Per un po’ tirò avanti con una borsa di studio per la raccolta di canzoni tradizionali iugoslave, e questo gli piacque parecchio; ma poi la sua situazione economica precipitò verso la miseria profonda. Per fortuna un bel giorno il famoso direttore d’orchestra Koussevitsky gli commissionò il “Concerto per Orchestra”, che divenne il suo lavoro più popolare e gli portò perfino qualche dollaro in tasca, ma mai abbastanza da stare tranquillo.
Bela Bartok morì di leucemia a New York il 26 settembre 1945, senza un soldo. Il funerale fu a spese dell'ASCAP, la Società degli Autori Americana. Presenti non più di una decina di persone.
Ma dopo la caduta del comunismo, ebbe il postumo onore di essere riportato a Budapest per i funerali di stato e lì finalmente riposa in pace.
N° 584 - Microbiografie Ristrette Estate - Benjamin Britten 1913 - 1976

Benjamin nasce in una cittadina inglese sul mare. Il padre è un dentista, buon dilettante di musica, e soprattutto bravo a riconoscere e a favorire la forte inclinazione musicale del figlio. La madre, un tipo un po’ particolare, anche lei appassionata di arte e in più dotata di una fissazione quasi patologica, decide che il piccolo dovrà diventare una personalità così straordinaria da trasformare il famoso trio delle grandi B della musica: Bach, Beethoven, Brahms, in un quartetto, con l’aggiunta, in coda, di Britten.
Studia con poco entusiasmo ma molto profitto. Una delle sue tante insegnanti private lo presenta a Frank Bridge, celebre musicista, noto per il suo inflessibile rifiuto a dare lezioni. Per Benjamin fa un’eccezione, anzi scrive addirittura un biglietto a papà Britten: “Ho molto piacere ad aiutare vostro figlio. Ha doti eccezionali e con la vostra comprensione conseguirà grandi cose.”
Britten è un ragazzo molto, troppo sensibile; in più oppresso da un’educazione puritana che gli regala giornate di depressione e notti di incubi. Intorno ai vent’anni, dopo aver studiato a fondo Freud, incontra il poeta W. H. Auden il quale lo aiuta ad accettare la propria omosessualità e a liberarsi dal senso del peccato e del segreto che fino a quel momento lo avevano paralizzato.
Conosce il tenore Peter Pears che diventerà l’interprete prediletto delle sue opere nonché il compagno di tutta la sua vita. Allo scoppio della guerra partono insieme per gli USA e lì passano gli anni del conflitto.
Nel dopoguerra Britten torna in Europa, acquista una residenza a Aldeburgh, vicino a casa dei suoi, e fonda l’English Opera Group con l’obiettivo di rilanciare il teatro e la musica inglese. Una parte del repertorio è destinato ai bambini, numerosi fra il pubblico, e a cui Britten si dedica con incontri e spettacoli. Immediatamente le malelingue partono alla carica e questa bella iniziativa si trova al centro dei sospetti di tutto il vicinato, che associando la presenza dei bambini alla ormai nota omosessualità dei padroni di casa (all’epoca ancora reato in Inghilterra) fanno virtuosamente e stupidamente naufragare tutto.
Intanto la fama del compositore cresce; è ormai mondiale. Le sue opere sono presenti in tutte le occasioni mondane e intellettuali: la Biennale di Venezia, la Royal Opera House, il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ma il suo cuore non va, e allora Britten, in uno sguardo retrospettivo sulla propria esistenza, mette in musica “Morte a Venezia” di Mann. E come il protagonista del romanzo, muore con la mano stretta in quella di Pears, destinatario dell’opera, silenzioso a vegliare l’amato.
N° 583 - Microbiografie Ristrette Estate - Samuel Barber

Nasce in una famiglia americana della migliore borghesia; suo padre è un medico, sua madre una pianista; zie, cugini e altri parenti sono nel mondo musicale, quindi Samuel naviga già nel brodo giusto. A sette anni comincia a comporre e a 14 entra al Curtis Institute of Music di Filadelfia.
Diventa musicista professionista. Nel 1936 compone il quartetto per archi in si minore. Due anni dopo, su consiglio di Toscanini trascrive per orchestra il secondo movimento del quartetto e lo intitola “Adagio for Strings”. Toscanini glielo esegue con la NBC Symphony Orchestra, portandolo a un successo clamoroso e dandogli la gloria. Si racconta che, dopo la prima lettura in prova del brano, Toscanini, il terribile Toscanini, che raramente eseguiva opere di compositori americani e che mai aveva una parola buona per nessuno, abbia dichiarato: “Semplice e bello”.
In seguito Barber vince un premio Pulitzer per “Vanessa”, libretto di Gian Carlo Menotti, suo poeta anche per altre opere e suo compagno (vivono insieme nella grande Villa Capricorn, poco fuori New York).
La sua terza opera “Antonio e Cleopatra”, su testo di Franco Zeffirelli e commissionata per l’apertura della nuova Metropolitan Opera House al Lincoln Center, è invece bocciata solennemente dal pubblico e dalla critica, e questo fa piombare Barber in un abisso di depressione e alcolismo che porterà alla fine del suo rapporto con Menotti, alla vendita della villa e alla rinuncia quasi totale a comporre, fino alla morte nel 1981.
Il suo “Adagio for strings” è un’opera dalla popolarità quasi sorprendente: è bello, è vero, ma nel tempo è diventato addirittura il commento musicale di una quantità di eventi importanti: il funerale del presidente Roosevelt, quello di Eisenhower, l’omaggio alle vittime dell’Undici settembre; e poi la colonna sonora di grandi film: “Platoon”, “Elephant Man” …
Significa evidentemente una cosa: a prescindere dalla sua sapienza compositiva è un tema che arriva al cuore. Come aveva detto Toscanini che se ne intendeva: “Semplice e bello”.
N° 582 - Microbiografie Ristrette Estate - Ernest Chausson 1855 - 1899

Nasce in una ricca famiglia borghese. Il padre è uno dei costruttori che stanno rifacendo Parigi secondo i piani del Barone Haussman.
Due suoi fratelli muoiono mentre è ancora bambino e questo accentua il suo carattere introverso.
Verso i dieci anni si avvicina alla musica ma, per far piacere a papà, accetta di studiare legge e diventa avvocato senza avere mai avuto il minimo interesse per la professione.
Frequenta invece con avidità i salotti letterari dove incontra il meglio dell’epoca. Si iscrive ai corsi di composizione del Conservatorio di Parigi con Massenet. Non riesce a vincere il prestigioso Prix de Rome. Deluso, lascia il Conservatorio ma continua a studiare privatamente con Franck.
Viaggia molto. Assiste alle prime rappresentazioni delle opere di Wagner che lo influenzano profondamente.
Finalmente, avendo risolto grazie a un provvidenziale testamento ogni problema finanziario, si sposa e può dedicarsi con tranquillità alla composizione. Apre con la moglie un salotto dove approdano continuamente nuovi artisti, fra cui Debussy, con cui nasce una grande amicizia.
A quarantaquattro anni il dramma! Durante una vacanza a Limay, in una gita di gruppo in bicicletta, infila una ripida discesa, sbanda e muore rompendosi la testa contro un muro di mattoni.
La stupidità dell’incidente alimenta un gran vociare di amici e conoscenti e comincia a girare l’ipotesi di un suicidio drammatico, fantasioso e anche un po’ ridicolo. Nessuna traccia di frenata e la consapevolezza che Chausson stava attraversando un periodo di depressione a causa della salute vacillante e della sua ipocondria, fanno pensare al peggio. Naturalmente, nessuna conferma.
Ingiustamente nell’ombra, Chausson è un compositore interessante ma sfortunato nel trovarsi a vivere in un’epoca ricca di personalità più grandi di lui. E’ stato comunque un vivace promotore culturale come segretario della Societè Nationale de Musique, organizzatore di incontri intellettuali di artisti, musicisti e pittori e collezionista in contatto con il mondo degli impressionisti.
N° 581 - Microbiografie Irrispettose N° 11 - Johann Sebastian Bach

Scrivere di Bach raccontando tutto in stile tradizionale riempirebbe un’enciclopedia in parecchi volumi. Troppi. L’alternativa? Lo stile telegrafico. Ecco:
La prima cosa da dire di Bach è che fu molto prolifico: un migliaio di titoli e venti figli.
Non ha mai scritto un’opera, perché l’opera non gli piaceva.
Cade nell’oblio, ma ne è dissepolto nel 1829 da Mendelssohn con la “Passione secondo Matteo”.
Dal 1723 alla morte, è alla chiesa di S. Tommaso a Lipsia. Tutto casa e famiglia: un borghese serio e pacato, ma prima della nomina ne aveva fatte parecchie con il suo caratteraccio sanguigno e anche violento.
Al servizio di Guglielmo di Sassonia, non avendo ricevuto la promozione che si aspettava, cominciò a importunare il suo padrone con tante di quelle richieste di congedo, che alla fine il duca si seccò e, detto fatto: “Per ordine di Sua Altezza Serenissima è stata decisa la messa agli arresti di Johann Sebastian Bach, Konzert-Meister e organista, in ragione della sua insistenza a chiedere un congedo ingiustificato”. Un mesetto più tardi è liberato, con il congedo richiesto.
E’ predestinato dalla sua famiglia all’artigianato musicale (certo, di livello superiore) e lui fa lo stesso con i figli (dei 20 che sforna, ben 4 sono musicisti, e diventano famosi).
Il capostipite è un fornaio e suonatore di cetra, Veit Bach, seconda metà del ‘500.
In Turingia la famiglia è così famosa che il nome Bach diventa sinonimo di musicista.
Siccome le musiche di chiesa non venivano comunque pubblicata, lui riutilizza liberamente i propri temi sia per soddisfare la continua richiesta di nuove composizioni, sia per non sprecare buone idee per una esecuzione sola.
Guadagna abbastanza, è testardo e parsimonioso e ci tiene ai suoi conti. E’ insofferente della vita di corte, eppure l’accetta perché non sa (ma solo perché è un’idea che non si è ancora affacciata alla consapevolezza del tempo) che potrebbe avere una posizione diversa da quella di servitore della nobiltà. E’ caparbio, collerico, eccessivo, in contrasto con l’immagine tradizionale del pacifico organista di chiesa.
Il municipio non è contento di lui. A Lipsia è un continuo litigio con i rettori, i prefetti, le autorità. Loro non cercavano un genio, gli bastava un musicista di chiesa, un impiegato, un insegnante; e Bach non lo è. Come professore non ha pazienza che per gli allievi migliori.
Nel 1703 fallisce un’audizione. Anzi l’avrebbe vinta se il principe Giovanni Giorgio di Sassonia non avesse deciso di far passare un suo raccomandato. Bach, arrabbiato, molla tutto e si trasferisce alla corte di Giovanni Ernesto di Weimar.
In autunno si fa dare un permesso e affronta a piedi il viaggio fino a Lubecca per ascoltare dal vivo Buxtehude, allora fra i massimi organisti del mondo.
Non si sa se si siano incontrati personalmente; quello che il figlio Carl Philipp raccontava, per averlo sentito personalmente dal padre, era che Johann Sebastian aveva preferito rimanere nascosto dietro a una colonna ad ascoltarlo per scoprire tutti i trucchi del grandissimo solista. E infatti al suo ritorno “eseguiva stupefacenti variazioni sui corali e vi mescolava armonie estranee a tal punto da confondere i fedeli”.
Bach è un notissimo collaudatore di organi. L’organo era una macchina costosissima e di enorme prestigio per la comunità. Il collaudatore doveva essere un grande virtuoso, un buon meccanico e un uomo onesto.
Bach non soffre di essere più noto come collaudatore ed esecutore che come autore. Ancora non c’era l’idea romantica dell’artista autonomo; poi Mozart e Beethoven hanno rovinato tutto.
Bach non innova, farcisce le formule della scuola antica con ripieno fresco.
Si fidanza con la cugina Barbara, che poi sposerà, ma intanto, in cattedrale, se la porta in cantoria, fra le volte, alla tastiera dell’organo. Malizioso…
La famosa storia del mancato incontro fra Bach e Haendel, anche se potrebbe essere solo una coincidenza, è da sempre fonte di pettegolezzi, supposizioni, sospetti.
Coetanei (1685), tedeschi entrambi, famosi allo stesso livello, si rincorsero, con l’umile Bach che faceva tragitti impossibili a piedi per incontrare il mondano Haendel; quest’ultimo che, sempre per pochi giorni non si faceva trovare, forse con il sospetto che l’altro volesse trascinarlo in una sfida organistica. Bach che copiava a mano le musiche di Georg, Georg, artista libero, che guardava dall’alto in basso Johann, musico impiegatizio; Haendel vitaiolo sempre in viaggio, Bach provinciale sempre alla tastiera. Non si saprà mai la verità, ma non importa.
Anche se forte fumatore di pipa, Bach fu sempre in buona salute. Il suo problema era la vista. Molto miope, cominciò a perderla rapidamente nell’ultimo anno di vita, finché diventò cieco.
Verso marzo passava da Lipsia un oculista inglese che promise un miracoloso intervento. Bach accettò, ma l’operazione andò male. Forse sarà caduto in mano a un ciarlatano; forse invece aveva un glaucoma, contro il quale all’epoca non si poteva fare niente.
Il 18 luglio Bach riacquistò improvvisamente la vista (i medici dicono che talvolta, nei soggetti anziani, c’è un abbassamento spontaneo del cristallino), ma dopo pochi minuti gli venne un ictus.
Morì la sera del 28 luglio 1750 all'età di 65 anni. La sua eredità venne valutata 1.159 talleri e comprendeva cinque clavicembali, due clavicembali-liuto, tre violini, tre viole, due violoncelli, una viola da gamba, un liuto, una spinetta e 52 "libri sacri" (molti dei quali di Martin Lutero).
N° 580 - Microbiografie Irrispettose N° 10 - Johannes Brahms

“La sua vita fu caratterizzata da una serena operosità, cui l’amicizia di molti eletti artisti e l’ammirazione del pubblico colto diedero un confortante appoggio. Il suo sviluppo artistico fu lento e continuo. La sua attività creativa fu contrassegnata da un costante impegno culturale, da una profonda meditazione, da una meticolosa accuratezza.”
Quindi, per Brahms, niente genio e sregolatezza.
Johannes Brahms nasce in una famiglia modesta, figlio di un musicista popolare che suonava un sacco di strumenti: flauto, corno, violino, contrabbasso e fu lui che diede al figlio le prime lezioni di musica. La madre, molto amata da Johannes, era sarta. Erano semplici e poveri ma capirono subito che il figlio meritava la migliore educazione possibile e gliela diedero.
A sette anni comincia a studiare musica: composizione e strumenti vari. A tredici è già in grado di contribuire al bilancio di casa suonando, come suo padre, in giro per le osterie di Amburgo.
A vent’anni conosce il grande violinista Joachim, che lo presenta a Liszt, il quale a sua volta lo porta da Schumann. Questi ne riconosce immediatamente il genio e lo indica nella sua rivista di critica musicale “Neue Zeitschrift fur Musik” come il compositore del futuro.
Brahms a sua volta adotta Schumann come il suo unico vero maestro d’arte e di vita e gli rimane devoto fino alla morte. Un legame ancora più forte, un vero amore spirituale, nasce fra lui e la moglie, poi vedova, di Schumann, la grande pianista Clara Wieck, che idolatra fino alla morte di lei, seguita, appena un anno dopo, dalla propria.
Brahms, spesso in duo con Joachim, dedica quasi tutta la sua vita all’attività concertistica, che coincide con un vagabondare senza tregua da un teatro all’altro: vita scomoda ma che a lui piace, specialmente se i suoi viaggi lo portano in mezzo alle bellezze naturali, fra le quali perfeziona mentre passeggia le sue creazioni musicali.
Dal 1862 comincia a familiarizzarsi con Vienna e poco a poco decide di trasferirsi in quella città della musica, dove si crea un mondo di amici e colleghi con cui rimarrà in contatto per il resto dei suoi giorni.
Uno di questi eletti amici è il chirurgo Billroth, che fa parte di quella classe di alta e coltissima borghesia che rende Vienna un centro di arte e cultura capace di attirare il meglio dal resto d’Europa. Ogni volta che Brahms finisce una composizione la porta in casa Billroth e lì la ascolta eseguita in prima assoluta da un quartetto di musicisti dilettanti (in realtà di livello professionale), tutti amici suoi e del padrone di casa: un capitano, un consigliere, un avvocato, un possidente. Felice quel popolo che può riunire in un salotto persone di questo genere.
Curiosamente, pur essendo un personaggio pacioccone d’aspetto e si dice anche di carattere, era pieno (in campo artistico naturalmente) di nemici.
Vale la pena di citare alcuni simpatici giudizi di costoro. Wagner: “Le sue sinfonie non sono altro che musica da camera monumentalizzata”. De Falla: “Musica piena di vanità e ampollosa come il suo autore”. Wolff: “Tutte le sinfonie di Brahms non valgono un trillo di Liszt”. Ciaikowskij: “Non è forse Brahms una caricatura di Beethoven? Che bastardo senza talento! Mi infastidisce che questa boriosa mediocrità sia acclamata come un genio”. Bruckner: “Un freddo temperamento di protestante”. A quest’ultimo Brahms rispose, rimanendo sul piano della religione: “Bruckner è un poveruomo privo di senno che i preti di Sanct Florian hanno sulla coscienza”.

Brahms era di fede luterana e tale rimase tutta la vita con incrollabile coerenza. Una delle sue abitudini altrettanto incrollabili era la lettura della Bibbia, su una copia che i genitori gli avevano messo nella culla il giorno della sua nascita. La leggeva con fede e assiduità e rimase per tutta la vita il libro più importante per lui.
Parsimonioso, spendeva quello che guadagnava dalla sua musica e non scrisse mai nulla su commissione.
Aiutò molti colleghi meno fortunati di lui, fra cui Dvorak in un periodo in cui quest’ultimo faceva letteralmente la fame.
Era noto per la bonomia accompagnata da goffaggine dei suoi scherzi, in questo simile a Beethoven e Wagner, come lui maldestri in società.
Aveva grande diffidenza e sfiducia nelle donne (tranne il suo angelo Clara Wieck) e spesso lo sentirono dichiarare: “Non sono mai stato sposato e per fortuna non lo sarò mai.”
Sotto quel barbone da profeta doveva essere davvero un tenero timidone.
N° 579 - Microbiografie Irrispettose N° 9 - Fryderyk Chopin

Tanto per gradire, ecco qualche carineria scritta da amici (?), biografi e critici su Chopin: “Un tubercolotico cronico, con la psiche alterata da una vita anormale in cui la creazione trabocca di vitalità”; “Vive costantemente in un clima di irascibilità malata”; “Un infermo, per di più grande artista, non può che essere un egoista forsennato e ipersensibile”; “Chopin non ha mai compreso la natura umana degli altri”; e così via, simpaticamente…
Figlio di Nicolas, di origine francese, nasce in un villaggio polacco dove il padre fa il precettore dei figli di un nobile. Papà suona il flauto e il violino, mamma il pianoforte, e glielo insegna. Chopin a 8 anni compone la sua prima polacca. Lo mettono a lezione da un maestro vero, Zywny, il quale, a un certo punto, è costretto a dichiarare a Nicolas Chopin che non ha più nulla da insegnare a suo figlio.
Il giovane Chopin è di corporatura esile e fin da piccolo la sua salute barcolla. Verso i nove anni comincia a essere tormentato da una tosse continua che lo accompagnerà fino alla morte. Oggi sappiamo che quella tosse era la manifestazione di una tubercolosi polmonare.
Liszt, di cui è grande amico, lo descrive così: la persona armoniosa, lo sguardo spirituale, il sorriso dolce che non si spegne mai. Carnagione fine e trasparente, capelli biondi di seta, portamento distinto e aristocratico, il timbro della voce sempre smorzato (la laringite tubercolosa).
A 15 anni è ingaggiato da un professore dell'Università di Varsavia, inventore di un organo meccanico, l'eolomelodicon, per eseguire su questo strumento una improvvisazione. Grande successo della esibizione; allora lo invitano a ripeterla davanti allo Zar Alessandro I, che lo premia con un anello di diamanti.
Appena finiti gli studi al Conservatorio di Varsavia, debutta a Vienna con un concerto di pianoforte, entusiasticamente recensito da Schumann (che spesso parla male dei colleghi, ma stavolta no) sulla sua rivista di critica musicale. Gli capita anche di ascoltare Niccolò Paganini e in suo onore compone una serie di variazioni: i “Souvenir de Paganini”.
Nel 1823 accade un fatto importante: Sebastien Erard, un geniale cembalaro riciclatosi costruttore di arpe e pianoforti (i suoi diventano praticamente gli Abarth dell’epoca) inventa il doppio scappamento, un meccanismo che aggiunge il turbo allo strumento. Questo è fondamentale per Chopin che concepisce i suoi virtuosismi proprio sul pianoforte e sarebbe forse rimasto nell’ombra senza le prestazioni acrobatiche fornite dalle elaborazioni di Erard.
Piuttosto che nei teatri preferisce suonare nei salotti di Parigi di cui diventa la star. E’ un gran mondano: amico di Rossini, Cherubini, la Malibran, la Pasta, Liszt.
Cos’era un “salotto”? Era uno spazio, anzi un evento in un palazzo privato. Si riceveva una volta la settimana. Cena per un minimo di 24 coperti. Verso le 9 arrivavano gli altri invitati: conversazione brillante, abiti eleganti, gioielli, fiori, liquori e poi la musica: ecco il mare in cui si tuffava Chopin per le sue magie sonore.
Base principale della sua sopravvivenza sono le molte lezioni di musica che dà, tanto è vero che può finalmente permettersi un calesse. Purtroppo, seguendo la sua natura, Chopin se molto denaro guadagna, altrettanto ne spende per vivere una vita lussuosa e senza futuro.
Nel 1835 si fidanza con la contessina Maria Wodzinska; la famiglia di lei, in un primo momento favorevole, poi si oppone. Forse questo rifiuto pregiudica la già cagionevole salute di Chopin che ormai soffre di frequenti attacchi di bronchite, laringite ed emottisi. Un bel giorno raccoglie la corrispondenza con Maria in un pacchetto insieme alla rosa che lei gli aveva regalato, lega tutto con un nastro e vi scrive sopra, romantico e disperato (e anche un po’ esibizionista): moja bieda (la mia sventura).
Nel 1836 a una serata musicale Liszt gli presenta George Sand. La scrittrice, più vecchia di lui di sei anni, a questo primo incontro non gli piace. In realtà lei è un’infermiera nata, che lo adotta subito come malato e gli regalerà qualche anno di vita in più. Chopin, capito il genere (di lei) e conoscendo sé stesso, si confessa: “Se qualcuno vuole mettermi al guinzaglio, eccomi qua”.
Persona riservata e, da buon polacco, molto religioso, cerca di mantenere la relazione più nascosta possibile. Quando a ottobre lui e lei, con i suoi due figli, Maurice e Solange, partono per Palma di Maiorca, lo fanno separatamente. Qui passano l'inverno in tre stanze con giardinetto. Quello che doveva essere un paradiso tropicale, ideale per i suoi polmoni, diventa presto un inferno. Il clima, buono all’inizio, peggiora dopo poco e la malattia di Chopin si aggrava.
A Parigi non vivono nello stesso appartamento, ma in due contigui, però con la presenza costante dei due figli della Sand. Intanto i segni della malattia diventano sempre più evidenti. A venticinque anni erano cominciati gli sbocchi di sangue, a trenta pesa meno di 45 chili. Le difficoltà di respiro si sono aggravate e la sua salute delicata lo rende instabile e capriccioso.
Dopo nove anni insieme, viene fuori l’impossibilità di convivere con Maurice: la causa è la gelosia del ragazzo che vede in Chopin l’ostacolo a un normale rapporto con la madre.
Costretta a fare i conti, lei gli preferisce il figlio e lo molla.
Durante l'ultimo periodo della sua vita, Chopin fu assistito (o forse affettuosamente tiranneggiato, lui che si presentava come una vittima predestinata) da una sua allieva scozzese, Jane Stirling, che insieme alla sorella lo convinse a trasferirsi in Inghilterra. Il clima inglese e la vita mondana a cui lo forzarono le due ragazze diedero il colpo finale alla sua salute.
Tornato a Parigi, dopo sette mesi passati su al nord, era completamente senza forze; il suo stato si aggravò improvvisamente e dovette smettere di dare lezioni e ricevere gli amici.
Il 17 ottobre del 1849, alle 2 del mattino era morto.
Il funerale si svolse nella Chiesa della Madeleine in presenza di una grande folla e di molte personalità del mondo musicale: c’erano Liszt, Meyerbeer, Berlioz.
L'orchestra del Conservatorio eseguì il Requiem di Mozart. Sulla sua tomba venne sparsa la terra polacca mandata dalla famiglia.
Il suo cuore è tornato a Varsavia, nella Chiesa di Santa Croce.
N° 578 - Microbiografie Irrispettose N° 8 - Ludwig Van Beethoven

“Ludwig van Beethoven è un ragazzo di undici anni dal talento molto promettente. Suona il pianoforte con grande bravura e forza, legge molto bene a prima vista. Questo giovane genio meriterebbe un sussidio per permettergli di viaggiare” Dal Magazin der Musik, 2 marzo 1783.
La famiglia di Beethoven, di umili origini, era nella musica da almeno due generazioni. Il nonno di Ludwig si era trasferito a Bonn nel 1732, diventando Kapellmeister del principe elettore di Colonia. Suo figlio Johann, padre di Ludwig, era strumentista e tenore alla stessa corte. Uomo mediocre e brutale, alcolista inveterato, fu incapace di educare i suoi figli. Pare che spesso, completamente ubriaco, costringesse Ludwig ad alzarsi dal letto a tarda notte e a suonare il pianoforte o il violino per divertire i suoi amici.
Ci mise poco, Johann van Beethoven, a scoprire il dono musicale del figlio e a mettersi in moto per sfruttare le sue doti eccezionali allo scopo di ricavarne più talleri possibile; addirittura, dice qualcuno, cercando di farlo passare per più giovane di quello che era per venderlo meglio come bambino prodigio, alla maniera di Mozart.
Proprio pensando al piccolo Mozart, esibito dal padre in tutta Europa una quindicina di anni prima, Johann avviò Ludwig allo studio della musica già dal 1775 e tentò, poco più tardi, di presentarlo come virtuoso di pianoforte in un giro di concerti. L’iniziativa non funzionò, non perché il piccolo non fosse abbastanza bravo, ma probabilmente perché non aveva il carattere docile di Mozart.
Qualche anno dopo, la morte di sua madre e l’incapacità di quel vecchio ubriacone del padre di sostenere la famiglia spinsero Beethoven a assumersi la responsabilità del mantenimento dei due fratelli Kaspar e Nikolaus lavorando come violista nelle orchestre dei teatri.
“Caro Beethoven, Ella parte finalmente per Vienna per soddisfare un desiderio a lungo vagheggiato. Il genio di Mozart è ancora in lutto e piange la morte del suo pupillo. Presso il fecondissimo Haydn ha trovato rifugio, ma non occupazione e per mezzo suo desidererebbe incarnarsi di nuovo in qualcuno. Sia Lei a ricevere, in grazia di un lavoro ininterrotto, lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn.”
Così il conte Waldstein, suo protettore, presenta Beethoven a Haydn, il quale, impressionato dalle sue capacità, lo invita a proseguire gli studi con lui a Vienna.
Mentre il suo talento matura, Ludwig partecipa alle sfide pianistiche, apprezzate dalla buona società viennese, che lo consacrano il primo solista di Vienna. Virtuosi famosi come Clementi, Cramer, Hummel ne fanno le spese.
Insieme all’abilità di Beethoven cresce anche il suo spirito ribelle. In Slesia, al castello di un altro suo sostenitore, il principe Lichnowsky, Ludwig rifiuta di suonare per gli ufficiali delle truppe di occupazione di Napoleone. Il principe minaccia di farlo arrestare. Beethoven, dopo una violenta litigata lo pianta in asso, perdendone la protezione.
Ecco il biglietto, davvero audace per l’epoca, che fa recapitare al principe: “Principe, ciò che voi siete, lo siete grazie alla nascita. Ciò che io sono, lo sono grazie a me stesso. Principi ce ne sono e ce ne saranno ancora migliaia. Di Beethoven ce n’è uno solo.”
C’è un altro episodio, diventato il soggetto di un quadro famoso “L’incidente di Teplitz”, che si inserisce nella rotta di ribellione del nostro genio furioso. Nella cittadina termale di Teplitz, Beethoven passeggia insieme a Goethe. A un certo punto si imbattono nella famiglia imperiale d’Austria. Tutti, Goethe per primo, fanno ala, inchinandosi e togliendosi il cappello. Beethoven no. Lui prosegue la sua passeggiata come se niente fosse.
L’opinione di Goethe: “Non avevo mai incontrato un artista così fortemente concentrato, così energico, così interiore. Il suo ingegno mi ha stupefatto; ma egli è purtroppo una personalità del tutto sfrenata, che, se non ha certamente torto nel trovare detestabile il mondo, non si rende certo più gradevole a sé e agli altri.” Insomma, un genio, ma anche un vero rompiscatole.
La sordità: cominciata con i primi sintomi nel 1796; è totale nel 1820. Una labirintite cronica? Una otospongiosi? Non lo si è mai saputo. Chiuso e isolato per non rivelare in pubblico il suo dramma, si fa una pessima reputazione di misantropo ostile al mondo; nello stesso tempo vive circondato da una corte di allievi, ammiratori e parassiti che lo adulano, spesso irritandolo e con i quali comunica attraverso i famosi quaderni di conversazione (in gran parte distrutti senza spiegazione dal suo esecutore testamentario Felix Schindler).
Beethoven non si è mai sposato, ma molte sono le proposte che ha nel tempo lanciato in giro. Puntando sempre troppo in alto rispetto al suo livello sociale ed economico: contesse, baronesse, altoborghesi, figlie di consiglieri, scrittrici o cantanti di successo. C’è chi sospetta che queste dichiarazioni fossero solo di facciata per fingere, da parte di quel ruvido orso che era, l‘adesione a una serie di convenzioni sociali che non gli interessavano.
Sul piano familiare l’evento determinante della sua vita fu la morte del fratello Kaspar. Ludwig aveva promesso di seguire l’istruzione di suo figlio Karl e dovette affrontare una serie di processi contro la vedova di Kaspar per ottenerne la tutela. Malgrado le sue migliori intenzioni, questo nipote diventerà il problema più assillante della sua vita, tanto è vero che dopo un tentativo di suicidio del nipote stesso, rinunciò alla sua tutela e lo fece arruolare in un reggimento di fanteria comandato da un amico.
Verso la fine del 1826, durante un tragitto su una carrozza scoperta, sotto la pioggia, si prese una bella polmonite, che lo mise a letto e dopo qualche mese lo uccise, non prima che avesse lasciato suo erede universale il famigerato nipote Karl.
Al suo funerale c’era una folla di ventimila persone.
Il teschio di Beethoven fu acquistato dal medico austriaco Romeo Seligmann che ne ricavò un modello, che oggi è il vanto del Centro di Studi Beethoveniani in California.
N° 577 - Microbiografie Irrrispettose N° 7 Achille-Claude Debussy

Nasce in una modesta famiglia di commercianti di porcellane. Prende le prime lezioni di pianoforte da un’amica di famiglia. Il padre vorrebbe farne un ufficiale di marina, ma si fa convincere da questa amica (che è la suocera di Paul Verlaine) a fargli studiare musica e a iscriverlo al Conservatorio. Siccome il giovane ha bisogno di guadagnare, il Conservatorio stesso gli procura un lavoro come pianista accompagnatore presso la ricca baronessa russa Nadezda von Meck.
Poco dopo è presentato all’architetto Vasnier che lo prende sotto la sua protezione. Vasnier ha una bella moglie con cui il nostro giovane maestro, infischiandosi dei favori che il marito gli fa, nel 1886 intreccia una relazione, avviando così la sua brillante carriera di seduttore di pochi scrupoli e diremmo anche di pochissimo buon gusto.
Su suggerimento dell’architetto, ignaro delle, o indifferente alle corna, Debussy concorre al Prix de Rome, un soggiorno di due anni a Villa Medici, che lo stato francese assegna a studenti meritevoli nelle arti. Non lo vince la prima volta. Ci riprova. Non lo vince la seconda volta. Ci riprova ancora e, grazie anche al sostegno di Gounod, la terza volta ce la fa.
A dar retta alle sue lettere, Claude detesta il suo soggiorno a Roma, una città che non gli piace, costretto a convivere con colleghi con cui non va d’accordo e a sottostare a un regolamento che gli fa orrore. Sempre senza un centesimo, scrocca prestiti a tutti (una delle vittime è il conte Primoli, a cui chiede 500 franchi per pagare la cena di celebrazione della propria vittoria al premio).
I due anni passano; torna in Francia e, scioltosi dal rapporto con Madame Vasnier, si rimette ad abitare coi genitori. Passa le serate nei locali: al Chat Noir a Pigalle, dove conosce Erik Satie, che diventa suo amicone, oppure da Chez Pousset, dove artisti di ogni genere discutono fino a notte alta e dove incontra Paul Dukas ed Ernest Chausson. Insomma, fa la bella vita e nello stesso tempo si costruisce una ricca rete di amicizie.
Nel 1889 incontra mademoiselle Gabrielle Dupont, il secondo passo nella sua carriera di dongiovanni. Figlia di un sarto e bellissima ragazza, ci va a convivere. Vita di boheme: niente soldi, niente legna per il caminetto, poco da mangiare, litigate e rappacificazioni.
Breve intervallo di un paio di mesi nel 1894 con la cantante Therese Roger (racconta a tutti, mentendo, che Gabrielle lo ha lasciato), poi, come se niente fosse, ritorna da Gabrielle, con cui però le cose vanno sempre peggio, e quando lei scopre (1897) che Claude ha intenzione di lasciarla per la sua migliore amica, Rosalie Texier, detta Lily, indossatrice di rara bellezza, prende una pistola e si spara al petto.
Sbaglia la mira e il suicidio non riesce, ma Lily appena lo sa molla Claude, il quale le scrive una lettera in cui minaccia di uccidersi a sua volta se lei non ritorna da lui. La bella indossatrice si fa convincere e i due si sposano. Però per Claude, Lily, che piace a tutti gli amici, che è innamorata di lui, che è simpatica e anche molto bella, non è abbastanza intellettuale e interessata alla musica. Comincia a stufarsene.
Tutte belle eh, qualcuna anche bellissima; e non si sa come facesse perché lui certo non era un gran che: sulla fronte aveva grosse protuberanze ossee: probabilmente una forma tumorale benigna nota come osteoma eburneo, che lui per tutta la vita cercò di nascondere con frangette varie.
Insomma, aveva “una testa squadrata come una scatola, la fronte grande e sporgente e una barbetta rada che ricordava un lichene parassita”. Parlando balbettava un po’ e tendeva alla pinguedine. E in più non aveva mai un soldo in tasca. Da Chez Pousset era soprannominato “Le christ hydrocephale” mentre i figli della baronessa von Meck lo chiamavano “Le petit hippopotame”.
Nel 1903, colpo di scena! Debussy conosce Emma Bardac, moglie di un facoltoso banchiere e, al contrario di Lily, colta, raffinata; perfino musicista dilettante. In un batter d’occhio abbandona il tetto coniugale e si trasferisce da lei.
Nuovo tentativo di suicidio non riuscito. Rosalie si spara un colpo che va a piantarsi in una vertebra ma non la uccide.
Scandalo, riprovazione e allontanamento di molti amici. Doppio divorzio, dopo di che Claude ed Emma si sposano, hanno una figlia e vivono felici insieme fino al 1918, quando Debussy muore di un tumore, mentre i tedeschi bombardano Parigi con il loro supercannone a lunga gittata. Naturalmente, con la guerra in corso il suo funerale è ridotto al minimo: un frettoloso corteo di non più di venti persone
Per nostra fortuna in tutto questo andirivieni di ragazze e colpi di pistola, Debussy trova anche il tempo di fare il musicista e ci regala l’Apres-midi, La Mer, il Pelleas, opere scritte in un nuovo linguaggio, che naturalmente all’epoca non piacque alla critica, ma a noi, oggi, piace e molto.
Il suo paese lo ha onorato con un funerale ufficiale a fine prima guerra mondiale, e stampando il suo profilo, come abbiamo già detto non proprio bellissimo, sulla banconota da venti franchi.
In più, anche a lui gli astronomi hanno intitolato un cratere sul pianeta Mercurio.
N° 576 - Microbiografie irrispettose N° 6 Wolfgang Amadeus Mozart

Doveva essere una bella famigliola di musici vaganti: papà Leopold Mozart, vicekapellmeister presso la Corte di Salisburgo, ma soprattutto astuto (e talvolta implacabile) impresario e organizzatore della vita di sua figlia Nannerl, eccellente pianista bambina, e di suo figlio Wolfgang Amadeus, genio precoce, piccolo virtuoso e, come lo definiva suo padre, "il miracolo che Dio ha fatto nascere a Salisburgo".
Franz Joseph Haydn, unito a Wolfgang da amicizia e stima, malgrado ci fossero 24 anni di differenza, disse un giorno che i posteri non avrebbero visto un talento simile per i successivi cento anni.
Mozart aveva l’orecchio assoluto, naturalmente, e una memoria fantastica. Una sua prodezza: a Roma ascolta il Miserere di Gregorio Allegri, una monumentale composizione a nove voci considerata proprietà esclusiva della Cappella Pontificia (pena di scomunica a chiunque la portasse fuori del Vaticano per eseguirla) e riesce a trascriverlo a memoria dopo un solo ascolto. Gara fra geni: c’è un secondo aneddoto collegato a questo: Mendelssohn, in visita a Roma, per scommessa vuole ripetere l'impresa di Mozart e, dopo un solo ascolto, anche lui riesce a trascrivere la composizione. Però Mozart ha 14 anni, Mendelssohn più di 20. Conta la differenza?
Nei suoi concerti per pianoforte Mozart spesso lascia vuota in partitura la linea dello strumento solista che, con sprezzo del pericolo o pura incoscienza, suonerà lui stesso a memoria.
Una volta è addirittura preso per mago: a un concerto a Napoli un nobile nel pubblico attribuisce all'anello che porta al dito il merito della sua incredibile bravura; Wolfgang se lo toglie, lo posa sulla tastiera e continua a suonare magnificamente come prima.
Eterno bambino, Mozart era particolarmente bravo a scrivere da destra a sinistra, ma aveva paura del suono della tromba.
Si divertiva a cambiare il proprio nome latinizzandolo in Wolfgangus Amadeus Mozartus, italianizzandolo in De Mozartini, o capovolgendolo in Trazom Gnagflow.
Grafomane compulsivo, scriveva (specialmente alla sorella) lettere piene di parolacce infantili e insistiti riferimenti a flatulenze e funzioni fisiologiche. Si dilettava anche a comporre canoni e arie, alcune assolutamente squisite, sullo stesso argomento.
Nel 1777, a 21 anni, Mozart aveva un aspetto infantile e non aveva ancora bisogno di farsi la barba. Non era alto: uno e sessanta, esile di corpo, capelli biondi e fini, occhi azzurri, bei lineamenti. Aveva avuto il vaiolo in forma leggera e ne portava le tracce.
Malgrado la vita troppo breve scrisse 20 opere, 40 sinfonie, 30 concerti, 20 messe, 100 brani per pianoforte, 200 danze; più arie, serenate, canoni, eccetera eccetera.
Altrettanto infantile fu per tutta la vita il suo rapporto con il denaro. Bisogna anche capirlo e ricordare che quando girava con il padre e la sorella, anche se la vera star del trio era lui riceveva solo una paghetta.
Più tardi gli fece i conti in tasca, in una lettera del 1785, il suo amministratore dell’epoca, quel rompiscatole oppressivo, ossessivo e ricattatorio di papà Leopold. In quell’anno Wolfgang incassa circa 3.000 fiorini (a una famiglia con 2 figli ne bastavano 500 l’anno per vivere bene), ma lui ne spende 460 solo per l’affitto di un lussuoso appartamento, più altrettanto per vestiti, parrucche e gingilli e, ancora peggio, in maniera incontrollata e incontrollabile al tavolo da gioco e al biliardo, per il quale va matto; pur non essendo affatto bravo, ci scommette e perde.
Così entra in un vortice di prestiti e cambiali per rimborsare altri prestiti, di anticipi chiesti e non restituiti, di lettere fastidiose agli amici con richieste imbarazzanti anche di pochi fiorini e alla fine, pur essendo potenzialmente ricco, vive e muore da povero.
Tanto per farci un’idea (anche se è difficile fare un rapporto con oggi), negli anni ’70 a Vienna il direttore dell’ospedale generale prendeva 3.000 fiorini l’anno, il primario chirurgo 800, l’invidiato maestro Salieri 1.200, un professore universitario 300, un maestro di scuola 22 e la serva di Mozart, l’ultima pedina della società, 12.
I colleghi devono essere grati a Mozart perché la sua scelta di abbandonare il servizio presso l'arcivescovo di Salisburgo fu fondamentale non solo per lui, ma anche per la condizione dei musicisti in generale: era la prima volta (perlomeno nell'ambiente di lingua tedesca) che un compositore della sua statura si affrancava dalla sudditanza alla Chiesa o alla nobiltà e decideva di agire come libero professionista, legato solamente alle regole del mercato.
Il fatto che questa mossa a lui non riuscì del tutto è irrilevante: aprì la strada ai posteri, lasciando anche un’involontaria eredità al figlio Carl Thomas, che vivrà fino al 1858 e sarà l’unico a prendere diritti d’autore sul lavoro del padre.
Sempre a proposito di colleghi, Mozart non è tenero. Umilia quando può il potente Salieri; in un confronto pubblico alla tastiera con il venerando e rispettato Clementi, lo batte clamorosamente e poi ne scrive: "Clementi suona bene, fino a che guardiamo alla mano destra. A parte questo, non ha un centesimo di gusto o sensibilità; in pratica è solo un puro meccanico". Poi aggiunge: "Clementi è un ciarlatano, come tutti gli italiani".
In parecchi, anche fra i posteri, lo ricambiano: l’Imperatrice Maria Luisa di Borbone, presente alla prima, definisce La Clemenza di Tito “una porcheria tedesca in lingua italiana” e aggiunge che "la musica era così brutta che ci addormentammo tutti". Strawinskij chiama le sue messe “pasticceria rococò”. Debussy detesta i suoi concerti per pianoforte; a Prokofiev è talmente antipatico che non capisce come qualcuno possa amarlo. Berlioz, grande orchestratore sostiene che il suo a solo di trombone nel Requiem fa un effetto miserando.
E siamo arrivati alla leggenda del Requiem. E’ vero che gli fu commissionato, ma non da un misterioso personaggio che veniva ad annunciargli la sua morte. Il committente, che naturalmente aveva mandato un segretario, era, in carne ed ossa, il conte Franz von Walsegg, un signore ricco e conosciuto, ma anche in qualche modo patetico perché, vergognandosene un poco, comprava in gran segreto composizioni da famosi musicisti (anche Haydn fu un suo fornitore) e poi, spacciandole per proprie, le dirigeva nel suo castello davanti ai nobili amici, suonando anche le parti di flauto, che gli scrivevano appositamente semplificate.
Mozart si trovò nel dubbio se comporre il Requiem nel proprio stile, il che avrebbe reso molto difficile credere che fosse di Walsegg, o in una forma banalizzata, più appropriata al conte; ma questo gli ripugnava e quindi continuò a rimandare la conclusione del lavoro finché fu troppo tardi.
Morto Wolfgang, l’astuta moglie Constanze lo fece terminare dall’allievo Süssmayr, poi lo recapitò al conte facendosi saldare l’onorario. Ormai però ce n’erano in giro altre copie, tanto che alla fine venne pubblicato, naturalmente con il nome di Mozart.
Come salvare la faccia? Il conte ebbe una trovata assolutamente geniale. Raccontò ai suoi amici e cortigiani di essere stato allievo di Mozart per la composizione, e come tale di aver mandato i frammenti del Requiem al maestro man mano che li scriveva perché li correggesse. Le partiture erano rimaste nello studio di Mozart e, trovate dopo la sua morte, erano state pubblicate come sue.
Ultimo brandello di banale verità, fuori dal mito: Mozart morì normalmente nella sua casa a Vienna. Gli fecero un normale funerale di terza classe: il feretro era sostenuto da quattro portatori, preceduti da un crocifero e da quattro chierichetti con i ceri. Al seguito la vedova Constanze, la famiglia Weber, Süssmayr, altri allievi, alcuni amici e perfino (questo sì un colpo di scena) Antonio Salieri.
…E IL FIGLIO
FRANZ XAVIER WOLFGANG MOZART: 1791 – 1844
Era l'ultimo dei sei figli di Wolfgang e Constanze; solo lui e il fratello Carl Thomas arrivarono all'età adulta. All’epoca i bambini morivano come animaletti e con lo stesso effetto per i genitori e per la famiglia. Fu chiamato Wolfgang in omaggio a suo padre e Franz Xavier in omaggio a Franz Xavier Süssmayr, compositore, allievo e intimo amico di Mozart.
Voci girano sul fatto che, facendo i calcoli, risulta che fu generato in un momento in cui Mozart era lontano da casa, mentre Süssmayr era vicino a Constanze. Inoltre si dice che Süssmayr fece molta resistenza alla richiesta da parte della vedova di Mozart di completare il Requiem dopo la morte dell’autore. Sensi di colpa basati sui sospetti di una relazione fra lui e Constanze?
Franz Mozart nacque solo cinque mesi prima della morte di suo padre, quindi non lo conobbe; eppure visse sempre nella sua ombra, nella paura e nella consapevolezza di non poter raggiungere gli stessi vertici artistici. Fu allievo di Antonio Salieri e, proprio come il padre, iniziò a comporre da bambino; diede il suo primo concerto a 14 anni. Il suo carattere era molto diverso da quello di papà: introverso, timoroso, tendente all'autosvalutazione. Non si sposò mai e non ebbe figli.
Morì di cancro allo stomaco (qui forse si manifesta psicosomaticamente il rovello di essere figlio di un simile padre) a Karlsbad, dove è sepolto sotto una lapide che porta la seguente scritta: “Che il nome di suo padre sia il suo epitaffio, giacché la sua venerazione per lui fu l’essenza della sua stessa vita”. Chissà se Franz Xavier sarebbe stato d’accordo?
N° 575 - Microbiografie irrispettose N° 5 Niccolò Paganini

Nasce a Genova. Il padre Antonio, “ligaballe” al porto, intuisce il suo talento e lo mette subito a studiare da enfant prodige, come ha fatto Leopoldo Mozart con Wolfgang. A 8 anni scrive la prima sonata.
Studia e alloggia in collegio con i castrati che allora c’erano ancora e facevano furore.
Cerca in tutti i modi, e alla fine ci riesce, di sfuggire alla tutela paterna.
Comincia subito a viaggiare e da allora per tutta la vita girerà l’Europa in carrozza senza fermarsi mai.
A Lucca si innamora ricambiato della sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte.
Nel 1816 finisce in galera e viene condannato a pagare 3.000 franchi per aver rapito e sedotto una ragazza. Una volta libero continua a sedurre implacabilmente chiunque gli capiti a tiro, ma si dichiara contrario al matrimonio.
Malgrado ciò, in vista delle nozze con Carolina Banchieri (che poi non si faranno), chiede al curato della sua parrocchia di correggere sull’atto la sua data di nascita, in modo di figurare più giovane dei 40 anni che ha, e raccomanda alla madre, analfabeta, di fingere una frattura alla mano per avere la scusa di non firmare, risparmiandogli una brutta figura.
Poi invece sposa una certa Antonia Bianchi, una donna collerica che gli fa continue scenate prendendolo a schiaffi davanti a tutti e distruggendo il mobilio di casa, compreso la custodia del violino (lo strumento è salvo per miracolo). Hanno il figlio Achille. Poi si separeranno.
La sua salute comincia a vacillare. Lui si cura come si usava all’epoca, con veleni e salassi.
Comincia a manifestarsi la sua avarizia.
Antonia sempre più bisbetica.
Sulla Revue de Paris il dottor Bennati pubblica un cervellotico articolo sulla struttura fisiologica del genio, prendendo come esempio Paganini, e ne descrive il non meglio identificato organo musicale, le bozze della melodia molto sviluppate, il padiglione dell’orecchio largo e profondo, la flessibilità dei legamenti di spalla, braccio, polso e dita. Oggi pensiamo che fosse affetto dalla sindrome di Marfan che rende, appunto, scioltissimi i legamenti e le giunture.
La sua avarizia è ormai diventata sordida. Vuole comprare un panciotto di lana. Si offrono di accompagnarlo da un sarto. “No - risponde Paganini - portatemi da un mercante di abiti usati”. E per tre quarti d’ora tratta per ottenere il ribasso di un franco.
Traffica con la compravendita di strumenti musicali Amati, Guarnieri, Stradivari. All’epoca se ne trovavano ancora in giro. Credendo di essere furbo, si mette negli impicci per un locale che apre con dei soci, il “Casino”, che poi fallirà e gli costerà un sacco di soldi.
Sempre più immerso in cure inutili di balsami e acque miracolose. Salute a picco.
In punto di morte rifiuta il prete; per questo Monsignor Galvano, vescovo di Nizza, gli nega la sepoltura in terra benedetta.
Finalmente nel 1875 arriva il perdono della Chiesa e il figlio Achille lo porta nel cimitero di Parma.
In gioventù un certo Monsieur Livron gli aveva promesso in premio un violino Guarnieri del Gesù se fosse riuscito a leggere a prima vista un concerto difficilissimo. Lui lo suona senza batter ciglio, vince il Guarnieri, che era chiamato “Il cannone” per la potenza del suono, poi lo lascia in eredità a Genova.
A diciannove anni compone i famosissimi 24 capricci.
Esplodono rivalità e gelosie con gli altri solisti che comunque vanno tutti a sentirlo suonare.
Compone per chitarra e violino, che suona egualmente bene. Esegue entrambe le parti alternandosi agli strumenti, la chitarra attaccata al collo con un nastro e il violino imbracciato.
Suona con lo spartito capovolto, su una corda sola, facendo ogni genere di acrobazie. A Londra la musica sul leggio prende fuoco da una candela. Gli orchestrali gridano che Paganini è il diavolo perché continua a suonare leggendo lo spartito in fiamme.
Tutto quello che lo riguarda diventa di moda: panini a forma di violino, guanti con sul dorso ricamato un violino a sinistra, a destra un archetto.
Ha l’aspetto di uno stregone: magrissimo, indossa un frak fuori moda con le spalle spioventi e i pantaloni ripiegati sulle scarpe.
E’ anche oggetto di contestazione. A Bristol, in tempo di carestia, appare un manifesto contro i compensi eccessivi di Paganini: “Perché tutti questi concerti in un tempo di miseria e di angoscia? Ovunque si fanno collette per venire in soccorso ai disgraziati; per quale ragione questo violinastro straniero viene a prosciugare il denaro destinato ai miserabili?”
Il 30 ottobre 1829 a Weimar concerto gremito, presente Goethe che scrive: “Ho udito qualcosa di meteorico”.
Incassi nel 1828 = Fiorini 68.300
Incassi nel 1829 = Fiorini 100.000. Cifre non quantificabili oggi, ma di sicuro enormi.
A Londra il prezzo dei biglietti per i suoi concerti è tri o quadruplicato, e le repliche si susseguono con le diciture “ultimo concerto”, “ultimissimo concerto”, “realmente ultimo”, “irrevocabilmente ultimo concerto”…
N° 574 - Microbiografie irrispettose N° 4 - Clara Wieck Schumann

Una vittima: prima del padre, poi del marito, alla fine di sé stessa.
Clara nasce in un’epoca in cui per una donna il talento musicale era un semplice accessorio alla dote da portare al futuro marito.
Suo padre, Friederich Wieck, fabbricante di pianoforti, bravo insegnante di musica, ossessionato dal bisogno di veder confermate le sue capacità didattiche, riconosce immediatamente le doti di sua figlia e comincia a forgiarla, fin dai cinque anni con un metodo, certo duro, che però le dà una eccellente formazione. Il progetto è di farne una virtuosa di livello superiore, il che costituirà una ineccepibile testimonianza sulla bontà del suo sistema educativo.
A sette anni Clara passa già tre ore al giorno alla tastiera. A undici debutta con successo in concerto. Più o meno in quel periodo Robert Schumann, che ha nove anni più di lei, diventa allievo di Wieck padre.
Wieck accompagnava sempre la figlia; controllava i contratti, le sale, gli strumenti. Portava una borsa con gli attrezzi per accordare o riparare i pianoforti su cui avrebbe suonato Clara. Questo era indispensabile in un’epoca in cui i grancoda non viaggiavano e quindi spesso capitavano strumenti malmessi o scordati.
Nel 1835, anno importante, Clara trionfa nel suo primo grande concerto pubblico e lei e Robert si dichiarano amore eterno. Papà Wieck si infuria, caccia Robert e gli proibisce di rifarsi vivo. La sua preoccupazione di padre è probabilmente di non affidare la figlia a un giovane di talento ma squattrinato, mentre la sua paura di tutore (e tiranno) è certamente di perdere il suo investimento per il futuro, intuendo nel matrimonio, anche se felice, un ostacolo alla carriera dell’artista predestinata.
Il che puntualmente succederà.
I ragazzi, di fronte a questa incrollabile opposizione non possono fare altro che ricorrere al tribunale, che decreta per loro la possibilità di sposarsi senza il consenso paterno.

Ecco che Clara passa dalla schiavitù del padre a quella del marito.
La coppia possiede due magnifici pianoforti a coda. Quando compone, Robert esige assoluto silenzio, e allora, dato che le pareti di casa sono sottili, la povera Clara non può neanche pensare di avvicinarsi alla propria tastiera.
D’altra parte Clara è figlia del suo tempo e da una pagina del suo diario fa capolino la terza forma di schiavitù. Quella al costume dell’epoca e contro sé stessa: “Una volta credevo di avere talento creativo, ma sto cambiando idea: una donna non dovrebbe desiderare di comporre, mai una è stata capace di farlo, dovrei essere io quell’una? Sarebbe arrogante crederlo. Che sia Robert a creare, sempre! Questo deve rendermi sempre felice”.
E allora Clara si mette a dare lezioni, a occuparsi delle faccende domestiche e di tutti i figli che nel frattempo sono arrivati.
Finalmente cambiano appartamento; lì c’è lo spazio e l’isolamento acustico per i due pianoforti. La convivenza diventa più leggera, ma la sottomissione coniugale prosegue. Sempre dal diario di Clara: “Oggi ho iniziato per la prima volta dopo anni nuovamente a comporre; vorrei elaborare delle variazioni su un tema di Robert, per il suo compleanno”. Compone sì, ma come regalo per lui.
Dopo l’inferno che le ha fatto passare per tutte le manie, le depressioni, l’alcolismo, i tentati suicidi, gli attacchi di follia, Schumann muore lasciandola naturalmente senza un tallero, e Clara, che gli sopravvivrà di quarant’anni deve darsi da fare per mantenere i figli, quindi riprende l’attività solistica.
Così i 28 ottobre 1856, sistema i bambini qua e là, da parenti e amici e parte per il primo giro di spettacoli. Avanti così per anni: d’inverno concerti, d’estate bambini e preparazione del repertorio per la prossima stagione.
Per sua fortuna adesso ha un amico, Johannes Brahms, sempre presente con la sua devozione (da molti ci si chiede se questa devozione non sia anche un grande, discreto e incrollabile amore). Non si è mai saputo, tanta era, appunto, la discrezione.
Dopo qualche anno però cominciano a manifestarsi sempre più spesso grossi problemi di affaticamento, che poco alla volta diventano una vera e propria patologia, quella che i medici chiamano sindrome da sovraccarico, dovuta al continuo stress di mani, polsi e braccia nelle troppe ore di esercizi e di esibizioni alla tastiera.
Trova una cura che allevia ma non elimina il problema, per cui deve diminuire di molto la sua attività e soprattutto, con grande dispiacere, escludere dal suo repertorio i brani più faticosi anche se gratificanti, come i due concerti per pianoforte e orchestra del suo amico Brahms, che lei aveva contribuito a promuovere, ma che dopo l’esibizione la lasciavano sfinita.
Muore a settantasette anni ed è sepolta a Bonn insieme al marito Robert Schumann.
N° 573 - Microbiografie irrispettose N° 3 - Robert Schumann

Robert Schumann nasce in Sassonia, in mezzo a quella natura che sarà così importante nella sua musica. E’ l'ultimo di sei figli di August Schumann, libraio, editore e scrittore. La madre, è una discreta pianista dilettante.
Robert a sette anni inizia a studiare musica con l’organista della cattedrale. Nel 1826 muore il padre lasciandogli (chi non vorrebbe avere un padre così?) diecimila talleri per terminare gli studi, risparmiandogli di entrare nella ditta di famiglia in cui già lavorano i suoi fratelli.
Va a Lipsia e si iscrive a legge, ma intanto prende in affitto un pianoforte. Conosce Friedrich Wieck, il più importante insegnante di musica della città, e diventa suo allievo. Come si usava all'epoca, si trasferisce in casa del maestro; qui suona spesso a quattro mani con la figlia bambina di Wieck, Clara.
Schumann vuole diventare un concertista e non un compositore. Quando nel 1832 Wieck parte per scortare la figlia, undicenne ma già pianista di talento, in un giro di concerti, Schumann decide di migliorare la sua tecnica collaudando su sé stesso un apparecchio che ha inventato per aumentare la divaricazione fra le dita e quindi l'estensione della mano. Un’idea che più scema e pericolosa non poteva farsela venire. Già in precedenza aveva avuto problemi con le mani; adesso naturalmente questi sono peggiorati.
Quando i Wieck rientrano, Schumann vuole fare ascoltare al maestro la nuova opera che ha composto in sua assenza: “Papillons”, ma il guaio è fatto e ormai ha due dita della mano destra paralizzate; l’opera dello sciagurato compositore, imparata in un attimo, a papà gliela suona Clara.
Cominciano ad aggravarsi le manifestazioni della sua instabilità mentale, già apparse in precedenza; soffre di amnesie, di allucinazioni sonore, resta assorto per ore.
"Ho sognato di affogare nel Reno": aveva annotato Schumann su un foglietto all'età di 19 anni. Il 26 febbraio del 1854 tenta di suicidarsi per davvero gettandosi proprio nel Reno; salvato dai barcaioli, su sua richiesta finisce internato nel manicomio di Endenich. Nel 1855 ha un lieve miglioramento, gli permettono di uscire, va a Bonn e lì rimane immobile ore e ore in piazza, in piedi davanti al monumento di Beethoven. La situazione si trascina ancora per un anno, con qualche lampo di lucidità e con l’assistenza di Clara, Brahms e altri amici che vanno spesso a trovarlo. Muore il 29 luglio del 1856.
I disturbi nervosi che hanno tormentato Schumann per gran parte della sua vita sono stati attribuiti a una sifilide contratta molto tempo prima. Si è anche pensato a un tumore cerebrale oppure a un disturbo bipolare. La morte forse provocata da avvelenamento da mercurio con cui sciaguratamente lo curavano. Distrutte le sue cartelle mediche per volontà della famiglia, la diagnosi è rimasta sepolta nel mistero.
La figlia di Wieck aveva appena quindici anni e Robert l'aveva conosciuta bambina. Il padre la voleva destinare a un futuro di grande concertista e quando intuì l'interesse di Schumann per lei, la costrinse a lunghe tournée pur di allontanarla. Clara era già una pianista affermata; ai suoi concerti assisteva Goethe. Nicolò Paganini la ascoltò più volte suonare e le regalò anche un frammento scritto apposta per lei.
Papà Wieck cercò in tutti i modi di tenere separati i due innamorati, perfino facendo causa a Robert per alcolismo e rimediando in cambio una bella condanna per calunnia. Alla fine la spuntarono loro e riuscirono a sposarsi, ma ormai Robert come pianista era finito, e la famiglia dovette basarsi per la sopravvivenza solo sul talento di Clara. I primi anni di matrimonio furono felicissimi, però presto arrivarono i problemi economici.
Schumann nel frattempo aveva iniziato a pubblicare una rivista musicale di cui era editore, direttore, redattore, insomma faceva tutto lui. Famosi alcuni suoi pungenti giudizi: “Cimarosa: magistrale nella tecnica, ma noioso e vuoto d’ogni pensiero”. “Donizetti, La Favorita: musica da teatro di marionette”; “Liszt: se non altro lo si è visto scuotere la criniera”. E il famoso bisticcio con Wagner. Wagner: “Schumann è un uomo impossibile, non parla mai”. Schumann: “Wagner è un uomo impossibile, non fa che parlare”.
Ma in seguito le sue passioni esagerate, i picchi di esaltazione e di depressione, gli insuccessi professionali e anche l’alcolismo lo misero fuori combattimento come marito, come giornalista e come musicista. Non si controllava più: una sera, in presenza di amici, mentre Clara stava suonando un suo pezzo (forse troppo veloce o troppo lento, chissà), corse come un pazzo al pianoforte e gridando: “Non è così che si suona Schumann!” chiuse il coperchio dello strumento sulle dita della moglie rischiando di fracassargliele.
Clara continuò la sua carriera di pianista e, grazie ai concerti nei quali eseguiva, insieme a Chopin e Beethoven, le musiche di Robert, fece crescere talmente la notorietà di Schumann che i suoi diritti d'autore arrivarono a superare quelli di quasi tutti gli altri autori contemporanei.
Peccato che per lui era troppo tardi.
N° 572 - Microbiografie Irrispettose N° 2 - Antonio Vivaldi

“L’anno 1678, il 4 marzo, era una domenica. Venezia fu percorsa da un tremito che fece dare brividi sconnessi alla terraferma, illividire le lagune, offuscare il cielo: il terremoto! All’ora della messa grande: caduta una casa, sprofondato un arco, danni gravissimi”.
Lo stesso giorno nasce Antonio Vivaldi figlio di Giovanni Battista, violinista in S. Marco, gracile e per questo battezzato in casa.
“Chi nasce in un anno di terremoto è destinato a portare scompiglio a sé e gli altri.”
Infatti lui cresce di carattere focoso e combinaguai.
Appena ha l’età per farlo Vivaldi decide, d’accordo con il padre, di indossare la tonaca che, se non eri nobile, a Venezia serviva da garanzia e da lasciapassare per tutti gli ambienti. Una scelta decisamente carrieristica. Disciplinatamente il nostro segue tutti i gradi fino all’ordinazione a sacerdote a 25 anni. Da quel momento dimentica l’altare; rimane prete ma non dirà mai più messa.
A Venezia i trampolini per il successo erano la chiesa e il teatro.
A Venezia i costumi erano molto liberi. Con la scusa che uscivano spesso in maschera, i veneziani ne combinavano di tutti i colori.
A Venezia si faceva musica dappertutto: in casa, in chiesa, in teatro, in piazza.
Vivaldi comincia a interessarsi al teatro, un ambiente in cui regna la concorrenza, anche sleale. I proprietari delle tante sale, quasi sempre nobili, non pagano gli autori, i quali, non esistendo la tutela dei diritti, fanno causa ma con tempi lunghissimi e risultati incerti. A loro volta i gestori fanno causa ai cittadini che affittano i palchi e non li pagano.
Insomma, una gran confusione.
Intanto Vivaldi lavora al conservatorio della Pietà, una delle quattro istituzioni riservate alle ragazze povere. Insegnare lì è una grande responsabilità, ma anche un grande onore.
Quando porta le sue partiture alle Putte della Pietà, l’esecuzione è sempre una sorpresa per tutti. Lui è appassionato della sua scuola, e le ragazze di lui. La Pietà lavora molto: nel 1706 offre al pubblico 27 trattenimenti musicali.
Il primo bel colpo di Vivaldi è “L’Estro Armonico”, stampato in Europa dal grande editore Roger, che nasce dalla sua “indemoniata e furiosa febbre creativa”; pensato per la pubblicazione, ma anche per l’esecuzione e lo studio da parte delle Putte della Pietà, che erano brave e spesso anche carine, tanto è vero che, benché prete, Vivaldi se ne prende una in casa come segretaria.
Scandalo!
Lancia il concerto grosso; le sue innovative trovate musicali sono definite: “Istigazioni a delinquere contro il concerto grosso tradizionale”.
Parecchie di queste composizioni sono trascritte per cembalo da Bach, che è un suo estimatore.
Vivaldi ne compone una grande quantità. Stravinskij, che tanto tenero non era, diceva che Vivaldi aveva scritto 800 volte lo stesso concerto. Lui stesso dichiara di “saper scrivere un concerto strumentale, con tutte le sue parti, più velocemente di quanto ci metta a terminarlo un copista”.
Riceve l’incarico di insegnare violoncello alle putte, e questo lo spinge a scrivere anche per quello strumento, che all’epoca era ignorato da compositori ed esecutori.
Nel 1709 c’è una grande gelata. Le barche sono bloccate in laguna e la gente cammina sui canali. Grande festa e tanta musica. Arriva a Venezia Haendel. Si incontrano
1717: culmine della carriera di Vivaldi con la nomina a Direttore dei Concerti della Pietà, Musico di Corte del Conte Morzin e Maestro in Italia di Filippo d’Assia, con nientemeno che tre stipendi.
Pubblica con enorme successo “Le Quattro Stagioni”, che incorona definitivamente il suo nome e rimarrà, fino alla sua riscoperta, la sua opera più famosa, con la quale dà corpo definitivo alla musica descrittiva (in questo caso accompagnata da poesiole spesso derise dai critici, forse scritte da lui stesso, che usa per sottolinearne l’impostazione naturalistica): “Giunt’è la primavera e festosetti / la salutan gli augei con lieto canto, / e i fonti allo spirar de’ zefiretti / con dolce mormorio scorrono intanto /” …e così via primaverilmente cinguettando.
Vivaldi è ormai lanciato nel teatro. Fa tutto: allestimenti, scrittura, musica, assume cantanti e orchestre. Impresario di grande fortuna, va a Roma per l’Anno santo 1725 e viene presentato a Papa Benedetto XIII.
Ma torna presto a Venezia, dove incontra Goldoni, ma dove in questo periodo ha parecchi fastidi dai propri fratelli che sono dei mezzi imbroglioncelli, fanno pasticci e piccole truffe e gli creano imbarazzo.
E’ un periodo di splendore per Vivaldi e di enormi guadagli teatrali, tali che fanno scrivere a un cronista veneziano dell’epoca: “L’abbate don Antonio Vivaldi, eccellentissimo suonatore di violino, detto il Prete Rosso, stimato compositore di concerti, guadagnò ai suoi giorni 50.000 ducati, ma per sproporzionata prodigalità morì miserabile a Vienna”.
Proprio così: a un certo punto parte per Vienna e lì, non si sa come e perché (mancano notizie su questo brutto finale), muore il 28 luglio 1741 nella più assoluta miseria e viene sepolto come un pezzente con un funerale da 19 fiorini e le campane a metà, quelle da povero.
N° 571 - Microbiografie Irrispettose N° 1 - Franz Schubert

Franz Peter Schubert nasce povero (e muore povero a soli 31 anni) ma in una famiglia civile e nel paradiso della musica: Vienna.
Dodicesimo di 14 figli, di cui solo 5 diventano adulti; a quel tempo tanti bambini morivano prima di crescere, fra l’indifferenza di tutti: considerati poco più che gattini da rimpiazzare con il prossimo parto che spesso andava male, e allora si perdeva il bambino e anche la mamma.
Il padre è maestro di scuola in un’epoca in cui l’insegnamento della musica è obbligatorio in tutte le scuole dell’Austria.
Franz impara presto pianoforte, violino, organo e viola. A casa suonano tutti insieme, in quartetto o in trio.
E’ tanto precoce che uno dei suoi maestri dichiara: “Ogni volta che cerco di insegnargli qualcosa di nuovo, lui la sa già”.
Entra nel Regio Imperiale Convitto, esaminato e ammesso da Antonio Salieri, all’epoca ancora perseguitato dalle maldicenze sulla morte di Mozart, ed è così bravo che presto riceve un encomio solenne dalla segreteria dell’imperatore.
Al convitto si mangia poco e male e si dorme al freddo, ma ogni sera i ragazzi suonano una sinfonia e un paio di ouverture. D’estate i vicini si affollano sotto le finestre aperte per ascoltarli.
Conosce e corteggia Therese; il matrimonio non si fa perché lui è troppo povero. La ragazza sposa un panettiere non certo ricco ma con un mestiere, non come Schubert.
Dal 1814 al ‘16 fa anche lui il maestro di scuola, soprattutto per evitare il servizio militare, da cui la benemerita categoria è esentata, ma rimane povero come prima.
Sa scrivere lettere amabili e comincia presto a manifestare il suo carattere allegro e compagnone e la sua inclinazione per il bicchiere e il buon cibo.
Organizza spesso le “schubertiadi”, riunioni a base di bevute, musica e lettura di poesie fra amici, tutti maschi, di cui alcuni hanno fama di omosessuali: tolleranti e tollerati.
E’ festaiolo, beve molto ed è sempre in cerca di ragazze. Che lo evitano perché è malvestito, sporco e puzza.
E’ basso, tozzo, viso rotondo, naso largo, labbra tumide, mani grosse e dita corte. Lo chiamano “Schwimmerl”, funghetto.
Tira avanti con l’aiuto di un gruppo di amici che gli pagano la stampa della musica, (lui non è proprio capace di proporsi agli editori) e che poi gli pagheranno anche il funerale.
Nel 1818 è assunto per insegnare pianoforte alle due figlie del conte Esterhazy, a Zseliz. Non abita al castello ma nell’alloggio della servitù: “un posto tranquillo, tranne per quaranta oche rumorose, ma con una domestica molto graziosa”.
Probabilmente una delle poche avventure della sua vita, magari concausa della sifilide che Franz si prende fra le quaranta oche schiamazzanti o in uno dei bordelli che frequenta.
Fatto sta che ne muore, nel 1828.
Ha composto moltissimo. E’ considerato il maestro indiscusso dei lieder. Ne ha scritti seicento, molti su testi di Goethe, il quale peraltro ignorava regolarmente gli spartiti che Schubert gli mandava. Melodie che cantano l’amore deluso, disperato, appassionato, inespresso, focoso, struggente, ingenuo, impossibile.
Da tutti apprezzate, anche se con qualche dissenso, per esempio di Scriabin che giudicava i suoi pezzi “roba buona per essere pestata sui pianoforti dalle signorine”.
Ha scritto sei opere, nessuna eseguita o pubblicata. Ce n’è una che avrebbe potuto avere successo: “Claudine von Villabella”, se non che ne rimane solo il primo atto perché il secondo e il terzo furono usati dai domestici del suo amico Hottenbrenner, che custodiva l’unica copia del manoscritto, per accendere il fuoco nel camino.
Di lui Beethoven disse: “In questo ragazzo c’è la fiamma divina”; e lui lo venerò: fu addirittura fra quelli che ne portarono la bara al funerale.
Ci rimane la cronaca di un suo disastroso incontro, proprio con Beethoven, nel 1822.
“Accompagnato da Diabelli era andato a trovarlo portandogli una copia delle Variazioni per pianoforte a quattro mani che gli aveva dedicato. Timido e senza parole, davanti al grand’uomo si trovò in difficoltà. Quando Beethoven gli chiese di scrivere personalmente le risposte alle sue domande (il maestro era già sordo e corrispondeva con gli altri attraverso un taccuino), la sua mano paralizzata rifiutò di muoversi. Intanto Beethoven aveva dato un’occhiata alle Variazioni e, scoperta un’inesattezza, la segnalò con garbo al giovane, aggiungendo che si trattava di piccola cosa.
Schubert perse completamente il controllo, si precipitò fuori e, come un pazzo, cominciò a prendersi a pugni in testa e a insultarsi”.
Mai più trovò il coraggio di ripresentarsi al suo mito.
N° 570 - Il diritto d'autore

Il merito è tutto suo. O forse stiamo esagerando un po’?
Di Mozart stiamo parlando. Quando decise di mollare la sua posizione alla corte dell’Arcivescovo di Salisburgo di sicuro non si rendeva conto che stava cambiando il destino di tutti noi. Era la prima volta che un compositore del suo livello si scrollava di dosso quel vincolo di sudditanza alla Chiesa e ai nobili e decideva di lavorare come libero professionista, legato solo al mercato.
Di lì a poco questa nuova posizione sarebbe diventata il presupposto indispensabile per l'affermarsi in musica dell'individualismo romantico.
Ma non di questo vogliamo parlare, bensì del forse banale ma socialmente determinante meccanismo del compenso per la creatività artistica.
Fino all'epoca di Mozart, infatti, musicisti come lui e come suo padre Leopold, che non fossero suonatori da strada, trovavano una sistemazione solamente impiegandosi in pianta stabile presso una delle molte corti o istituzioni collegate; il loro ruolo era subalterno all'aristocrazia, equiparato a quello del personale di servizio. Leopold Mozart si era adattato a questo tipo di sistemazione e si aspettava che anche suo figlio facesse carriera come musicista di corte, magari in una corte più grande e più ricca di quella di Salisburgo; ma Wolfgang, quando fu maggiorenne, si ribellò alla schiavitù dei preti, dei nobili (e già che c’era anche a quella di suo padre).
Si può anche dire che perse la partita, ma intanto aveva aperto la strada.
Perché fino alla fine del ‘700 la musica, a parte quella di chiesa, era mero intrattenimento. L’artista autonomo che si affidava per il successo al pubblico non esisteva. I concerti a pagamento, le accademie, erano all’inizio. Per tradizione tutti i musicisti preferivano basarsi sullo stipendio di un principe. Era inconcepibile che un compositore potesse sopravvivere grazie al mercato, anche perché il diritto d’autore ancora non esisteva.
Il compositore di un’opera o di una sinfonia era pagato solo per la prima esecuzione, e da quel momento non vedeva più un centesimo per le repliche. Se il prodotto aveva successo, allora partiva un piccolo commercio di arie e brani staccati, ma la loro diffusione era un problema perché tutta la musica era copiata a mano. I veri padroni del mercato erano i copisti che spesso riuscivano a intercettare gli incassi. Talvolta erano anche compositori e completavano le partiture lasciate a metà dagli autori, (anche da Mozart, che così riusciva a comporre più velocemente, tanto le parti mancanti rientravano in modelli standard, facili da integrare). Leopoldo stesso fu copista per suo figlio.
I primi veri diritti d’autore arrivano grazie a Napoleone, a fine secolo. L’unico Mozart che vede due talleri è Carl Thomas, che nel 1844, 53 anni dopo la morte del padre si può permettere di acquistare un piccolo podere in Brianza con i diritti di alcune rappresentazione delle Nozze di Figaro in Francia.
Poi, con Beethoven, comincia ad affermarsi seriamente il compositore autonomo; e via, sempre meglio, fino a una data importante per gli italiani, il 1882, in cui viene fondata la Società degli Autori da Verdi, De Amicis, Carducci, Sonzogno, e altri importanti personaggi della cultura e dello spettacolo.
In seguito la leggenda di un Mozart morto in miseria fu smentita da studi che chiarirono come il compositore guadagnasse in realtà, nei suoi anni viennesi, cifre considerevoli; ma questo ricco, anche se non impetuoso fiume di denaro finiva sui tavoli da gioco e in un vortice di spese sconsiderate al quale, insieme a lui, partecipava allegramente e attivamente anche la Signora Mozart, Constanze.
Ecco il perché del funerale da poveri e della fossa comune.
N° 569 - Professioni scomparse

Il Puntatore. Da anni, anzi decenni frequentiamo il mondo della musica, leggera e classica, e mai ci era capitato di incontrare questa figura: il puntatore.
Siamo a cavallo fra il sei e il settecento e dovunque fiorisce una quantità di cappelle musicali che oggi neanche ce le sogniamo. Cantare in un coro è ambizione di molti e soprattutto è un’attività che garantisce un salario sicuro in quei tempi difficili, anche perché, non essendo ammesse le donne, c’è posto pure per i ragazzi (e forse per qualche castrato in incognito).
La cappella musicale è composta dall’organista, dal coro e dal Maestro di Cappella. Accanto a questi, nominato a turno fra i cantori c’è il nostro personaggio, oscuro ma di grande potere: appunto il puntatore. Il suo ruolo è segnalare tutti coloro che trasgrediscono le regole e darne nota al camerlengo, il quale, “avanti di pagare il mese”, detrae l’ammontare della multa dal salario.
E le trasgressioni possono essere tantissime in un regolamento rigido e minuzioso. Rileggiamone alcuni articoli nel linguaggio pomposo e un po’ ridicolo del tempo, sempre tenendo presente che “se alcuno per domandar gratia a un prencipe mondano studia di compor se stesso & le sue parole con habito onesto, gesti decenti, parlar moderato, distintamente e con attentione, con tanta maggior diligenza in luogo sacro ciò convien di fare in pregare l’onnipotente Iddio”. Perciò:
“Non cominciar il versetto sin che l’altro non sia finito, et quelli che contrafaranno saranno multati in baiocchi cinque per ciascuna volta”.
“Nessuno dovrà tenere le labbra serrate, ma tutti nei salmi, hinni et cantici con allegrezza spirituale mandar voci di laude al signor Iddio, sotto pena di esser multati come absenti”.
“Quando si dice il Gloria Patri ogn’uno si cavi la beretta et inchini divotamente il capo”.
“Nessuno di essi cantori o cappellani debba partirsi di Choro (mentre durano li divini uffitij) senza espressa licenza, et al puntatore che altrimente concederà tal licenza, in giulij due per ciascuna volta”.
“Non vadino né stiano senza cotta et veste longa et habito clericale, etiam che fosse il giorno over la settimana sua vacante, sotto pena di giuli due per ciascuna volta; et stiano con quella gravità che si richiede, non confabulando o parlando insieme, sotto pena d’un giulio per ciascuna volta; et finiti gli uffitij divini ritornino a spogliarsi senza tumulto ne i luoghi loro ordinarij, sotto pena di baiocchi cinque per ciascuna volta”.
E c’è anche un premio per la delazione:
“Per la lor fatica i detti puntatori habbino, oltre la rata loro, a ragione del cinque per cento”.

Il Castrato. Gli amici gastronomi non ci fraintendano: non è a loro che ci rivolgiamo per descrivere le delizie di un gustoso animale che spesso frequenta le nostre tavole: braciolette, carrè, sella. Non a loro parliamo, ma agli amanti dell’opera; e le delizie a cui ci riferiamo non sono per le papille gustative ma per i timpani.
Si chiamavano Farinelli o Pacchierotti, erano stati evirati da piccoli in modo da bloccargli la muta della voce, ma non la crescita del corpo. Così da grandi sviluppavano un’emissione imitabile con il falsetto, ma certamente ineguagliata come timbro e potenza. Insomma, uno strumento fra la voce bianca e quella femminile, ma servito dal potente mantice dei polmoni di un uomo adulto. Erano amati, ammirati, applauditi dappertutto. Le rockstar del settecento. Nessun solista ha mai raggiunto la fama e la ricchezza di questi personaggi, che però, per arrivarci, avevano dovuto pagare un prezzo, diciamo così, un po’ salato. E non smettevano di pagarlo, facendo talvolta la triste fine dei fenomeni da baraccone.
Questo intervento era deciso non certo dal ragazzo, ma dai suoi genitori, nonni, tutori. Ed è umano che, una volta diventati famosi, tutti cercassero di spiegare, nella vita o nelle autobiografie, una situazione scabrosa come la loro con storie di cure mal condotte o accidenti fantasiosi se non addirittura inverosimili.
D’altra parte, pensiamo a quelle migliaia di ragazzini che, per colpa dei genitori, lo stesso prezzo lo pagavano ma senza avere in cambio il successo. E’ che all’epoca, per molte famiglie povere con un figlio minimamente dotato per la musica, questa era una delle poche speranze di sistemarsi.
Col tempo questa pratica incivile è stata abolita. Però, da appassionati, a noi rimane lo scontento di non aver mai potuto ascoltare direttamente quei fenomeni. Pazienza.
Detto questo, venisse a qualcuno la perniciosa idea di andare a sentire l’unica registrazione esistente (inizio ‘900) di un castrato, su You Tube c’è Alessandro Moreschi, l’ultimo sopravvissuto della categoria. Ammesso che sia autentica, è orripilante. Sembra di ascoltare una comare di mezza età, ubriaca e anche un po’ stonata. Forse è colpa dell’arcaicità dell’incisione, comunque consigliamo vivamente di soprassedere se si vuole tenere vivo il mito.
N° 568 - Pesce d'aprile
E invece è tutto vero

San Crisogono a Trastevere è una grande chiesa arcaica nei cui sotterranei si sgomitola tutto un groviglio di scale, pozzi, saloni e salette, muri di precedenti chiese con affreschi mezzo sbiaditi, scrostati mosaici romani, frammenti di colonne e sarcofagi vuoti.
Vuoti? Tutti tranne questo. Ci saranno dentro omeri e femori di almeno una dozzina di chissà quali morti. Proprio così: un mucchietto d’ossa buttate lì come in un bidone della spazzatura.
Fa un certo effetto, ma forse dovremmo prenderlo come un segno dell’insignificanza della vita nei tempi lunghi. E del fatto che prima o poi diventiamo tutti polvere (anzi, immondezza).

Al di là del fiume, a Sant’Agostino, ci imbattiamo in un Cristo, tutto il contrario del giovanottone nordico, biondo e muscoloso, che era l’iconografia del periodo.
Guardiamo questo, invece: bruno, bruttino, rachitichello e per niente maestoso, ma dolente, proprio come ce lo ha raccontato anni fa Pasolini nel suo Vangelo.
C’è da chiedersi come mai i committenti si siano accontentati di un’opera quasi blasfema come questa, con Gesù sorprendentemente accessoriato di un gran barbone nero, di peli sul torace, sotto le ascelle e perfino sull’addome.

E invece che dire di questo vezzosissimo Cristo in minigonna col pizzo, dalla chiesa del Domine quo vadis?

E non finisce qui.
Dalla profonda cripta di Santa Maria dell’Orazione e Morte a Via Giulia, una confraternita che si occupava di recuperare e dare sepoltura ai cadaveri degli annegati e dei morti ammazzati, all’epoca abbondanti, a quanto pare, sulle sponde del Tevere e per le strade di Roma, ecco un documento un po’ inconsueto.
Si tratta di un certificato di decesso stilato non su una vecchia pergamena o su un polveroso registro parrocchiale, ma direttamente sul defunto, anzi, più precisamente inciso sul suo cranio.

Per concludere, a Santa Maria della Vittoria, sul pavimento della Cappella Cornaro, sotto gli occhi estatici della Santa Teresa del Bernini, ci sono due mezzi morti (letteralmente) che se la ballano con stile.

O forse pregano? L’incertezza è d’obbligo con uno come il Cavaliere Gian Lorenzo che si faceva beffe degli interdetti del Concilio di Trento e ritraeva i suoi soggetti come gli pareva.
Sante preda di un rapimento potenzialmente equivoco e scheletri tagliati a metà, ma scatenati in mosse di danza.
N° 567 - Sostituzione
Qualche giorno fa sulla stampa è uscito un succulento articolone intitolato: “Pranzo al Museo, e l’Arte è servita”. Si tratta di una esplorazione di tutti i ristoranti, bar o a nche tavole calde, aperti nei musei di Roma. “Caspita! - ci siamo detti, colpiti anche se un po’ diffidenti - ecco un tema che risveglia il nostro appetito e che vogliamo gustare con i nostri lettori”.
Però, fra collezioni irraggiungibili per riallestimento e nostri problemi di organizzazione, alla fine ci siamo trovati a non avere ancora niente da raccontarvi.
Ci scusiamo, vi promettiamo un indennizzo e vi proponiamo in sostituzione un articolo di tempo fa che ci sembra ancora attuale e interessante.

Roma, centro storico, domenica. Appena fuori da casa, ecco la grande colonna di granito grigio che sostiene l’angolo dell’edificio, sprofondata nel terreno fino alle cantine. Un salto dal giornalaio e contiamo una decina di colonnine usate come paracarri. Un cappuccino al bar che ha al centro della sala una colonna di meraviglioso marmo color crema lisciato da secoli di carezze; e finalmente una capatina in chiesa, dove c’è il meglio del meglio.
Questo, in una normalissima passeggiata di pochi metri. Colonnone e colonnine riutilizzate, magari dopo essere state sepolte per qualche secolo sotto la sabbia del fiume. Perché è così che sono spariti, e si sono salvati, un’inondazione dopo l’altra, i resti della magnifica architettura, e soprattutto dei magnifici materiali usati da Roma (un pezzo di cemento vecchio di venti anni è sbriciolato, scrostato, brutto; un pezzo di marmo vecchio di venti secoli è solo impolverato. Una sciacquatina e ridiventa splendido).
Bene, le colonne grandi, belle e in buono stato si sono trasferite nelle chiese, e sono centinaia; quelle rotte sono diventate paracarri e guardaportoni, e sono migliaia. Di tante altre siamo riusciti, con una piccola indagine, a ritrovare la destinazione.

Per esempio il pavimento di S. Agostino. Bellissimo, variopinto, lussuoso, ornato di losanghe, rombi e quadrati al centro dei quali ci sono perfette circonferenze di splendido marmo. Che non sono altro che fette di colonne tagliate come fossero salami e inserite nelle geometrie su cui si cammina.

E poi ci sono i portoni dei grandi palazzi nobiliari, papali, cardinalizi, che naturalmente hanno una soglia in cui sono scavati i solchi per le carrozze che entrando nel cortile dovevano seguire quelle guide per non andare a raschiare gli stipiti con i mozzi delle ruote.

Bene, quei monoliti su cui noi poggiamo i piedi meravigliandoci del bellissimo granito rosa o grigio di cui sono fatti, sono anche loro colonne (di qualche tempio, salone o peristilio), solo che invece di essere fatte a fette, sono tagliate per il lungo, in modo che la parte arrotondata vada adagiata sul terreno, mentre quella dritta rimanga a vista con, scalpellati nel fusto originale, i piccoli solchi antiscivolo per le pantofole dei cardinali e quelli grandi per le ruote delle carrozze.
E il meccanismo di questo recupero si capisce andando a cercare questo bellissimo frammento rilavorato di granito grigio, in cui si vede bene la curva della colonna nella parte di sotto e la lavorazione per la nuova destinazione in quella di sopra.
Lo trovate buttato a terra insieme ad altri marmi lungo il sentiero che porta alla Casina delle Civette di Villa Torlonia.
N° 566 - Due grandi vecchi

Siamo in piena era Pistoletto: commemorazioni, celebrazioni, mostra al Chiostro del Bramante; certo, quando si arriva a novant’anni…
Con l’occasione emerge dalle profondità del nostro archivio (2016, sette anni fa), bella impolverata, una cronachetta che facemmo in occasione di un evento alle terme di Caracalla intitolato “La Mela Reintegrata di Pistoletto”. Eccola:
In un profondo recesso nei sotterranei delle Terme di Caracalla, che non avremmo mai visto non fosse stato per questa occasione, eccolo, questo masso di marmo statuario di Carrara, non monolitico, come ci avevano fatto credere nella presentazione, ma assemblato. Che va bene lo stesso, intendiamoci, anche se qualunque forma scolpita in un unico blocco fa più effetto. Ancora di più se è molto grande (due metri e mezzo di diametro). Il contrasto fra i mattoni rosicchiati dai millenni, e il purissimo marmo bianco è di gran scena.
La mela è morsa e poi ricucita. Da Eva? “…partendo dal morso che rappresenta il distacco del genere umano dalla natura, la Mela Reintegrata rappresenta l’entrata in una nuova era nella quale mondo artificiale e mondo naturale si ricongiungono producendo un nuovo equilibrio planetario”. Pistoletto dixit.
Spiegazione non necessaria perché la mela è comunque bella per come è e per dove è stata piazzata, e non ha bisogno di aria fritta di supporto.

Sette anni dopo siamo di nuovo nei sotterranei di Caracalla, per un’altra mostra, stavolta con performance, di Yuval Avital.
Urla, lamenti, buio e dolore. L’artista multimediale (pittura, scultura, foto, suono, luce e buio) con “Lessico animale – Mysterion” crea un’opposizione fra la lussuosa quiete dei bagni e dei giardini superiori e la bestiale sofferenza degli schiavi che a centinaia lavoravano qui sotto.

E il giro, di grande emozione, (e diciamo anche a rischio d’inciampo, data l’oscurità) nel labirinto underground termina alla mela di Pistoletto, nel suo profondo recesso, un bel po’ più sporca e polverosa di quando l’avevamo vista sette anni fa.

Adesso usciamo dall’atmosfera claustrofobica dei sotterranei e andiamo a respirare sotto la chioma balsamica del magnifico cedro che riempie il cortile del Museo di Roma in Trastevere.
Qui troviamo il secondo grande vecchio: Armando Trovajoli (all’anagrafe Trovaioli, come specificato varie volte; chissà il perché di quella j aggiunta?) onorato con una mostra intitolata: “Una leggenda in musica”.
Spesso (anche in questo caso) le mostre sulla musica e i musicisti si risolvono in pareti cosparse di vecchie fotografie di colleghi musicisti, di vecchie immagini di registi e vecchie locandine dei loro film, di vecchie partiture e vecchie copertine di dischi; e quella che dovrebbe essere la protagonista, cioè la musica, che non si può mostrare ma bisogna ascoltare, diventa un confuso brusio di fondo in uscita da cuffie, altoparlanti o monitor TV.

In più questa volta abbiamo trovato discutibile il testo dell’invito all’evento diffuso da Zetema: “A dieci anni dalla scomparsa, Roma presenta la prima mostra che ricostruisce la lunga carriera artistica del maestro di musica leggera Armando Trovajoli (Roma 1917 – 2013), pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano ecc. ecc.”
Ma perché una definizione così riduttiva come “maestro di musica leggera”? A guardare questa locandina, ci viene da dire che con quell’orchestrona sinfonica, quel fior di direttore e in più Santa Cecilia in persona sullo sfondo, tanto leggero Trovajoli non doveva essere.
N° 565 - Cento e passa

E’ un periodo che amici, conoscenti, colleghi, tutti più o meno coetanei cominciano ad andarsene. La cosa un po’ ci preoccupa e allora ci siamo messi a consultare qualche statistica.
Nel mondo, di ultracentenari ormai ce ne sono a bizzeffe. Per restringere il campo andiamo a vedere i supercentenari, quelli con più di 110 anni, e loro sono circa mille (in Italia sono 3). Ce lo testimonia il Dottor Robert Young (eh? quando i cognomi ci si mettono anche loro!) capo del Centro di Ricerca Gerontologica di Los Angeles.

A marzo del 2018 ci ha lasciati il nostro campione nazionale di lunga vita (maschio, quindi ancor più meritevole) Gillo Dorfles, critico d’arte, pittore, scrittore e parecchio altro ancora. Essendo nato nel 1910, ne ha avuto di tempo per fare un bel po’ di cose.
Naturalmente, come era successo con la Levi Montalcini, quando muore un ultracentenario, e non uno di quei vecchietti rimbambiti che si vedono ogni tanto nei Tg regionali, ma un Premio Nobel o un intellettuale famoso, ci rispunta questa speranza di immortalità che in fondo è il mito di tutti noi umani.
Tanto forte è il nostro desiderio di arrivarci che da sempre e con grande successo, leggende, studi scientifici di dubbia serietà, ricerche geografiche viranti al new age e adesso anche la nostra grande mamma informatica, la rete, ci forniscono storie di popoli che hanno scoperto la formula della vita infinita.
Abbiamo i centenari del paesello sardo, quelli del villaggio del Caucaso e gli altri del pueblo sulle Ande.

Ma i più in gamba di tutti sono gli Hunza. Gli Hunza vivono in una inaccessibile vallata dell’Himalaya. Secondo i testi in rete, un’abbondante percentuale di questa brava gente campa come minimo un secolo. Alcuni arrivano ai centotrenta, e c’è chi ha raggiunto i centoquarantacinque anni. Per non parlare delle loro indomabili signore, capaci di generare fino a tarda età.
La formula? Naturalmente andare sempre a piedi, mangiare poco e sano, frutta e verdura non trattata, bere acqua dei ghiacciai, niente carne, fumo o alcool. Niente stress. Fare per tutta la vita un lavoro per il quale non serve il cervello: zappare, seminare, raccogliere.
Tranne questa trovata del cervello in pausa che ci vede un po’ scettici, tutto sacrosanto. Forse un tantino noioso, ma di sicuro sano.
Noi che il cervello cerchiamo di farlo andare, magari non sempre con successo, abbiamo un’altra teoria per spiegare tutti questi miracolati. Si sarà notato che, contrariamente a Dorfles che era di Trieste, perciò solidamente documentato, i vecchietti ultrasecolari abitano sempre in angoli sperduti del mondo, su vette irraggiungibili, o in fondo a vallate sconosciute.
Bene, la spiegazione del fenomeno è una sola, secondo noi: l’anagrafe. Nel senso che da quelle parti non ce n’è, e non ce n’è mai stata una.
Come si fa a certificare l’età di un anziano che dichiara di avere centoquarant’anni, quindi è nato, diciamo, nel 1883, in una sperduta valle del Karakorum? Facile inventarsele, le date, anche in buona fede. Il tempo, si sa, se è un concetto relativo per noi, figurarsi per quei signori che ne avranno di sicuro un’idea piuttosto fluida.
Però, siccome del mito abbiamo tutti bisogno, allora ce lo teniamo così: razionale o no.
Per ora. Poi, i futuri progressi della medicina, chissà…
N° 564 - Viaggiare

La primavera sta per arrivare (così ci si illude di solito in questo periodo, proprio quando spesso capitano dei colpi di freddo da distruggerti il terrazzo) e con lei i primi richiami pubblicitari a viaggi e vacanze: tutto facile, economico, veloce e tranquillo. Oggi.
Invece, secoli fa, ecco a cosa andava incontro uno sconsiderato come Montaigne, che aveva deciso di raccontare i suoi viaggi non in territori inesplorati, ma dalla Francia all’Italia, due paesi civili della civile Europa del tempo.
La durata: non ore o giorni, ma mesi, anni. I mezzi: a piedi, a cavallo, oppure, massimo del lusso, una carrozza, ma solo per brevi percorsi perché le strade erano poche e cattive. Il resto, sentieri. E si viaggiava solo di giorno: il mondo era buio, fuori e nelle case.
Oggi ci piacciono le cene a lume di candela che ci isolano in un cerchio magico, tutto intorno la penombra. Ma quello che funziona adesso per i momenti romantici, non era affatto comodo allora per la vita quotidiana delle famiglie. Si andava a dormire al tramonto e ci si alzava all’alba. L’unica luce era quella del camino. I pochi che leggevano col moccolo ci rimettevano gli occhi e la salute (vedi Leopardi).
In viaggio un gentiluomo, come appunto Montaigne, si portava dietro, oltre al proprio cavallo, un mulo per il bagaglio, un cameriere, un mulattiere e due lacchè a piedi. Più, molto spesso, materassi, biancheria e coperte, stoviglie e provviste. Perché le locande erano infami, gli osti imbroglioni, e non c’era da scegliere. Finestre senza vetri, piatti di legno o terracotta sporchi, tavolacci su cui era meglio dormire senza lenzuola, federe o pagliericcio, perché così si evitavano cimici e pulci.

Brevi tappe percorse ogni giorno, per di più calcolate in misure diverse da luogo a luogo: lega di Guascogna, lega di Francia, lega tedesca; miglio italiano (ce ne volevano 5 per farne uno tedesco), spanne, piedi, braccia, cubiti, lance, passi.
Si viaggiava con il contante in borsa, scambiandolo in una girandola di valute locali: scudi, fiorini, soldi, lire, talleri, reali, giuli, zecchini, paoli, grossi, denari, baiocchi. Niente assegni o carte di credito, quindi continui rischi di rapina.
E naturalmente ognuno degli innumerevoli staterelli da attraversare richiedeva passaporti, bollette di alloggio con il numero di signori, servitori e bestie in transito, senza le quali non si trovava da dormire e da mangiare. Qualche volta servivano anche le bollette di sanità, se si arrivava da dove c’era o si credeva che ci fosse qualche pestilenza. E nel bagaglio erano attentamente controllati e al caso sequestrati anche i libri, oggetti rari, costosi e all’epoca molto sospetti, soprattutto di eresia.
Una parola sull’igiene: “Nelle città regnava un puzzo a stento immaginabile per noi moderni. Le strade puzzavano di letame e rifiuti, i cortili interni di urina e feci, le scale di legno marcio e sterco di topi, le cucine di cavolo andato a male e grasso rancido, le camere da letto di lenzuola bisunte e vasi da notte. La gente puzzava di sudore e di vestiti sporchi, le bocche di denti fradici e i corpi di pustole e scabbia; il contadino puzzava come il prete, puzzava tutta la nobiltà. Perfino il re puzzava come un animale e la regina come una vecchia capra, sia d’estate che d’inverno. Insomma, non c’era attività umana che non fosse accompagnata dalla puzza” (Süskind: “Il profumo”).
Ma poi, arrivato a Roma, Montaigne riferisce (con uno stupore che conferma essere i fatti precedentemente citati la normalità) di una cena al palazzo di un cardinale, in cui “tutti si sono lavati le mani prima del pasto!”
Chiudiamo con una sua segnalazione, tanto per sapere come regolarsi, della migliore locanda d’Italia, che è “La Posta” di Piacenza, e la peggiore: “Il Falcone” di Pavia, dove si paga a parte la legna per il camino, la biancheria e il materasso.
Forse, essendo passati diversi secoli, non sono più indicazioni tanto attendibili.
N° 563 - Il primo moto dell'immobile
21 febbraio 2023, tardo pomeriggio, temperatura mite, Roma amabile; ci troviamo a salire i centotrentasei gradini della scalinata di Piazza di Spagna, per poi girare a sinistra e, raggiunta Villa Medici, farcene un’altra sessantina per arrivare alla saletta cinema dove, preceduta dall’esecuzione di un brano per viola del compositore Giacinto Scelsi, ci è stata offerta la proiezione del docufilm “Il primo moto dell’immobile” di Sebastiano D’Ayala sulla vita e la musica dello stesso Scelsi.
Impossibile giudicare la qualità dell’esecuzione della musica di apertura, da parte di Francesca Verga: priva (la musica stessa, non Francesca) di un filo narrativo, di una melodia, perfino di apparenti esigenze di intonazione. Cosa se ne può dire (al di fuori di una eventuale godimento esclusivamente sonoro)? O piace o non piace.
Il filmato, fatto di normali immagini, idee e parole ci è parso bello ed emozionante.
E in più il nome del suo protagonista ci fornisce l’aggancio per andare a recuperare un articoletto, direttamente collegato a lui, da noi pubblicato l’otto giugno del duemilaquindici con il titolo INVIDIA. Eccolo:

Proprio così, l’invidia è stata il primo inconfessabile sentimento che ci è salito in gola quando, giovedì, siamo approdati sulla terrazza della Fondazione Scelsi a Via San Teodoro. E non è difficile capire perché.
Quello che appare nelle foto è solo metà del panorama che si vede da lassù. A sinistra, niente di meno che il tempio di Antonino e Faustina, quello dei Dioscuri, quello di Romolo e la Basilica di Massenzio.

A destra, niente di meno che la chiesa di San Teodoro e la rupe del Palatino, con mura dirute e cipressi.
L’altra metà del panorama è dietro le nostre spalle, e comprende, sempre niente di meno che, il Campidoglio, l’Altare della Patria, e poi il Foro e la colonna di Traiano, l’arco di Settimio Severo, tetti, cupole, campanili, terrazze fiorite.
In più il sole tramonta nel quadrante giusto e così facendo illumina i monumenti di quella speciale luce dorata di Roma.
E con loro illumina il relatore Giancarlo Schiaffini, esimio compositore, trombonista e tubista, da sempre compromesso con la Musica Contemporanea.
Ci aspettava per parlarci di “Improvvisazione per scrivere, scrivere per improvvisare, improvvisare per improvvisare”. L’uomo è un paradossale (come si può dedurre dal titolo dell’incontro), garbato e interessante affabulatore. Ci ha tenuti incatenati alle sedie per due ore, certo con l’aiuto del panorama, ma anche della “sua capacità di snocciolare con semplicità tutta la sua conoscenza ed esperienza”: dichiarazione della direttrice nel presentarlo.
Ci ha offerto un bel ripasso di storia dell’improvvisazione nella musica colta occidentale: dalla pratica sei-settecentesca del basso numerato con il solista al timone di comando, poi decaduta e passata dalla totale libertà di prima all’imbalsamazione di tutto l’ottocento; alla rinascita a inizio novecento nel jazz, al definitivo riemergere, a metà del secolo, nella Contemporanea.
Da buon maestro ci ha ricordato che anche in musica puoi avere grandi idee, ma se non hai la tecnica in mano non farai certo grandi cose. Tanto meno se improvvisi.
E poi, per tornare al nostro argomento di partenza, Schiaffini ha imbracciato un euphonium (una specie di basso tuba in formato ridotto) e ci ha suonato “Maknongan” un brano di Giacinto Scelsi, il padrone di casa da tempo dipartito, a cui la fondazione è dedicata.
Il glorioso tramonto romano, sui colori del quale ci siamo già soffermati, avvolgeva il solista abbracciato al suo lucido strumento. Il quale, e non ce ne voglia l’amico Schiaffini, per sua natura (dello strumento, non di Schiaffini), e specialmente come solista (sempre lo strumento), non può che emettere, sollecitato dal soffio dell’esecutore, sonore, talvolta vellutate, magari anche melodiose pernacchie.
Tutto intorno alla terrazza, nel dorato tramonto, volteggiavano sghignazzando i gabbiani.
E’ chiaro che il verso del gabbiano non ha alcuna connotazione critica. E’ nella sua natura emettere un richiamo che alle nostre orecchie suona come uno sghignazzo. Lui, ne siamo certi, non se ne rende conto. E soprattutto è garantito che non ha alcuna competenza sull’improvvisazione nella musica contemporanea.
A fine esecuzione si è alzato l’atteso ponentino, altra pregiata esclusiva di Roma, e la fondazione Scelsi, oltre al panorama, di cui non ci stancheremmo mai di parlare, che nel frattempo si era tinto di lilla, e poi di ombre azzurre, ci ha fatto omaggio di un calice di ottimo prosecco ben gelato. Non volevamo più andarcene.
N° 562 - Ecomostri vintage

Il Circo Massimo è sempre presente nella vita dei romani, nella normalità e nell’emergenza; la normalità è il traffico, l’emergenza è sempre il traffico, che però si spalma tutto intorno, senza perdere di viscosità, quando ci sono i concertoni: di Capodanno, di Ferragosto, e di altre feste comandate. A questo proposito, l’ultimo pettegolezzo, ormai superato, che ci ha tenuti con il fiato sospeso è stata la trepidazione sulla presenza, il 31 dicembre scorso, della cantante Madame, una poveretta che si era fatta coinvolgere in qualche piccola truffa sulle vaccinazioni anticovid. Una no vax scandalosa, poi perdonata e riammessa sul palcoscenico. Robetta.
Però, che caduta di stile rispetto ai vecchi fasti.
Certo il mattone invecchia meglio del cemento, i millenni danno dignità a qualunque struttura; vedere queste rovine rosseggiare nel sole del pomeriggio al di là della fossa del Circo Massimo riempie gli occhi di chi passa con la maestà della grande architettura imperiale. Eppure quella fila di doppi archi che si stagliano impettiti sulla destra, sono ciò che resta di una vera a propria violenza al paesaggio da parte dell’imperatore Settimio Severo.
Il quale, essendosi fatto venire la voglia di ampliare il complesso dei palazzi di abitazione e rappresentanza imperiali che già coprivano diversi ettari, evidentemente non abbastanza per lui, ed essendo ormai esaurito lo spazio sul colle Palatino, pensò bene di prolungarlo, il colle, e sostituire il terreno mancante con questa pesante quinta di mattoni: una piattaforma sulla quale poi edificò effettivamente la sua nuova ala.
Tutto il marmo, i bronzi e gli altri materiali preziosi se ne sono andati, rapinati dagli straccioni del medio evo, ma anche da illuminati papi del Rinascimento, come Sisto Quinto, che non si fece scrupolo di scippare le ultime colonne rimaste in piedi per riutilizzarle nel Fontanone; bene, certo, ma senza rispetto per la loro storia.
Oggi di quel gran corpo solenne rimane lo scheletro, in origine destinato a starsene nascosto, che ancora ci affascina con la sua molto restaurata imponenza. Ma sempre un ecomostro è.

Il Claudio è di sicuro il più maestoso e bello di tutti gli acquedotti romani. Anche se è lui il secondo ecomostro vintage che vogliamo raccontare. O meglio, non è lui nella sua versione originale: una infinita fila di archi, perfetta opera d’arte ingegneristica messa insieme senza neanche un cucchiaino di calce, con massicci conci di tufo tagliati tanto bene che ancora adesso sembrano saldati.
L’ecomostro nasce quando il capolavoro originale, insieme all’Impero, comincia a vacillare. Passa un secolo, ne passa un altro, gli archi, per quanto ben costruiti, cedono ed ecco apparire i rinforzi in mattoni e malta che, d’accordo, ne rovinano l’estetica ma almeno li tengono in piedi.

Con gli acquedotti ormai senz’acqua, quei macigni tagliati così bene, si sono trasformati in un ghiotto bottino per tutti. E allora inizia lo smantellamento: i rinforzi di mattoni, inutilizzabili, rimangono ma i bei massi di tufo, assolutamente non ottenibili con la misera tecnologia del tempo, cominciano a scomparire.
E così miglia intere di quella maestosa opera svaniscono, ma lasciano un’immagine precisa, come in questo tratto vicino a Tor Fiscale, dove i grandiosi archi di tufo non ci sono più, ma ne è rimasta la traccia, nella forma dei sostegni che non sostengono più niente, residua massa smozzicata di mattoni e calce.

E finalmente ecco la perfetta testimonianza finale della grande rapina: questo rudere ancora in piedi a Porta Furba.
Che è un arco isolato dell’Acquedotto Claudio. Cioè, lo sarebbe, perché l’arco non c’è più. E’ rimasta la sua impronta in negativo: i muri di emergenza in mattoni costruiti a sostegno dei pilastri, che mostrano ancora l’impronta dei famosi tufi così ben tagliati, e la curva, sempre in mattoni, su cui poggiava l’arco a sostegno del condotto dell’acqua.
Praticamente l’ombra di un lavoro di giganti sbriciolato da insolenti implacabili formiche.
Ma l’idea è ancora lì, intatta e maestosa.
N° 561 - C'è spettacolo e spettacolo

Gli spettacoli non sono più quelli di una volta!” Battuta da nonno davanti al televisore. Ci è quasi scappata dopo esserci sorbiti le troppo lunghe serate del Festival di Sanremo.
Tranquilli, non abbiamo intenzione di lanciarci in una approfondita o superficiale analisi musicale o anche solo spettacolare del prodotto presentato quest’anno, in gara e fuori, sul palcoscenico più famoso della nazione.
I cronisti non lesinano in drammaticità quando commentano le battaglie fra concorrenti, le sorprese, i colpi di scena, spesso così bene orchestrati che c’è da sospettare un’accorta regia al losco fine di aumentare la presa sul pubblico.
Effettivamente al Teatro Ariston la tensione si spreca, le carriere sono a rischio, la possibilità di perdere la faccia e i contratti è concreta…

Vediamo, a proposito di situazioni spettacolari un po’ più intense, il programma di un altro teatro, di un genere diverso: più grande, più bello, ancora più famoso, tutto marmi e bronzi; in un tempo lontanissimo da noi, con la certezza per i partecipanti all’evento di perderci non solo la faccia, ma anche la pelle.
Dunque, ecco la locandina di un giorno di festa al Colosseo.
Mattino: combattimenti di animali selvaggi, uno contro l’altro o a gruppi, e battute di caccia in grandiose scenografie. I numeri degli animali sterminati per il divertimento del pubblico sono terrificanti.
Sotto Pompeo, venti elefanti, seicento leoni, quattrocentodieci leopardi, e scimmie a non finire. Con Augusto, tremilacinquecento bestie da preda. Per l’inaugurazione dell’Anfiteatro Flavio, in tutto novemila. Undicimila sotto Traiano. L’estinzione di parecchie specie asiatiche e africane è cominciata negli anfiteatri dell’Impero.
Alla fine della mattinata l’arena trabocca di bestie (e uomini) sbudellati in mezzo a un fetore di sangue e interiora.
Presto tutto deve essere ripulito per la seconda parte del programma: le esecuzioni dei condannati a morte. Che sono spettacolari, per dare l’esempio certamente, ma anche per soddisfare il gusto sadico della folla.
Uomini messi a duellare e ammazzarsi fra loro, crocefissi, cosparsi di pece e bruciati, fatti divorare vivi dalle belve, addirittura costretti a rappresentare i miti della tradizione (quelli senza lieto fine, naturalmente), indossando il costume del personaggio per concludere la recita ammazzati in modi molto pittoreschi e molto graditi al pubblico.
Dopo di che un simpatico personaggio con la maschera di Caronte va in giro per l’arena menando gran colpi di mazza in testa ai caduti per accertarsi che siano morti per davvero, e solo allora un suo compare aggancia i corpi con un uncino e li trascina fuori. Anche loro a centinaia.
A questo punto, di nuovo l’anfiteatro è pieno di sangue, viscere e cervelli.
Ancora una veloce pulizia, perché è ormai pomeriggio e devono cominciare i duelli dei gladiatori, pezzo forte del programma, che vanno avanti fino al tramonto. Inutile continuare la descrizione della carneficina. Basti dire che per gli spettacoli importanti erano parecchie centinaia, se non migliaia le coppie che combattevano; e molto, ma molto pochi quelli che riuscivano a salvare la vita. Altri cadaveri a mucchi nell’arena.
In pratica i bravi cittadini romani andavano allo stadio per vedere ammazzare. Uomini e bestie. Che bella, civilissima festa della morte.
Piccola nota di colore: pare che parecchi imperatori, fra cui Commodo e Settimio Severo si divertissero a combattere (in tuta sicurezza, ovvio) anche loro nell’arena.
Sarebbe un po’ come immaginare, oggi, Amadeus che scende al centro dell’anfiteatro per presentare l’ultimo gladiatore, circondato da un branco di leoni affamati.
N° 560 - Dispetti

La Crypta Balbi è un museo di scultura, storia e artigianato interessantissimo ma poco frequentato, dove è esposto (anche se in maniera piuttosto maldestra) il più bel capitello che ci sia mai caduto sotto gli occhi.
In un recente paginone di Repubblica si annuncia un progetto di restauro milionario e il ripensamento dell’intera struttura, che dovrebbe portare alla creazione di baretti e ristorantini, insieme ad aree di sosta, incontro e riflessione; insomma tutte quelle civili comodità che per ora in questo, come in quasi tutti gli altri musei di Roma, non ci sono; infatti spesso una visita perde la sua piacevolezza e diventa una via crucis.
Chissà perché, hanno deciso di farci un dispetto. Vuoi sederti un attimo a riposare? Mai: in piedi e trottare! Vuoi confortarti con qualcosa di caldo? In castigo: niente cappuccino! La cultura è fatica. Giusto ogni tanto, vicino ai gabinetti, c’è qualche macchinetta a gettone per farsi passare la sete.

Andiamo al Maxxi, un museo più moderno, dove qualche giorno fa abbiamo deciso di punirci con una capatina alla mostra di pittura e scultura di un certo Bob Dylan (che secondo noi farebbe bene a limitarsi all’altra sua attività).
Il bar c’è, e anche bello, ma guai a pensare di ordinare qualcosa di più interessante che un solitario tramezzino. Chissà perché un’attività di ristorazione dentro un museo non è pensata come un esercizio che deve, e può, funzionare bene, fornendo al pubblico merce di buona qualità, guadagnando il giusto come avviene nel resto della città. Anche questo è un dispetto.

E le fioriere per strada? Qualunque tipo di pianta, anche la più tosta, ingiallisce e poi muore in poco tempo. Che strano: evidentemente i giardinieri non si ricordano che, se non innaffiate, le piante fanno questa fine; anche, appunto, le più toste.
Dispetto ai nostri danni, ai danni della città, delle istituzioni (qui siamo al Senato) e anche ai danni loro, dei giardinieri, che le tasse comunque gliele trattengono sullo stipendio; ma, è chiaro, questo pensiero neanche gli passa per la proverbiale anticamera del cervello.

Stanno sistemando gli scavi di Torre Argentina per renderli accessibili in futuro. Cosa ci sarebbe di più divertente (e innocuo per l’ordine pubblico) di potersi affacciare alla balaustra e osservare i lavori dall’alto?
Niente, il Comune ha deciso di farci un altro dispetto: tutto è nascosto da un telone alto un paio di metri, imperforabile perfino con quella chiave puntuta che tutti noi abbiamo attaccata al mazzo che portiamo in tasca.
Ma quale segreto c’è da proteggere? Perché un passante benintenzionato non può guardare? E infatti in questa tristissima immagine (siamo in pieno giorno e in pieno Centro Storico di Roma) quello che potrebbe essere un divertente balcone sull’archeologia e un punto di incontro di cittadini interessati o di turisti curiosi diventa uno spazio sprecato, occupato da un monopattino, due persone distratte sedute di spalle, un netturbino al lavoro e basta.

Sconsolati entriamo in una delle tante chiese di Roma. Sono quasi tutte barocche, alcune barocchissime; e che musica ci arriva dagli altoparlanti nascosti dietro le colonne? Un arcaico canto gregoriano che più medievale non si può, altro che barocco. Dispetto della Curia? del Vaticano? del parroco?
In compenso se ce ne andiamo a zonzo per il Palatino, palcoscenico della memoria di Roma antica, il commento sonoro, che arriva anche qui da fonti nascoste nei prati, è affidato a squisite frivolezze vivaldiane che richiamano le loro brave atmosfere settecentesche, decisamente fuori epoca rispetto ai marmi e alle colonne imperiali. Dispetto.
Forse in realtà non c’è cattiva volontà da parte delle istituzioni o dei privati. Allora ci tocca dar la colpa alle pessime abitudini della città, alla mancanza di cultura; magari, peggio, alla diffusa stupidità di chi decide e sceglie.
N° 559 - La stupida sapienza degli antichi

Nei giorni scorsi si è affacciata sulla stampa la notizia che Steven Spielberg si dichiara pentito di avere provocato con il suo film di grandissimo successo la paura e l’odio degli umani con relativo stupido sterminio di tanti squali innocenti.
Abbiamo cercato di soffocare il sospetto in agguato nel profondo della nostra anima malfidata, che questa non richiesta manifestazione di buonismo sia solo un rigurgito di narcisismo camuffato, tanto per far parlare ancora un po’ di sé (e davvero non ne avrebbe bisogno).
Speriamo di sbagliarci. In ogni caso questa riflessione sui danni provocati alla natura dalla stupidità umana ci ha immerso in una ricerca che ci ha portati a scoprire la potenza della stupidità stessa, soprattutto se antica e contrabbandata per sapienza.

Appunto. Avranno anche una delle più antiche civiltà del mondo, ma su certi argomenti sono proprio degli stupidi creduloni.
Parliamo dei cinesi e delle loro antiche fissazioni mediche e alimentari. Che mettono a rischio un numero esagerato di infelici bestie, molte delle quali hanno ormai una zampa nella fossa.
Sono i poveri rinoceronti, quasi sterminati, il cui corno tritato, secondo i creduloni farebbe passare la febbre e le convulsioni. Ed è afrodisiaco. In realtà si tratta di normale cheratina; come dire che mangiarsi le unghie fa bene alla virilità.
E sono i poveri orsi, tenuti per tutta la vita in gabbie dove non possono neanche alzarsi in piedi, con infilata nella pancia una cannula aperta in permanenza per raccogliere la bile, che gli stupidi anti-chi credono faccia passare la congiuntivite e l’epatite. E in più, alla fine, gli tagliano i piedi, a questi orsi condannati, e se li mangiano in guazzetto contro l’artrite e l’impotenza.
E sono i poveri pescicani, a cui i pescatori tagliano le pinne e poi li ributtano in acqua dove affogano dato che non riescono più a nuotare dritti, perché ai superstiziosi gastronomi creduloni piace la zuppa con cui pensano di curare il cancro e recuperare la virilità.
E sono le povere tigri, le cui ossa tritate servono contro le infiammazioni e l’osteoporosi, e il cui pene seccato, fritto e sgranocchiato i creduloni cretini credono che aumenti la virilità.
E giù con scorpacciate di testicoli di caproni, membri di alce, scroti di non si sa chi altro. In-somma la tradizionale superstizione per cui se mangi qualcosa o qualcuno, incorpori le sue qualità.
Una teoria davvero all’avanguardia, non c’è che dire.
Insomma, la infiacchita virilità dei maschi cinesi è da sempre un pericolo letteralmente mortale per un sacco di animaletti e animaloni che, senza le smanie di questi incivili, se ne starebbero tranquilli per conto loro e non darebbero fastidio a nessuno.

Notizia di qualche tempo fa: un articolo allarmatissimo denuncia che al mondo rimangono solo 30 focene della California. E per colpa di chi? Dei creduloni dall’altra parte del mondo.
Non perché gli piacciano i filetti di focena. No, la faccenda è un po’ più complicata. Ai cinesi piace la vescica natatoria essiccata dei totoaba, pesci che vivono nello stesso mare delle focene, per loro sfortuna (delle focene).
Li pescano con reti di profondità in cui, oltre a loro, anche le focene rimangono impigliate e affogano: mammiferi della famiglia dei delfini, ogni tanto devono risalire per respirare.
E come mai questa vescica natatoria dei totoaba sul mercato clandestino vale più del corno di rinoceronte? Ma naturalmente perché è afrodisiaca.
Per fortuna (sempre delle focene) la California è in USA, dove ogni tanto c’è qualcuno che apre il portafoglio e le imprese umanitarie vanno a buon fine. Hanno organizzato una grande battuta (con la collaborazione di quattro delfini addestrati), per radunare le poverette in via di estinzione e portar-le in una zona sicura. Con tutti i dubbi sulla riuscita del raduno e sulla capacità di questi sfortunati animali di sopravvivere a una prigione, anche se dorata, in cui li rinchiuderanno per salvarli.
Però almeno ci provano. E a quei dementi che ancora sguazzano nel loro medioevo di cucina e medicina mescolate con magia e superstizione, cosa possiamo dire?
Niente, sono più di un miliardo e non di buon carattere: è meglio stare attenti a come si parla.
N° 558 - Sex and the Church - Terza Puntata - La Punizione

Roma, chiesa di S. Maria dell’Anima. Scolpiti nel marmo, intagliati nel legno, modellati in stucco o dipinti: 2 teschi con femori, 7 teschi semplici, 2 teschi alati dall’aria mansueta, 1 scheletro intero, 1 clessidra (tempus fugit).
S. Agostino: 3 teschi semplici, 2 teschi alati con riccioli ribelli, corona d’alloro e aria strafottente.
S. Lorenzo in Damaso, la chiesa più buia di Roma: un immenso scheletro alato che si libra fieramente tutto bianco su un fondo di marmo nerissimo. Impressionante.
S. Maria sopra Minerva: anche qui un bello scheletro che abbraccia l’ovale con il ritratto del caro estinto. Più quattro teschi semplici, tre teschi con femori e ben sei femori incrociati senza teschio.
S. Pietro in Vincoli, due scheletri accompagnatori del caro estinto.
S. Maria Maddalena: uno scheletrone (vero, non di marmo) completo.
E così via in un allegro inventario cattolico apostolico romano.

Vale la pena di soffermarci un po’ a cercare di capire il ruolo che l’arte funeraria, soprattutto quella barocca dà allo scheletro nella messa in scena della sepoltura.
E’ ovviamente il personaggio principale della rappresentazione della vita e della morte. Un attore che, per come viene presentato sulla ribalta e grazie alla sua tradizionale caratterizzazione macabra fa riflettere.
Non ci si era mai pensato prima del barocco, a questo tipo di simbolo, e non ci si è più pensato dopo. Ma durante quel tempo del superfluo, dell’eccesso, del teatrale è stato un grande protagonista.
Dunque, agli scheletri di servizio in chiesa viene affidato l’incarico di stupire, informare, educare i fedeli a non prendere troppo alla leggera la morte e il peccato: c’è sempre in agguato la punizione. Tutto attraverso la fantasia, davvero scalpitante, degli artisti dell’epoca.

Santa Romana Chiesa per un lungo periodo ha tenuto nascosti i suoi scheletri nei cimiteri. Poi non ce l’ha più fatta e a un certo punto (forse per far rabbia a Lutero, ai tempi della Controriforma), ha cominciato a piazzarli sulle tombe in chiesa, sotto gli occhi di tutti, a scopo dimostrativo, ammaestrativo e, diremmo, anche terroristico.
Scheletri, mezzi scheletri e quando non c’era abbastanza spazio, teschi con tutti i ghigni possibili, coi femori incrociati o no, e coi simboli del tempo che passa e della fine che incombe: clessidre, falci e ossute dita puntate.
Per non trascurare le tante macabre reliquie, che, sotto forma di reperti fisiologici più o meno incartapecoriti promettevano la salvezza eterna ai fedeli dell’abbazia e succulenti incassi agli osti e agli albergatori dei dintorni.
Insomma: non dimenticate, o fedeli, che questa bella punizione tocca a tutti.

Per fortuna non sono mai mancati gli artisti che, magari alle spalle del committente si divertivano a infilare in queste rappresentazioni punitive imposte dall’alto qualche trovata irrispettosa, anche blasfema, ma sicuramente sempre teatrale.
E’ un po’ un richiamo alla burla di Bernini ai danni della Chiesa quando riuscì per ben due volte a gabellare un’estasi chiaramente profanissima per qualcosa di mistico e spirituale.
Bravo Gian Lorenzo!
N° 557 - Sex and the Church - Seconda Puntata - La Repressione
La nudità nell’arte è sempre stata un problema di esibizione che andava controllata a seconda dei periodi, dei costumi e soprattutto delle implicazioni religiose.
Lo hanno fatto tutti. E come? Nell’epoca classica, senza scandalo, riducendo, per i nudi maschili, la dimensione dei genitali a ridicole taglie infantili, anche su omoni dalla muscolatura imponente. Per le signore è sempre stato molto più facile: bastava rappresentare la zona incriminata completamente glabra, scansando ogni suggerimento esplicito.
Poi, dopo il momento di pudicizia del medioevo (tutti infagottati in tonache e cappucci), col rinascimento sono tornati i nudi, spesso obbligati a calzare i famosi braghettoni del povero e da allora sempre vituperato pur essendo anche un buon pittore, Daniele da Volterra.

Ma la vera arma letale è stata la foglia di fico, abile trucco di facile installazione sulle vergognose anche se miniaturizzate pudenda delle statue antiche: una toppa di bronzo, magari dorato, e via. Poi, in casi particolarmente scabrosi, entrava in funzione lo scalpello.

Questa faccenda dello scandalo è cominciata appena qualche vecchio prete complessato si è seduto al posto di comando. Il committente delle braghe sul Giudizio fu appunto un vecchio prete, Pio IV, appena uscito dal funesto Concilio di Trento, che dichiarò la visione di quegli organi, anche se resi infantili, un grave pericolo per la sensibilità di ogni buon cattolico.

Anche la bellezza più casta faceva infuriare i talebani cristiani dei primi tempi, quando Roma Imperiale non era ancora svanita. Un profondo dolore ci annienta ogni volta che capitiamo nella sala di Palazzo Altemps dove è esposta questa meravigliosa Lucilla, figlia di Marco Aurelio ma soprattutto donna e bella, quindi veicolo di Satana, quindi debitamente sfregiata a colpi di mazza da qualche fanatico, di quelli che, appena diventata abbastanza forte la loro mortificante religione, si erano scatenati a distruggere tutto ciò che ricordava il passato pagano, e soprattutto rappresentava il bello.

L’intervento sugli omaccioni di Michelangelo, benché sottodotati, poteva anche avere un senso.
Perplessi, invece, lo siamo quando a essere colpiti sono i pubi innocenti di putti e angioletti (sempre maschi; putte o angiolette non erano previste?), la cui attrezzatura tutto è tranne che stimolatrice di turbe sessuali.

Un perfetto esempio e una campionatura completa di questo accanimento si trova a San Pietro in Montorio.

Le cappelle principali ai lati dell’abside sono precedute da magnifiche balaustre di marmo, ornate ognuna da due coppie di putti di squisita fattura, devastati da ambigue ferite che risalgono non sappiamo bene a quando, ma che hanno lasciato immonde cicatrici.

Otto innocentissimi angioletti. Poveri bambini: chi violato da osceni impacchi di gesso, chi con macchie di ruggine colate da perizomi di metallo, chi con tamponature scure, chi addirittura con i peccaminosi pisellini raschiati via e ridotti a foruncoli arrossati.
Una nudità che più innocente di così non poteva essere, ma veleno per qualche malpensante.
N° 556 - Sex and the Church - Prima Puntata - La Tentazione

Si è inaugurata qualche giorno fa alla Galleria d’Arte Moderna di Roma una mostra su Domenico Morelli, pittore napoletano dell’800, il cui capolavoro di grande formato “Le tentazioni di S. Antonio” riempiva una parete.
E’ un bellissimo quadro, dicono gli storici dell’arte; e noi aggiungiamo che è anche molto chiaramente indicativo di quello che la Chiesa intende quando parla di tentazioni.
Non oro, non potere, ma sesso. Sex and the Church; basta guardare la fanciulla discinta e popputa che fa capolino sotto la stuoia del povero Santo, accovacciato lì accanto, spaventatissimo. E quell’altra, sullo sfondo, furbetta in attesa di vedere come va a finire…

Certe poppe sono peccaminose, altre no. Ci riferiamo naturalmente a quelle che servono per allattare; possibilmente Gesù Bambino, ma anche altri santi neonati, perfino neonati non santi, la cui presenza neutralizza quella del maligno, che su ogni centimetro di pelle nuda, specialmente nei dintorni di zone sensibili, è capace di imbastire una deriva malandrina.
Quindi a questo proposito, visto che non si possono ignorare, parliamo di quelle della Madonna, parliamo del lattante e, già che ci siamo, di anatomia.
Questa non è un’analisi artistica, è solo il resoconto dello stupore che ci prende all’osservare le Maternità della pittura prerinascimentale. Rappresentazioni in cui l’anatomia, addirittura la semplice osservazione dal vero, decollano verso orizzonti sconosciuti.
Sì perché i Bambinelli (spesso dipinti come adolescenti ben oltre l’età dell’allattamento, ma sempre miniaturizzati alla taglia di un poppante), stanno attaccati a sacre mammelle che, fra drappi e manti, fanno capolino da una spalla, da un’ascella, da una clavicola, da punti del corpo dove nella realtà c’è tutt’altro.
Forse questa indifferenza verso la correttezza anatomica serviva a rendere irreale, e quindi non pericolosa per il fedele uomo la visione di una ghiandola che, papi o non papi, manteneva ben saldo il suo richiamo più terreno che spirituale.
Tanto è vero che, qualche anno più tardi, questo concetto che all’epoca non era ancora chiaro né agli artisti né ai loro ecclesiastici committenti, fu codificato dal Concilio di Trento, lo stesso che poi decise di far mettere i mutandoni alle figure di Michelangelo nel Giudizio Universale.

E da allora, nell’arte sacra, addio ai richiami sessuali; se non quelli astutamente contrabbandati da qualche artista malizioso come estasi mistica.
A chiarire l’argomento bastano le espressioni di due famosissime primedonne della santità, Teresa d’Avila e la Beata Albertoni, che ci fanno l’occhiolino (di marmo) da quattro secoli, forse per farci capire che per una volta quel furbacchione di Bernini gliel’ha fatta a imbrogliare Santa Madre Chiesa.

L’ultima parola (non nostra) la lasciamo al diario di Santa Teresa. “In un'estasi mi apparve un angelo tangibile nella sua costituzione carnale et era bellissimo; io vedevo nella mano di questo angelo un dardo lungo; esso era d'oro e portava all'estremità una punta di fuoco. L'angelo mi penetrò con il dardo fino alle viscere e quando lo ritirò mi lasciò tutta bruciata d’amore per Dio…”
N° 555 - Anno Domini 2023

Nella speranza di non finire così,
vi manda tanti auguri di un ottimo 2023
IL CAVALIER SERPENTE
N° 553 - Prodigio barocco al Gesù
Siamo nel periodo in cui gli editori, nella speranza sempre più fioca di vendere qualche copia, promuovono le loro pubblicazioni.
Ci hanno invitati a due di questi eventi; il primo al Centro Culturale Francese per il battesimo di “Sorprendente Roma”, una guida all’arte nelle chiese con forte accento sul significato religioso delle opere, di Anne Cecile Brame, francese, della Comunità della Fraterna Domus, a cui (al testo, non all’autrice) è mancata prima della stampa una certa attenzione che avrebbe rilevato ed eliminato i francesismi che lo affliggono (fra gli altri quello, molto comune, di appioppare il genere maschile a una parola che in italiano, invece, è femminile, come “arte”). Lo stesso problema che appesta i pannelli illustrativi di Caravaggio nella chiesa lì accanto.
Per l’altra presentazione siamo andati sul profano, scendendo nei sotterranei dello stadio di Domiziano (Piazza Navona) a conoscere “Roma, bella da vedere, magica da raccontare”, un itinerario laico nella storia, nel quotidiano, nella poesia, nelle canzoni e nelle pentole della cucina casereccia romana, anzi romanesca.
Belle foto, begli aneddoti, bei suggerimenti.
Bene, né questi due nuovi nati, specialmente il primo che avrebbe dovuto, né tante altre guide che abbiamo letto accennano a quello che ora vi andiamo a raccontare.

Il Gesù è la chiesa madre dei gesuiti qui a Roma e il prodigio barocco è qualcosa che accade tutti i giorni alle 17.30 nella cappella di Sant’Ignazio di Loyola.
Mettiamo che un pomeriggio d’inverno un viaggiatore, forse diretto a prendere un bus per la stazione, decida di entrare in chiesa, spinto da un impulso mistico, o anche dal semplice desiderio di riposarsi un attimo.
Si trova, smarrito, in un antro buio (il tramonto è già lontano). Naturalmente si avvia all’altar maggiore fiocamente illuminato. Si siede in uno dei primi banchi.

Sono le cinque e mezzo; dal transetto sinistro parte una musica, qualcosa di barocco per coro e orchestra. Il nostro viaggiatore si gira in quella direzione; c’è un altare su cui si intravvede a stento, nella penombra, un quadrone seicentesco con S. Ignazio assunto in cielo. A un certo punto il quadro si illumina e con lui tutta la sontuosa macchina barocca che lo incornicia (alabastro, marmi, onice, ametista, cristallo, bronzo). Entrano trombe e tromboni che annunciano il trionfo, ma ancora non sappiamo cosa succederà.

Invece le luci si abbassano e così la musica. Tornati al buio dell’inizio, intuiamo sull’altare un fatto meccanico che fatichiamo a identificare, ma qualcosa si muove. Bisogna strizzare gli occhi (e seguire lo sprofondare graduale di un elemento vistoso del quadro: per esempio lo stendardo rosso triangolare che fa da sfondo alla figura di S. Ignazio) e ci si accorge che la pala è diventata una saracinesca che piano piano cala nel pavimento.
Questa discesa è quasi impercettibile; il trucco funziona proprio per questo; un esempio della grande sapienza scenica barocca (bisogna pensare che a suo tempo lo spettacolo era senza elettricità, senza riflettori, senza musica registrata. Giusto un paio di chierici appesi a due carrucole e qualche moccolo acceso; eppure con le sole candele e un probabile coretto di confratelli doveva funzionare molto bene anche allora).

Dopo questo intervallo di penombra, carico di suspense, le fanfare e i cori raddoppiano all’improvviso, si accendono tutti i fari, e dietro la paratia sprofondata appare il prodigio: una nicchia scintillante di gemme e lapislazzuli in cui domina in trionfo una prodigiosa, è il caso di dirlo, statua di S. Ignazio, tutta d’argento.
Per la precisione: la statua era d’argento massiccio fino all’arrivo dei francesi di Napoleone, fine ‘700. Poi deve essere successo qualcosa perché da allora non è più risultata d’argento, ma di stucco (argentato).

Insieme alla nicchia s’illumina tutta la chiesa che, da buia, diventa anch’essa splendente di ori e stucchi. Musica a palla con il sostegno del naturale eco delle volte (sempre cori e orchestrona barocca) e il miracolo si compie in gloria.
Siamo convinti che dopo un’emozione del genere, il viaggiatore che per la meraviglia si sia trattenuto più del previsto, sarà anche contento di aver perso il treno.
N° 552 - Ambientalisti

Al nostro tavolino del bar, tutte le mattine c’è “La Repubblica”, che ci tiene compagnia insieme al cappuccino e ci dà le informazioni politiche e culturali del giorno.
Con alcune impennate che il cappuccino ce lo fanno gustare meglio.
Così oggi 9 dicembre, che bei titoli! Finalmente qualcuno, non uno qualsiasi: il presidente del FAI, che manifesta a chiare e grandi lettere una posizione ragionevole, non faziosa, non catastrofista, semplicemente ragionevole.
Sono anni che ripetiamo, certo con minore autorevolezza, ma con lo stesso buon senso, le stesse cose.
Ed essendoci sentiti negli stessi anni rimproverare dai parrucconi di nostra conoscenza per le nostre idee ragionevolmente moderne, abbiamo deciso di fare (e farvi fare) un bel salto all’indietro, cercando di ricostruire, con un solo esempio, ma di peso, quello che poteva essere allora lo stesso tipo di atmosfera vecchieggiante.
Da sempre ci affascinano i quadri della paesaggistica romantica del sette-ottocento, e poi le fotografie seppia del primo novecento con le immagini della campagna romana, e sullo sfondo quella serie di archi barbuti di felci, estesi fino all’orizzonte.
Cosa ci può essere di più profondamente intrecciato con la natura di questi ruderi, di più gratificante per gli occhi e per l’immaginazione, di più evocativo della grandezza imperiale, e soprattutto di più classicamente radicato nella tradizione confermata dal tempo?
Eppure tutto questo è stato modernissimo. Venti secoli fa.

Eccoci, appunto venti secoli fa, di fronte a queste romantiche rovine, oggi; in realtà fastidiosi manufatti industriali, allora.
Li sentiamo protestare, esattamente come adesso, gli ambientalisti dell’epoca, contro quelle moderne barriere, ingombranti e volgari, che gli costipavano il panorama e facevano calare il valore degli iugeri quadrati; e i fattori imprecare contro quegli archi che gli spaventavano i maiali e facevano seccare il latte alle capre, che impedivano la vista dei colli vicini e con la loro altezza bloccavano il ponentino rinfrescante del pomeriggio.
Naturalmente senza un pensiero sulla moderna utilità dell’acqua per tutti, che dava alla città le terme, le fontane, l’igiene e il benessere.
Si tratta in fondo di una considerazione banale, ma non per questo meno vera: quello che è bello (e in questo caso bello è sempre uguale a funzionale) se non è distrutto da qualche fanatico sopravvive nei secoli e rimane bello.

Per caso questa turbina eolica è meno elegante di un arco dell’acquedotto Claudio?
N° 551 - S. Ivo e i muraglioni

Eccola, sulla sinistra, la meravigliosa chiocciola di S. Ivo alla Sapienza: sublime torta bianco panna di Borromini, e laggiù a destra, sul tetto, un incongruo casotto arancione alla Carrà.
E’ mezzogiorno del 27 novembre; anche oggi tutto si aggiusta come sempre, amalgamato meravigliosamente dall’azzurro di questo incredibile cielo di Roma.
Saliamo lo scalone dell’Archivio di Stato; avanti lungo il portico al primo piano, e finalmente, tanto per cambiare, un altro miracolo barocco: la Biblioteca Alessandrina, dove si inaugura la mostra “La sistemazione del Tevere urbano” che documenta la necessità, l’idea e la faticosa realizzazione dei muraglioni sul fiume.

Sono brutti, lo diciamo tutti, ma se ci trovassimo, come in passato, con i pantaloni a mollo nell’acqua due o tre volte ogni inverno, crediamo che il giudizio estetico passerebbe in secondo, se non ultimo piano di fronte alla situazione pratica.
E più di una volta, durante le grandi alluvioni non si trattò solo di salvare i pantaloni, ma anche la pelle, e furono in molti a rimettercela. Nella peggiore di tutte, quella del 1598, 20 metri sopra il livello medio, “una poderosa corrente traversò la Via Flaminia entrando in Roma per la Porta del Popolo. Al sopraggiungere delle acque che correvano difilate per la Via del Corso e quella di Ripetta, l’evento prese la proporzione di un disastro”. Decine di case abbattute, centinaia di persone affogate. Con l’ultima, nel 1870: l’acqua quasi alla stessa altezza, ma meno morti e danni, la giunta di Roma appena liberata, rischiò nuovamente di infradiciarsi i pantaloni e all’unisono decretò la costruzione dei famosi, brutti muraglioni.
Non staremo a raccontare quello che si può vedere su vecchi dagherrotipi e mappe nella mostra: bisogna andarci, anche perché siamo sicuri che la maggior parte dei romani a cui questa iniziativa si rivolge, non hanno la più vaga idea di chi abbia promosso il progetto (Garibaldi), di quando siano cominciati i lavori (dopo il 1870), di quanto siano durati (una quarantina d’anni), di quanto siano costati (uno sproposito), degli incidenti (crollo di una parte dell’opera non finita) e di come siano stati utili nell’ultimo secolo e mezzo per tenerci i già citati pantaloni all’asciutto.
Quindi, la mostra è davvero utile per soddisfare molte curiosità; ma attenzione!

Mica è così facile.
Perché chiunque ha curato l’allestimento non ha considerato un elemento, appunto, elementare.
I pannelli, dove tutto è spiegato piuttosto bene, talvolta in modo perfino avventuroso e appassionante, bisogna poterli leggere.
Ma, e si vede nella patetica foto, i visitatori sono costretti, per compiere questa fondamentale, semplice operazione, a illuminare con il telefonino le scritte. Le quali, malgrado la luce del sole che entra a fiotti dalle finestre del salone, sono immerse in un buio profondo.
Una sistemazione diversa, un faretto, un qualunque altro trucco da elettricista sarebbero stati un pensierino gentile per noi ospiti in visita.
Va bene, facciamo finta di niente; se ne accorgeranno, speriamo, e dopo l’inaugurazione troveranno un rimedio.
In fondo noi romani siamo, sì, cialtroni per definizione, ma cialtroni d’ingegno e buon cuore.
N° 550 - Clavicembali e gabbiani

Fra i ruderi del palazzo imperiale di Elagabalo, poi passato a Costantino e a sua madre Elena, nei secoli è stata fondata, costruita, risistemata e ancora ricostruita la basilica di Santa Croce in Gerusalemme, una delle chiese di Roma peggio riuscite.
E’ un edificio che, malgrado la storia che lo accompagna, la dovizia di maestose colonne che lo sorreggono, l’abbondanza di splendidi pavimenti cosmateschi, riesce a essere di una freddezza e di una cupezza tale che l’unico desiderio quando ci si entra è scappar via il più presto possibile. Guardare per credere.
Per fortuna, proprio lì di fianco c’è un posto molto più allegro: il Museo degli strumenti musicali.
Che, come abbiamo scoperto il pomeriggio del 18 novembre, è anche un laboratorio di restauro di clavicembali, due dei quali erano parcheggiati sul palcoscenico dell’auditorium del museo, pronti a essere cavalcati per un concerto di collaudo.

Prima si è affacciato il cembalaro che li ha guariti, e ce ne ha raccontato il meccanismo: niente martelletti come nel pianoforte, ma una penna tagliata a linguetta, fissata al salterello, che a ogni pressione di tasto salta su (destino di un nome!) e pizzica la corda.
Penna di gabbiano, caduta spontaneamente e non strappata all’uccello, ha precisato. Grazie: immaginiamo il mite cembalaro alle prese con uno degli enormi e ferocissimi gabbiani che infestano il cielo di Roma.
Lo avremmo perso: lui, non il gabbiano.
Ottima l’esecuzione di Rossella Policardo alla tastiera dei due strumenti resuscitati ed Enrico Onofri alle prese con un violino dalla voce formidabile.
Programma di autori semisconosciuti fine 500 e pieno ‘600: Virgiliani, Fontana, Rognoni, Uccellini e altri, che, ancora una volta, con nostro sempre rinnovato stupore ci hanno messi di fronte all’inquietante constatazione di quanto la musica fosse arretrata all’epoca.
Uno scarno balbettio quasi infantile di fronte al discorso pienamente maturo di tutte le altre forme d’arte contemporanee: architettura, pittura, scultura, letteratura. Dante, Raffaello, Michelangelo, Bernini…

A questo punto vogliamo divertirci un po’, sempre con rispetto, naturalmente.
Il maestro Onofri, imbraccia il violino, comincia a suonare (benissimo, lo ripetiamo) e parte la vaporiera. All’attacco di un tema, in una pausa, nel pieno di un’arcata: una serie di respiri, soffi e sbuffi che neanche il lupo cattivo con i tre porcellini.
Ci torna in mente un’esperienza di anni fa (citiamo una nostra cronaca dell’epoca). “Institutum Romanum Finlandiae, ottima esecuzione di alcune suite di Bach per violoncello. Allo strumento Vito Paternoster. O meglio: allo strumento e all’apparato otorinolaringoiatrico.
Dal bel violoncello antico escono suoni rotondi, corposi, appassionati, ma contemporaneamente in gola al solista funziona a tutta pressione una locomotiva: rantoli, ansimi, profondi sospiri.
In camerino ne abbiamo parlato e Paternoster ci ha convinti che questa intensa partecipazione respiratoria non solo non turba l’ascolto, ma aggiunge tensione e patos”.
Verissimo. Anche l’aria compressa di Onofri a contorno della splendida, potente sonorità del suo strumento non ci ha creato il minimo fastidio, anzi, ci ha coinvolti di più.
D’altra parte basta ascoltare qualche disco di Casals, di Rubinstein, perfino di Errol Garner: è tutto un borbottare, un canticchiare, un ansimare, che di certo non toglie niente alla qualità della registrazione.
A proposito di attività extramusicali durante l’esecuzione, mai guardato la faccia di un chitarrista mentre suona? L’attenzione del cervello è tutta sulle dita, e così i muscoli dell’espressione, non più in controllo, tirano, spingono, ammiccano, sorridono, strabuzzano, spalancano e trascinano il volto in ridicole e talvolta preoccupanti smorfie.
Per non parlare delle boccacce dei cantanti lirici spalancate nei do di petto, sottolineate da un trucco esagerato pensato per le distanze teatrali e impietosamente esposto dai primi piani tv. Grotteschi mascheroni.
Ma sono inezie: quello che conta, naturalmente, è la musica che quando è buona sopporta qualunque interferenza.
N° 549 - L'accumulatore seriale

Seconda metà dell’ottocento. Un giovane di belle speranze, si chiama Gennaro Evangelista Gorga, debutta nel mondo della musica come accordatore di pianoforti. Ma è inquieto: non gli basta. Scopre di avere una voce, si mette a studiare e diventa così bravo da essere chiamato da Puccini nel 1896 al Regio di Torino per il ruolo di Rodolfo alla prima mondiale de “La Boheme”, diretta nientedimeno che da Toscanini.
Successo trionfale: da quella sera è il tenore alla moda.
Però il ragazzo, che ormai ha preso il nome d’arte Evan Gorga, non solo è inquieto, ma anche un po’ squilibrato, tanto è vero che, solo tre anni dopo, cede al demone che evidentemente lo possedeva da sempre, molla la musica e diventa collezionista, anzi accumulatore: di antichità, per fortuna, e non di spazzatura, come vediamo in certe morbose trasmissioni televisive, ma comunque a un livello di assoluto squilibrio, prima mentale, e poi, inevitabilmente finanziario.
Quando muore nel 1957 a più di novant’anni, braccato dai creditori, ha raccolto in tutto centocinquantamila pezzi antichi che tiene stipati in dieci appartamenti in Via Cola di Rienzo, di cui naturalmente non riesce a pagare l’affitto.
Mania ossessiva compulsiva. Con questa diagnosi il collezionista viene riconosciuto malato inguaribile (qualunque collezionista, mica solo lui). L’ultimo pezzo per completare la raccolta non esiste, così la caccia non finisce mai.

Perché parliamo di Evan Gorga? Perché il museo di scultura antica a Palazzo Altemps gli dedica una bella mostra permanente.
Apriamo una parentesi. Secondo noi tutti i musei dovrebbe essere come l’Altemps. Un magnifico palazzo rinascimentale, belle sale con pochi pezzi strepitosi e la certezza per il visitatore di arrivare in fondo al suo festino artistico senza l’indigestione che inevitabilmente ti paralizza, per esempio ai Musei Vaticani, dove, già alla terza sala gremita di capolavori, arriva il coccolone da bulimia e cominci a non capire più niente.

In mostra ci sono milleottocento pezzi antichi: una minima percentuale del totale raccolto dal povero Gorga, che però esprimono con assoluta precisione il quadro clinico della sua malattia: bronzetti, marmetti, intonaci, stucchi, ex voto, avori, giocattoli, ceramica, terracotta, piastrelle, lucerne, specchi, armi, vetri, monete; si rimane senza fiato.
Immaginare l’oppressione in quegli appartamenti di Via Cola di Rienzo nei quali, nascondendosi dagli strozzini che gli davano la caccia, sicuramente il nostro squilibrato passava giorni e notti di beatitudine e di angoscia.
Anche noi, bisogna ammetterlo, abbiamo avuto delle fitte di piacere guardandoli, perché gli oggetti accumulati dalla buonanima e astutamente ammonticchiati nelle vetrine dal curatore, così numerosi e stretti per trasmettere l’affanno maniacale del collezionista, presi singolarmente sono tutti molto interessanti.
A noi, allora, il bello; la patologia la lasciamo a Gorga.

N° 548 - Cactus da collezione

Leggiamo sul Venerdì di Repubblica di questa settimana un gustoso articoletto sull’imminente sfratto di uno dei tanti personaggi che ormai fanno parte di quel panorama artigianale-contadino che sopravvive sempre più stentatamente intorno ai confini della città, mentre questa si dilata come una vescica, tutto soffocando.
Si tratta di Gaetano Palisano, un vivaista un po’ sui generis che bivacca da anni su un terreno forse del comune, forse di un privato, forse comprato da lui stesso anni fa con un contratto forse non valido; insomma un precario suburbano.
Si sta progettando una sistemazione del Parco della Caffarella, e quando cominceranno i lavori (conoscendo i tempi del Comune, crediamo che possano stare tranquilli lui e i suoi eredi) se ne dovrà andare.
Quattro anni fa eravamo passati a trovarlo e avevamo buttato giù le nostre impressioni. Eccole. (Dall’articolo del Venerdì apprendiamo che oggi ha anche un allevamento di tartarughine, specie protetta e per legge intoccabile, soprattutto durante il letargo. Sembra una di quelle storie neorealiste, con la contrabbandiera, Sophia Loren, sempre incinta, che i carabinieri non possono arrestare).

23/4/2018. Pochi passi sull’Appia Antica, fuori Porta San Sebastiano e poi, quasi al bivio con l’Appia Pignatelli, davanti alla Cartiera Latina, ci fermiamo a uno sciccosissimo vivaio.
Ma è una finta perché lì non ci entriamo per niente; proprio a sinistra dello sciccosissimo ingresso dello sciccosissimo vivaio, segnalato da uno sgangherato cartello “Piante grasse da collezione”, parte un viottolo altrettanto sgangherato che dopo qualche curva ci porta a un cancello. Ci infiliamo in una jungla di erbacce alte due metri, capannoni di bandone e serre coperte da stracci, e ci viene incontro, scortato da un bastardino, Gaetano dei Cactus, piccolo, con la scoppola e uno stuzzicadenti che gli sta piantato in bocca come se proprio lì fosse germogliato dalle radici dei denti caduti.
Vendere, sì, le venderebbe anche, su nostra insistenza, le sue amate creature, ma in realtà gl’interessa di più parlare delle succulente che coltiva, dei danni dell’ultima gelata, di un cereus che gli è cresciuto tanto da costringerlo a fare un buco nel tetto della serra, come se quel piccolo squarcio rovinasse la linea purissima della costruzione, sgangherata come il resto.
Ci accompagna in giro per la sua proprietà (?), affascinante guazzabuglio di materiali vari (orgoglio di raccoglitore), vegetazione di ogni genere (orgoglio di coltivatore), perfino una vasca con carpe ornamentali, la più grossa e vecchia delle quali sale a galla per rubargli dalla mano dei granelli di cibo (orgoglio di allevatore).
Insomma, abbiamo di fronte un raro esemplare sulla cui peculiarità non ci sono dubbi. Come non ce ne sono sul fatto che potrebbe avere la stessa veneranda età dei basoli dell’Appia. Merita una visita archeobotanica.

11/11/2022. E noi l’abbiamo rifatta questa visita, non solo archeobotanica, ma anche maliziosa. Perché conosciamo la nostra città incapace di entusiasmi, di slanci, di iniziative o di ribellioni: una palude spesso infetta, comunque sempre inerte, come d’altra parte si conviene a una palude.
E abbiamo voluto metterla alla prova alle 16 di oggi, venerdì, giorno di uscita del supplemento di Repubblica in cui si racconta la storia di Gaetano.
Siamo riandati sull’Appia Antica, davanti alla Cartiera Latina, un po’ prima del bivio con l’Appia Pignatelli.
Come temevamo, ma avremmo sperato di no, il cancello d’ingresso al vivaio di Gaetano era sbarrato e nel parcheggio lì davanti, neanche una macchina ferma, eppure era l’orario giusto.
Sfruttare (in fondo è un esercizio commerciale) la popolarità, anche se effimera, dell’articolo su un giornale che arriva a un buon numero di romani per guadagnare due bajocchi? Ma stiamo scherzando? Tocca lavorare!
E i romani che ci aspettavamo di vedere in massa sul posto, se non altro per curiosità? Troppa fatica arrivare fino all’Appia. Magari domani, o domenica, o un altro giorno…
I nostri fedeli lettori, se fedeli lo sono davvero, avranno ormai capito che la conclusione dell’escursione archeobotanica non poteva che essere il baretto verso Cecilia Metella con le sue irresistibile pizzette a mozzarella, alici e fiori di zucca annaffiate, come si scrive nei romanzi di avventura, da un boccale di birra freschissima. Prosit!
N° 547 - Suorine e chitarrine

Una mattina settembrina, anzi potremmo benissimo essere nel pieno dell’ottobrata romana; diciamola tutta: è il 3 novembre e fa caldo come in estate, ci troviamo a Palazzo Cesi per la presentazione del Ventunesimo Festival di Musica e Arte Sacra.
Svolazzi di tonache e baci di anelli cardinalizi. Gran discorsi in italiano ma con sonorità internazionali.
C’è il tedesco, fondatore dell’iniziativa, con la parlata sobria e un accento ben bene spigoloso, macchiettato di tanto in tanto dalla scomparsa di intere parole italiane dovuta a vuoti di memoria, Dott. Hans Albert Courtial.
C’è lo spagnolo, Monsignor Pablo Colino, notissimo e prolifico compositore e didatta di musica, orgogliosamente sul margine dei novant’anni, che invece scatena un brillantissimo e molto colorito fiume di parole piene di accenti corretti o personalizzati, ma sempre molto fluidi e naturalmente musicali.
E c’è anche la pittrice russa Natalia Tsarkova, fotografata mentre coglie l’occasione per presentare con un accento questa volta di quasi comica esagerazione, roba da barzelletta, un suo grande “Retratuo di Santo Padrie Benedetuo Diecimo Sestuo”.
Il Festival consiste, oltre alla realizzazione di quadri e sculture, in una serie di sontuosi concerti di musiche di Brahms, Bruckner, Bach e un contemporaneo, Andrea Mannucci, nella terza settimana di novembre, a S. Paolo, S. Giovanni e S. Maria Maggiore, le Basiliche Papali.
Da quanto abbiamo capito il sostegno finanziario viene da sponsor privati; il Vaticano non ci metterà il denaro, ma ci mette i palcoscenici, e bisogna riconoscere che più belli di così non se ne possono trovare.
Diamo un’occhiatina di passaggio a un’altra iniziativa musicale che usufruisce nello stesso modo degli spazi ecclesiastici, il Roma Festival Barocco di Michele Gasbarro che tiene tutti i suoi concerti, molto spesso con interessantissimi recuperi di capolavori dimenticati o ritenuti perduti del cinque e seicento in tutte le più belle chiese barocche del centro di Roma.
Anche altre simili iniziative sono ospitate nelle chiese qui a Roma: Il Festival dell’Architasto, Le Cinque Perle del Barocco; e abbiamo addirittura, diamante di comportamento virtuoso, Santa Maria dell’Anima, una chiesa cattolica che serve la comunità tedesca di Roma e impiega addirittura, miracolo, un kapellmeister: l’amico Flavio Colusso.
Ecco, qui per esempio (sarà perché è tedesca?), la musica è parte importante e soprattutto quotidiana della liturgia e così il fedele si gode, possiamo dirlo, la messa insieme a una bella esecuzione di Palestrina, Gabrielli o Bach.

A questo punto lasciamo perdere per un momento festivalini o festivaloni, che sono comunque degli eventi eccezionali, e limitiamoci al quotidiano, alla parrocchia, alla messa domenicale, ai matrimoni, ai funerali, alle cresime, alle prime comunioni.
A eseguire il repertorio immenso di musica sacra composto nei secoli, ogni parrocchia potrebbe festeggiare con un capolavoro tutti i giorni, feriali compresi, per una cinquantina d’anni. Mettendo al lavoro orchestre, cori, organisti, tenori, baritoni, soprani e contralti.
E invece cosa ci tocca sentire normalmente alle messe? Un paio di suorine con le chitarrine e, quando va bene, tre chierichetti coi bonghetti che eseguono insulse canzoncine con testi da asilo infantile.
Questo vero e proprio miracolo dello spreco non riusciamo a spiegarcelo. Spreco di un capitale di musicisti e di musica, e anche di occasioni (per la Chiesa) per attirare il popolo alle funzioni, che in fondo, come accennavamo prima, sono spettacoli, e quindi devono piacere agli spettatori, cioè ai fedeli.
Chissà perché questa realtà è invisibile per chi dovrebbe avere occhi. E’ come quei barboni che hanno i milioni nel pagliericcio e poi vivono sotto i ponti. Forse è solo un fenomeno cattolico apostolico romano, perché ci dicono che le chiese protestanti mantengono in vita l’abitudine.
Ma qui da noi la mancanza di tradizione, di attenzione, di preparazione ci ha portati al punto che in chiesa non si trova più un organista decente, e quando serve bisogna chiamare il collega musico.
N° 546 - Il guastafeste
Quante volte, a proposito della nostra città, abbiamo raccontato un evento di scarsa qualità, di eccessiva presunzione, di pochissimo interesse, per concludere che il basso livello dell’iniziativa era comunque riscattato dall’eccezionalità del luogo, dal pregio estetico dell’edificio, dall’unicità del panorama: insomma, collocarla a Roma salvava comunque la baracca.
Qui vogliamo raccontare il contrario: quando l’evento, magari piccolo ma interessante, che quindi non avrebbe nessun bisogno di essere soccorso, viene inquinato dalla bellezza stessa di Roma, che in questo caso fa da guastafeste.

Palazzo Altemps: “Virginia Woolf e Bloomsbury”. Una snobbissima mostra su quello che lo snobbissimo gruppo di quegli intellettuali, artisti, omosessuali, ma soprattutto gente snob scrivevano, dipingevano, scolpivano, creavano per confrontarsi fra di loro ma anche per vendere agli altri.
Alle pareti notevoli ritratti dei membri del gruppo, nelle bacheche prime edizioni di romanzi e poesie, in fondo una sala piena dei prodotti artigianali del loro Omega Workshop: piatti, teiere, zuppiere. Tutto molto elegante, raffinato e snob.
E proprio in questa sala, eccolo il primo guastafeste: un nudo romano, mutilato ma talmente potente da trasformare il resto in cianfrusaglia senza nerbo.

Palazzo di San Silvestro: “Poste Italiane, la storia”. Vecchie bici da postino, vecchi telegrafi a contrappeso, bollatrici, posta militare, cartoline e libretti di risparmio.
C’è anche un reparto per far giocare i bambini; insomma un allestimento tra il familiare e il didattico, ma comunque curioso e nostalgico.
Colpo di scena! Distrattamente, attraverso uno dei tanti finestroni, buttiamo l’occhio sul bellissimo cortile del Palazzo delle Poste e questo stesso occhio viene attratto irrimediabilmente da un maestosissimo ciuffo di banani che neanche Salgari.
Siamo immediatamente trasportati dal centro storico di Roma alle selve di Mompracem, dove inevitabilmente timbri, francobolli e telegrammi scivolano via dalla nostra attenzione per lasciare il posto a tigri, coccodrilli e dayaki.
Di nuovo all’opera il guastafeste, stavolta esotico.

Museo dell’Ara Pacis: “Lucio Dalla - anche se il tempo passa”.
Qui siamo sulla nostalgia pura. Lucio era un amico che abbiamo seguito nella sua straordinaria mistura di inarrivabile autore e interprete di musiche sempre più belle e intense; e di persona fisicamente brutta, ma di intelletto così ricco e bizzarro da trasformare la sua presenza in una continua esibizione di genialità inventiva, fra parrucchini, orpelli e mascherate di ogni tipo.
Certo, a parte la memoria quando è un fatto personale, la celebrazione di un musicista fatica a riempire una mostra, anche se bella: quattro foto, due costumi di scena, l’immancabile pagella di scuola (a leggerla ci è sembrato un alunno di scarso rendimento) l’ascolto di qualche canzone e poco più.
Ecco che allora Roma guastafeste si fa viva attraverso le vetrate con l’immagine del Mausoleo di Augusto, un’affascinante rovina di pietra e alberi, che ci porta nel vuoto della campagna romana, anche se poi siamo e restiamo al centro della città.

Palazzo Braschi: “Roma Medievale”.
Rispetto a città davvero medievali come Firenze o Siena, bisogna ammettere che Roma non ha un gran che da mostrare.
Eppure, con poco materiale artistico, ma molte mappe, ricostruzioni, foto, memorie, questa esposizione riesce a tracciare un quadro di prima dell’alluvione del Barocco, soprattutto basandosi sul lato religioso della Roma dei papi, con tutta la sua pittoresca accozzaglia di nepotismo, veleni, crimini e ruberie. Ma anche vera, ingenua fede e altrettanto ingenua sua rappresentazione.
L’appartamento del palazzo offre una sontuosa ambientazione, anche se ci sentiamo in diritto di lamentare una caratteristica di quasi tutti i musei italiani: vietato sedersi! Forse è per la teoria che la cultura uno deve guadagnarsela con la fatica. Mah.
A un certo punto è inevitabile affacciarsi a una finestra su Piazza Navona. Da dove prendiamo il volo sulle ali di un altro guastafeste, quello barocco, che ci porta lontano, da tutto quello che c’era prima, medioevo compreso.
N° 545 - Fred

E’ una fantastica giornata di ottobre. Aria balsamica e sole brillante.
Il centro di Roma è un vespaio di turisti, però basta spostarsi a Prati che tutto si tranquillizza; l’aria è ancora balsamica e puzza meno di benzina, la gente è più rilassata (il mestiere di turista è duro, specialmente se devi vedere tutto in mezza giornata) e soprattutto al Magic Maxxi c’è un’interessante piccola mostra, anzi, la commemorazione di un personaggio, un duro ingenuo del nostro passato.

Prima di parlare di Fred, perché il Maxxi è Magic? Intanto perché è il giocattolo che Roma ha commissionato a una fata-architetta famosa e geniale (e le è riuscito così bene che uno fa finta di andarci a visitare le mostre, ma in realtà l’opera d’arte è l’edificio).
Poi perché delle magie le fa davvero, per esempio con quel finestrone sporgente che si intravede nella prima immagine con l’albero blu.
Noi lo abbiamo fotografato anche in una giornata d’inverno, quando nel grigio freddo dell’aria e sul grigio ancora più freddo del vetro apparivano riflesse le modeste case di abitazione fine ‘800 lì di fronte, trasformate dall’oro del sole al tramonto in castelli di fiaba. Un miraggio.

Il duro commemorato è, ovvio, Ferdinando Fred Buscaglione, che ci ha lasciati ormai da più di sessant’anni.
Naturalmente alla mostra il materiale non è tanto: qualche foto, copertine di dischi, manifesti cinematografici e in sottofondo le sue “Che bambola!”, “Eri piccola”, ma è sufficiente a farci rivivere il prima, quando le canzoni erano tutte cuori infranti e mamme preoccupate, i musicisti dei complessi tutti vestiti uguali, in giacca, papillon e possibilmente scarpe bianche, facce anonime e capelli giusti; e il dopo, quando finalmente qualcuno, lui, Fred, pensò di inventarsi un personaggio, naturalmente non ancora proprio maledetto (c’era da rispettare le abitudini e i desideri del pubblico e le paure dei discografici) ma comunque un po’ spaccone, col baffo assassino e la (finta) frequentazione della malavita.
Ma con dei pezzi intelligenti, spiritosi, scritti con Chiosso, che erano ognuno uno sketch musicato, con un tema in apertura, uno svolgimento e un finale: tutto nei due minuti e mezzo obbligati per una facciata di 45 giri.

Grande successo, come dicevamo; e finalmente basta serate a due lire, ma soldi veri, con i quali cosa ci si compra, da ex orchestrale povero, verso la fine degli anni ’50? Ma una macchinona americana, naturalmente, una Ford Thunderbird, per fargliela vedere ai colleghi che vanno ancora in giro in Topolino.

Però stavolta il finale della storia non fu uno scherzo, come le sue canzoni criminali.
Saranno state le quattro di una notte di febbraio 1960; tornava all’albergo dopo una serata, probabilmente alcolica, certo di stanchezza e confusione: bum! contro un camion carico di pietre.
Non aveva quarant’anni.


